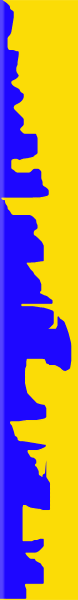C’è
un singolare contrasto fra l’accordo pressoché unanime
sulla necessità di conservare il ricordo dell’Olocausto
e la scarsa fortuna di cui gode nei nostri ordinamenti
scolastici l’insegnamento della storia – Historia
magistra vitae, si diceva un tempo: molti
secoli più tardi Vico parlerà di corsi e ricorsi, gli
idealisti di perenne contemporaneità della storia –
Comunque la si voglia interpretare, è certo che la
memoria collettiva dell’umanità va coltivata con la
massima cura
Il
27 gennaio del 1945 i primi soldati dell’Armata Rossa
arrivarono ai reticolati di Auschwitz. A quanto pare non
sapevano nulla del campo, né del mostruoso sterminio che vi
era stato praticato per anni: certo dovette sorprenderli non
poco la vista di quei gruppi di prigionieri, con le tetre
uniformi a righe svolazzanti sui corpi scheletriti, le
braccia scosse dai brividi di un freddo glaciale che
tentavano gesti di saluto, i sorrisi spettrali su quelle
facce incavate che avevano visto la morte e adesso
contemplavano la fine dell’incubo. Da qualche anno il 27
gennaio è stato consacrato in tutto il mondo quale giornata
della memoria, in particolare dedicata a quella comunità
ebraica che più di tutti i perseguitati dal nazismo –
comunisti, zingari, omosessuali, testimoni di Geova,
disabili – subì la feroce aggressione hitleriana. Al di là
delle retoriche celebrative, l’idea di istituire una
giornata della memoria è nata da una constatazione molto
semplice: il tempo si sta lentamente portando via i
superstiti dell’orrore, arriverà presto o tardi il giorno
in cui non ce ne saranno più. E anche quello in cui non ci
saranno più i loro figli, i nipoti, quelli che hanno
ascoltato dalla loro viva voce le testimonianze della vita e
della morte nei campi di concentramento e in quelli di
sterminio.
Si
attribuisce giustamente grande importanza al fatto che non
per questo l’umanità perda il ricordo vivo di quanto
accadde, attorno alla metà del ventesimo secolo, nel cuore
dell’Europa evoluta. Perché l’orrore non abbia a
ripetersi, è stato detto più volte, è necessario non
dimenticarlo. In particolare è necessario che non si perda
traccia dell’Olocausto, la Shoah, il massacro scaturito
dall’infernale disegno di cancellare dalla faccia della
terra una comunità religiosa e culturale qualificata come
“razza” e bollata come “inferiore”. Quel disegno fu
in larga misura realizzato: nella primavera del 1945, quando
finalmente la sconfitta militare del nazismo pose fine alla
strage, soltanto un terzo dei quasi dieci milioni di ebrei
d’Europa era ancora in vita. Il termine genocidio derivava
così dai fatti una spaventosa concretezza. Ricordare,
dunque, perché più non accada: quest’anno, con il
sessantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz che
dava alla ricorrenza un significato ancora più alto, è
stato proprio questo il motivo dominante delle celebrazioni.
Certo,
a coltivare la memoria restano per sempre testimonianze
letterarie, basti pensare ai libri di Primo Levi, o al Diario
di Anne Frank, o ricostruzioni cinematografiche, come Schindler’s
List o La vita è bella, o Il
pianista. Ma senza la familiarità consapevole con il
dramma, la memoria appunto, quelle opere potrebbero perdere
il loro valore di denuncia e restare soltanto bei libri, bei
film. Superare la linea sottile fra il documento e la
creazione artistica. Occorre coltivare la memoria dunque, e
del resto su questo sono tutti d’accordo, o quasi. Sono
d’accordo persino i cosiddetti revisionisti, il cui scopo
è precisamente quello di intervenire sulla memoria
alterandone i contenuti, ma non di mandarla in soffitta. A
questo punto è difficile non contrapporre questa
convinzione comune della necessità di ricordare
l’Olocausto al sostanziale disinteresse che in Italia, ma
anche in altri paesi, accompagna le tematiche
dell’insegnamento della storia. Se si ritiene non solo
opportuno ma indispensabile
non perdere memoria della Shoah, è così difficile
fare un passo avanti e sostenere che tutta la storia, nella
sua interezza, nel suo drammatico oscillare fra bene e male,
fra progresso e regressione, deve essere ben conservata nel
nostro ricordo, deve essere parte essenziale della nostra
cultura di base?
Dalla
nostra cultura di base, la storia è quasi assente. Basta
seguire uno dei tanti programmi televisivi di quiz.
L’ignoranza dei fatti storici, anche dei più
significativi e persino dei più attuali, è diffusissima,
accettata con noncurante indulgenza, e del resto seconda
soltanto a quella della geografia. Siamo un popolo
serenamente convinto che l’Iran sia un paese arabo, gli
albanesi una nazione slava, e che il Messico si trovi in
Sudamerica. Siamo del resto in buona compagnia, se è vero
che il presidente degli Stati Uniti in carica non aveva
nessuna idea di dove diavolo si trovasse il Caucaso, e che
uno dei vicepresidenti che lo hanno preceduto credeva che in
America Latina si parlasse latino. È vero che il motto
antico historia magistra vitae è forse ottimistico
quanto semplificatore, ma è proprio così azzardato
ipotizzare che certe gaffes politiche internazionali, certi
irreparabili errori di valutazione strategica siano nati
proprio da queste lacune? E che l’ignoranza della storia
possa contribuire a spiegare i corsi e i ricorsi di cui
parlava Vico? Una società che dimentica la sua storia è
come una persona che ha smarrito la memoria: non è in grado
di andare avanti. L’ignoranza del passato ostacola il suo
presente e compromette il suo futuro.
Ci
piacerebbe che la nostra scuola, riconoscendo il valore
profondo della memoria collettiva nazionale, di quella
europea, di quella dell’umanità nel suo insieme,
attribuisse ben altro ruolo all’insegnamento della storia.
Certo, è una disciplina che va coltivata con cura, che deve
aprirsi a ogni libertà interpretativa, a ogni confronto di
visioni e punti di vista. Non può ridursi a aridi elenchi
di fatti e date, non può essere limitata alla tradizionale histoire-bataille
così giustamente castigata dalla scuola storiografica
francese delle Annales. Deve guardarsi dal rischio
della soggettività, o per meglio dire della soggettività
accettata come dato oggettivo: la storia è sempre
contemporanea, dicevano gli idealisti, ma non bisogna
rassegnarsi a questo limite. Deve semplicemente preoccuparsi
di fissare le nostre coordinate nel tempo, così come alla
geografia tocca il compito di fissare le coordinate nello
spazio. Un minimo di coordinate essenziali per i piccoli
della primaria, una rete più fittamente articolata per i
ragazzi della secondaria. In modo che dalla scuola possano
uscire persone in grado di orientarsi nel fluire delle idee,
nel percorso esistenziale del genere umano, capaci al tempo
stesso di applicare alle singole tappe di quel percorso una
propria intelligenza interpretativa. Persone libere e
coscienti che sappiano guardare in faccia la Shoah, e anche
tutto il resto.
-
Alfredo Venturi
-
|