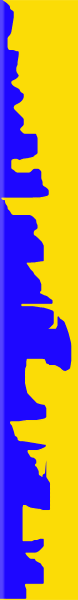I
ricordi di una donna che visse bambina a stretto contatto
con un penitenziario – Trovava inaccettabile il
trattamento cui erano sottoposti i detenuti e per questo
li aiutava: per esempio impiegando i suoi risparmi per
regalare sigarette, o accettando di imbucare lettere
aggirando la censura – Dalla sua esperienza ha tratto
una morale: il carcere è una risposta impropria alla
delinquenza, frutto avvelenato di una società incapace di
capire, di vedere, di aiutare, di amare
Sorridono
gli occhi piccoli vivacissimi di questa bambina di più di
settanta anni. La guardo e mentre racconta è proprio lei
quella piccola Anna dal cuore grande, più grande di
quell’enorme carcere a Porto Azzurro nell’isola
d’Elba. Mi spiega che il suo cognome, Postiglione, è
retaggio di una dinastia di operatori della posta: il nonno,
poi il padre, addetti all’ufficio postale del carcere. E
c’era un asino “che era il mio migliore amico,
mangiavamo insieme i torsi del cavolo, quando riposava io
andavo a fargli compagnia, mio padre aveva bisogno di
lui”.
“Quando andavo a scuola vedevo passare tanti uomini
incatenati ed altri che li trattavano male, ed io cominciai
a chiedermi il perché degli uni e degli altri. Mi chiedevo
perché a differenza dagli altri bambini quando tornavo a
casa dovevo aspettare che una guardia mi aprisse un
cancellone enorme e poi lo richiudesse dietro di me…
Eravamo sei figli con i genitori e i nonni, ci aiutavamo, si
cercavano delle affinità ma io ero diversa, cominciai a
fare il doppio gioco e avevo un mondo mio privato. Ero
sensibile come una carta assorbente, ogni cosa che vedevo
poi dovevo elaborarla, e scrivevo appuntando ogni cosa. Il
doppio gioco era nel senso che dentro di me c’era
l’adulto accanto alla piccolina”.
“A scuola è stato un tormento perché in prima
elementare mentre gli altri facevano le aste io leggevo già
i libri e la maestra non capiva. Vivevo in una realtà che
nessuno di loro conosceva: era il mio segreto. Come quei
piccoli grandi favori che facevo ai detenuti, comprare loro
le sigarette, un giornale, delle cartoline con i miei
risparmi, anche se erano tempi duri per la famiglia. O
spedire una lettera senza che passasse la censura…”.
Piccolo angelo dai riccioli rossi, la conoscevano
tutti, anche chi non l’aveva mai vista. “Un giorno,
mentre tornavo a casa su per la collina, vidi un uomo che
scendeva con le valigie in mano, chiaramente era qualcuno
che aveva finito di scontare la pena e nel vedermi salire
verso quel luogo mi chiese perché andavo lì e come mi
chiamavo. Appena udì il mio nome posò le valigie per terra
e mi abbracciò”.
Anna racconta che nell’isola il rapporto con i
detenuti era una realtà quotidiana. C’erano il fornaio,
il fabbro, i cuochi, tutte persone che per buona condotta
vivevano quasi liberamente, sia pure sempre sotto il
controllo delle guardie. C’era il bibliotecario che le
passava di nascosto i libri e c’era anche un distinto
professore di latino, era dentro perché aveva ucciso la
moglie scoperta con l’amante. “Tutte persone che mi
avevano vista crescere, perché allora gli ergastolani
stavano dentro almeno trent’anni. Non c’era proprio
confidenza, ma un legame fittizio per sopravvivere. Per me
era la possibilità di dare una mano. Per una bambina era
come un mondo proibito, ho sempre visto i miei genitori
chiudere la sera il grosso portone e la porta di casa con il
chiavistello, allora io mi chiedevo chi doveva venire per
vivere così barricati. Crescendo facevo le mie indagini per
capire la vita, e leggevo moltissimo: Tolstoj, Victor Hugo”.
“Quando veniva il giorno dei morti e andavamo al
cimitero chiedevo a mia mamma perché c’era un campo con
delle sepolture segnate soltanto da un sasso, senza un
fiore, un niente: quelle erano le tombe dei detenuti,
l’immagine di quello scarno cimitero mi è rimasta per
sempre impressa. Per questo poi facevo chilometri per
imbucare una lettera o prendere delle sigarette, per aiutare
chi aveva una pena da scontare, senza infierire come
facevano le guardie. Era il mio senso della giustizia e del
resto quante volte durante l’occupazione tedesca furono
proprio gli stessi detenuti addetti al panificio che di
nascosto ci passavano delle pagnotte: sapevano che eravamo
sei fratelli e che la fame si faceva sentire”.
“Piano piano cominciai a capire il perché di quel
luogo, di quella sofferenza, leggevo la storia, la
filosofia: avevo scatole di perché, era il mio mondo
segreto. Cominciai a capire che cos’era un governo, che
dovrebbe fare coma una madre di famiglia e purtroppo non era
all’altezza di gestire questo malessere: c’era un vuoto,
un vuoto enorme e dicevo a me stessa che avrei dovuto fare
qualcosa. Non bisogna sottovalutare i bambini, perché
capiscono moltissimo, e soffrono. Penso che i detenuti di un
tempo erano diversi da quelli di oggi, così cinici, così
spietati, Ricordo i giocattoli bellissimi che mi facevano
con mollica e acqua, il poi li regalavo agli altri
bambini”.
Le chiedo che idea si sia fatta della carcerazione, se
creda alla possibilità di alternative. Anna risponde così:
“credo all’educazione, alla cultura, al rispetto,
all’amore, queste cose possono impedire che si verifichino
certe situazioni. Credo al dialogo, alla dignità,m che deve
essere sempre salvata in un essere umano fino all’ultimo
giorno di vita. Il carcere è una punizione ridicola. La
delinquenza esplode dalle situazioni sociali problematiche:
sono quelle che andrebbero curate a livello governativo, se
il governo si comportasse come una mamma. Il lavoro può
essere una buona soluzione, sotto guida e sorveglianza, ma
non in carcere. Perché l’uomo non nasce delinquente ma lo
diventa, è quello che ho scoperto crescendo. Perché questa
è una società che non sa capire, non sa vedere, non sa
aiutare, non sa amare”.
Marilena Farruggia
-
|