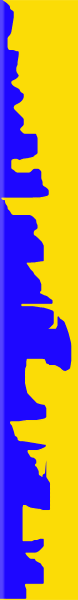Nei
ricordi e nelle riflessioni di un maestro sardo, poi
passato al ruolo di direttore didattico, la questione del
“monopolio” femminile nell’insegnamento elementare
– Più indietro, la memoria di una scuola in cui ancora
si punivano i bambini facendoli inginocchiare sulla
ghiaia, accanto alla cattedra riscaldata da un braciere di
carbone – I pochi maestri impegnati a nuotare
controcorrente in una marea di maestre – Com’è
difficile far coesistere la necessità
dell’aggiornamento con l’alibi dell’esperienza
Le donne sono la realtà più bella della nostra vita:
e più ce n’è meglio è. Ma non nella scuola. Chi scrive
ha avuto tre osservatori privilegiati per poterlo
constatare: l’età scolare e i due periodi della sua vita
trascorsi tra i banchi come maestro elementare e come
direttore didattico.
Ha
fatto le elementari in un periodo in cui si vedevano pochi
supplenti: l’insegnante che avevi ti durava almeno un
anno, senza perdere dei mesi scolastici neppure un giorno,
perché non c’era malattia che potesse allontanare queste
missionarie dell’abc dalla loro cattedra in legno liso con
sotto, in inverno, un braciere di carbone vivido e
croccante. Cinque anni, cinque maestre. Puntualissime
maestre che si chinavano sugli scolari alternando un sorriso
a una carezza. Se eri buono. Se eri cattivo, anche solo
monello, c’erano piccole scaglie di ghiaia raccolte dal
condannato stesso nello stradone (l’asfalto dalle sue
parti a quel tempo era di là da venire), da mettere sotto
le ginocchia, genuflesse dietro la lavagna. E con quale
sorridente perfidia, tutta muliebre, le missionarie della
bacchetta, sistemavano con le proprie mani le pietruzze
sotto le rotule dei piccoli di uomo in calzoni corti!
A chi scrive questa sorte non toccò mai perché era
buono e bello, anche se nero dal sole come una bacca matura
d’olivastro. Pare che lo fosse, bello, almeno quanto
adesso è brutto. O quasi. Le coccole non riuscirono a
rovinarlo perché aveva un padre buono come il pane: ma rude
come il pane stesso, quando dopo una settimana diventa duro.
Un po’ soldato d’oltremare e un po’ contadino
restituito alla terra, per dimostrare al figlio il suo
affetto gli dava uno scappellotto ventoso che gli
scompigliava i capelli e gli faceva chiudere gli occhi. A
scuola, saturo delle attenzioni melense e spersonalizzanti
delle maestre, sentiva vera nostalgia di quella rude
carezza. Altri compagni non ebbero la stessa fortuna.
Da maestro fu ancora più dura. Bisognava convivere,
lui e altri cinque malcapitati maestri, con cinquantadue
maestre. Tante ce n’erano nel caseggiato scolastico
dov’era arrivato dopo una lunga peregrinazione per gli
stazzi della Gallura, costellati di scuolette nuove e da
maestrine in continuo pianto di nostalgia, consolate
appiccicosamente da alunni e alunne, piagnucolanti anche
loro per contagio, che avevano capito quanto fosse più
facile improvvisarsi un ruolo da consolatori che quello di
studenti volenterosi. A volte era qualcuno più grande, che
arrivava a gatta morta e piano piano riusciva a far
dimenticare alle maestrine le loro città lontane con
altrettanto lontani famigliari, fidanzati e qualche marito.
Era sempre meglio di avere a che fare con quelle del
caseggiato cittadino.
È difficile dimenticare i pittoreschi collegi dei
docenti che iniziavano sempre in ritardo per aspettare le
ritardatarie. Arrivavano trafelate portandosi appresso aloni
di odorose colazioni imbastite in fretta prima di uscire da
casa per i figli più piccoli. Collegi finiti sempre un
po’ prima dell’orario prefissato per sconfiggere il
tempo di chiusura dei market dove si poteva trovare, senza
correre di negozio in negozio, pane, carne, verdure e altri
articoli di sopravvivenza domestica.
Scolaresche ridotte al silenzio a suon di “bravi”
per i prediletti e “asinoni” per i meno dotati, venivano
allineate, un quarto d’ora prima che suonasse la campana
dell’uscita, dietro la porta chiusa della classe, per
schizzare via nei corridori al primo trillo. I cinque
maestri lasciavano le aule per ultimi e raggiungevano piano
piano l’uscita chiacchierando con alunni seri e
interessati cui veniva dato sempre il tempo di chiarire
l’ultimo argomento trattato.
Ma l’esperienza più significativa, il maestro la
visse quando, con regolare laurea e concorso di stato,
diventò direttore. Contento di andar via dal suo caseggiato
per avere a che fare con altra gente e respirare un’altra
aria, si trovò di colpo a dirigere le scuole di un paese né
vicino né lontano, con l’aggiunta di una corona di
“reggenze” che lo rese padrone delle scuole di una
diecina di paesi con annesse campagne.
Una marea di maestre di ogni età (all’interno della
quale nuotavano controcorrente, ma positivamente dieci
maestri, la cui azione doveva rivelarsi alla fine
risolutiva) oppose ai consigli del neo direttore, a
proposito della necessità di un continuo aggiornamento, di
un rapporto affettuoso con gli alunni, ma serio e
costruttivo, inteso come volontà di bene, la loro
autoconferita “esperienza ”, stella polare ferma e
immutabile, buona da seguire in ogni temperie.
Questo dell’esperienza è un triste nodo impossibile
da sciogliere. Credersi “sperimentate” è proprio una
convinzione al femminile: ed è deleteria nei confronti dei
piccoli proprio perché essi capiscono, strano per chi non
li conosce profondamente, ma vero, che l’insegnante si
dichiara “ sperimentato ” soprattutto per paura di
affrontare nuove formule educative, nuovi problemi da
risolvere in altri modi al di là da quello imposto da
regole refrattarie a qualsiasi ipotesi fallibilista.
Non sono solo questi i pericoli di una scuola troppo
femminilizzata. Soprattutto nella contingenza storica che
stiamo attraversando in questi anni: così fragile e
delicata per una inspiegabile poca attenzione nei confronti
dei piccoli di uomo. Ma questo convincimento, fregiato
anch’esso dal crisma della fallibilità, potrà offrire lo
spunto per ulteriori considerazioni.
Franco
Fresi
|