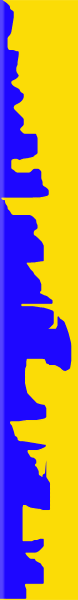In
certe proposte di riforma del sistema educativo è
visibile una trasparente nostalgia dei tempi andati –
C’è chi suggerisce il ritorno alle classi separate fra
ragazzi e ragazze, chi addirittura una sorta di apartheid
per gli alunni stranieri – Si fa strada persino l’homeschooling,
ormai largamente praticato in America – Questi scenari
sono in realtà restaurazioni di formule storicamente
superate, e nascondono l’incapacità di vedere nella
scuola il crogiolo della società
A
voler parafrasare il poeta c’è qualcosa di nuovo, anzi
d’antico in molte discussioni attorno alla scuola. Si
propongono a volte innovazioni che sono nient’altro che
restaurazioni, ritorni al passato, anche se magari poggiano
su accurate documentazioni scientifiche. Per esempio
l’idea, elaborata negli Stati Uniti e prontamente
rimbalzata in Europa, che il sistema delle classi miste
penalizza un po’ tutti, e che separando ragazzi e ragazze
si otterrebbero risultati didatticamente migliori. Poiché
non sarebbero soltanto i caratteri sessuali primari e
secondari a differenziare i due gruppi, ma anche cervelli
diversamente organizzati di fronte alla sfida
dell’apprendimento, ecco la soluzione ideale: classi di
soli maschi, classi di sole femmine.
Ecco
finalmente l’insegnamento orientato a sviluppare la
capacità maschile di sintesi e la propensione femminile
all’analisi, ecco i ragazzi che non reagiscono più con
comportamenti aggressivi al confronto con compagne più
brave, ecco le ragazze che possono dedicarsi senza complessi
d’inferiorità alla matematica, incuranti del fatto che i
loro compagni sono meglio portati al calcolo. In America,
dove si è provato a dividere sperimentalmente alcune prime
classi elementari in base al sesso, si è scoperto che
grandi miglioramenti derivano dal permettere per esempio ai
bambini di muoversi più liberamente in aula, alle bambine
di poter periodicamente chiacchierare fra loro.
Sempre
negli Stati Uniti viene proposta un’altra possibile
separazione volta a ottenere un migliore rendimento
scolastico complessivo: questa volta non in base al sesso ma
all’etnia. C’è molto paternalismo in questa ipotesi, ma
anche qualcosa di meno presentabile su cui è meglio
sorvolare. L’argomentazione è apparentemente
ineccepibile: poiché mediamente i piccoli neri o ispanici
fanno registrare risultati inferiori a quelli dei loro
compagni bianchi o asiatici, perché non separare i
percorsi? Perché non adeguare i modi e i ritmi
dell’insegnamento a condizioni così diverse, uniformando
le classi a seconda dell’appartenenza etnica? Già, perché.
Questa
proposta americana è stata in un certo senso ripresa anche
in Italia, dove di fronte a un sistema scolastico sempre più
massicciamente interculturale è scaturito un suggerimento
che apparentemente non fa una grinza: classi apposite nei
primi anni di scuola per i piccoli stranieri, che in questo
modo potranno più facilmente impadronirsi della lingua e
non patire più il confronto con i più agguerriti compagni
italiani. La generosità dell’offerta risulta decisamente
attenuata se si pensa che la parte politica da cui proviene
è la stessa che non perde occasione per attaccare la
crescente presenza straniera, cavalcando demagogicamente la
paura del terrorismo e l’insofferenza per una criminalità
che molto spesso parla l’italiano stentato degli
immigrati.
Che
dire di queste proposte? Prima di tutto non vogliamo entrare
nel merito didattico. Può darsi benissimo che il rendimento
didattico venga positivamente influenzato dal costruire
gruppi omogenei separando i ragazzi dalle ragazze, i neri
dai bianchi, gli albanesi dagli italiani. Ma non è questo
il punto, o almeno non è soltanto questo. Infatti lo scopo
della scuola non può ridursi a inseguire statistiche di
rendimento, per quanto importanti. In altre parole la scuola
non deve fornire soltanto istruzione, ma anche educazione.
Soprattutto educazione. Per questo non può esimersi dal
proporre un modello di riferimento dell’universo sociale,
deve insomma riprodurre dentro se stessa la società.
Ovviamente la riproduce soltanto se non viene organizzata in
forme separate, visto che la società è multiforme, fatta
com’è di uomini e donne, di etnie e provenienze culturali
diverse.
Del
resto la separazione viene spesso propugnata sulla base di
elementi patologici della società, o almeno di lacune che
vanno colmate. Se i piccoli immigrati che vivono da noi non
parlano italiano, andrebbero messi in condizione di farlo
prima della scuola, non rinchiudendoli in ghetti scolastici.
Se sono appena arrivati, l’insegnamento intensivo della
lingua dovrebbe essere impartito parallelamente alla normale
attività scolastica. Nel caso della discriminazione etnica
proposta in America, che senso avrebbe dividere le classi
sulla base di rendimenti statisticamente diversi che
risentono, evidentemente, della rispettiva collocazione
sociale dei gruppi? Se gli afroamericani sono mediamente
meno bravi dei loro compagni wasp, non è perché
sono neri, ma perché sono mediamente più poveri, e le loro
famiglie sono mediamente meno acculturate. La scuola deve
contribuire a colmare questi fossati, non considerarli
semplici dati di fatto su cui fondare la sua organizzazione.
Non può permettersi di fare cortocircuito con la società.
Una
classe di soli bianchi rischia di produrre un gruppo di
cittadini per i quali la componente nera della società è
ridotta a qualcosa di estraneo e lontano: di qui
all’ostilità interetnica il passo è brevissimo. Da una
classe di soli maschi potrebbero uscire uomini portati a
considerare l’universo femminile come qualcosa di ben
differente dall’altra metà del cielo: e così,
parallelamente, da una classe di sole femmine potrebbe
scaturire una visione distorta del mondo virile. Se poi
separiamo i nostri figli dai compagni stranieri, che
rapporto avranno con la società interculturale? C’è
insomma la prospettiva concreta che da quelle esperienze
escano rispettivamente rafforzati il razzismo, il
maschilismo, la xenofobia. Sullo sfondo di una società
frammentata e internamente segnata dall’incomunicabilità.
C’è
poi una forma estrema di separatismo scolastico, già
abbastanza largamente praticata in America e che anche da
noi si va facendo strada almeno sul piano teorico. Si tratta
dell’homeschooling, come la chiamano dall’altra parte
dell’Atlantico. La scuola è quella che è, densa di
problemi, malesseri, disagi? Ebbene, educhiamoli a casa i
nostri figli, riducendo le necessità formali di
riconoscimento dei curricula a una serie di esami pubblici.
Anche questo è un ritorno al passato più remoto,
all’istruzione riservata a quei pochi che se la potevano
permettere, e non basta certo a renderlo accettabile un
vantaggio rispetto ai tempi andati che pur bisogna
riconoscere: l’accesso diretto ai più vari contenuti e a
nuovi orizzonti comunicativi consentito dalle tecnologie
informatiche.
È
probabile che anche così si possano ottenere buoni
risultati in termini di rendimento, almeno in singoli casi.
Già, ma che tipo di individuo uscirebbe da questa sorta di
scuola destrutturata a domicilio? Privo dell’esperienza
formativa del gruppo scolastico, digiuno di attività
collettive e di lavoro di squadra, ignaro dello stimolo
competitivo implicito nello studiare a fianco a fianco con
altri, senza ricordi di classe né compagni di scuola, non
rischierebbe forse di essere un asociale? Non è di per sé
asociale, rifiutare quel crogiolo della società che è, di
fatto, la scuola?
Alfredo
Venturi
|