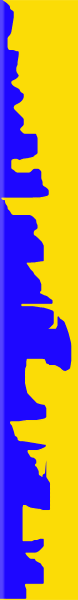Si
chiamava Anthony e veniva da un villaggio indiano –
Adottato da una famiglia italiana all’età di otto anni,
è vissuto per altri otto a Firenze – Alla fine non ce
l’ha più fatta: si sentiva diverso, incompreso,
sbeffeggiato per quella sua pelle scura – Dieci giorni
prima di uccidersi ha scritto una lettera in cui si scusa
con i genitori adottivi, accusa la società e prima di
tutto la scuola e avverte: il mondo sarà pacifico solo se
risolverà la questione multietnica
“Mi piaceva
andare a scuola ma nessuno mi apprezzava, e la vita è
tornata ad essere infernale come quando ero nel mio
paese”. “Quando sono entrato alle superiori pensavo che
questi anni li avrei passati più serenamente di quelli che
avevo trascorso alle medie. Invece non ho trovato altro che
solitudine, tristezza e tanti brutti voti”. Vita
infernale, solitudine, tristezza: è il bilancio tracciato
da un ragazzo di sedici anni che ha deciso di farla finita.
Si chiamava Anthony, frequentava la prima classe di un
istituto tecnico agrario e veniva dall’India. Otto anni fa
aveva lasciato il paese asiatico, adottato da una famiglia
italiana che vive a Firenze. Nella sua lettera di addio,
Anthony ha parole di grande affetto per i genitori adottivi,
con i quali si scusa per l’atroce decisione: “quando
rientravo a casa ero il ragazzo più felice del mondo…”
Ma subito fuori, l’inferno: “ogni volta che uscivo di
casa la gente non faceva altro che insultarmi per il colore
della mia pelle e mi sentivo un verme”.
Quando
il ragazzo venne in Italia, si lasciava alle spalle
un’infanzia fatta di miseria e privazioni. L’adozione lo
aveva improvvisamente proiettato in un mondo di benessere,
nel calore di una famiglia, in un ambiente sociale che gli
garantiva un avvenire attraverso l’assistenza e
l’istruzione. Già, l’istruzione. E’ difficile
rileggere senza un brivido le parole di Anthony a proposito
della scuola e delle proprie brucianti delusioni.
Immaginiamoci quel ragazzino dalla pelle scura seduto al suo
banco, quello stesso che dopo il suicidio i compagni hanno
ricoperto di fiori, con in testa un terribile passato
infantile e un grandissimo bisogno di amicizia,
considerazione, affetto. Ora veniamo a sapere che più volte
aveva parlato di suicidio ma nessuno lo aveva preso sul
serio. Ma va’, tu vedi troppi film, così rispondevano ai
suoi sfoghi. Perché evidentemente il suo male di vivere non
era così evidente, era nascosto dentro, nelle pieghe di
un’identità che non riusciva, ostacolata dall’ambiente
ostile, a uscire dal bozzolo. Nel contrasto irrisolto fra
un’infanzia asiatica povera di cibo e un’adolescenza
europea povera di stima e di autostima. Diceva sul serio,
purtroppo: Anthony si è ucciso davvero, un giorno di questa
fredda primavera, stringendosi un cappio intorno al collo.
Dicono
che poche settimane prima della morte, durante una gita
scolastica a Urbino, Anthony si era divertito, aveva riso e
scherzato con gli altri. C’era stato, è vero, un
incidente all’inizio dell’anno. Un compagno aveva alluso
al colore della sua pelle, e lui aveva reagito
avventandoglisi contro. Poi c’era stata un’assemblea di
classe per analizzare il caso e tutto era andato a posto:
era solo una battuta e non m’importa delle battute, aveva
detto. Nella sua ultima lettera, il ragazzo indiano allude a
un insegnante troppo severo con lui. Il preside ci fa sapere
che Anthony non andava poi così male, aveva qualche cinque
ma si trattava di lacune facilmente colmabili. Ma forse,
questa è una nostra ipotesi, lui sentiva la necessità di
risultati più che buoni: per compensare il disagio, per
riscattare quello che sentiva forse come un vizio
d’origine indelebilmente impresso nel suo corpo. Infatti
compagni e insegnanti ci dicono che pur essendo un tipo
abbastanza estroverso non voleva assolutamente parlare
dell’India, né delle esperienze infantili.
La
lettera di Anthony ce lo mostra capace di esprimersi
efficacemente e ben dotato sul piano intellettuale per i
suoi sedici anni: nonostante il trauma del trapianto e forse
in parte proprio per questo. Si interessava ai problemi
della concordia fra i popoli: per esempio partecipando al
progetto Coltiviamo la pace, che si propone di incoraggiare
all’ombra degli ulivi toscani l’amicizia fra ragazzi
israeliani e palestinesi. Si interessava anche a una grande
questione nazionale di cui era parte in causa, quella degli
immigrati, e nella sua lettera c’è un appello al
presidente del consiglio che il destinatario farebbe bene a
non trascurare: “voglio dire al presidente Berlusconi che
il mondo potrà diventare pacifico se diventerà multietnico”.
Per “mondo multietnico” intendeva probabilmente un
ambiente sociale in cui nessuno viene irriso perché la sua
pelle ha un colore inconsueto. Il suo era un invito alla
concordia, alla tolleranza.
Sarebbe
retorico dire che questa morte dovrebbe almeno servire a
qualcosa, nell’epoca delle isterie xenofobe alimentate, ma
non certo giustificate, da cronache fiammeggianti di guerra
e di odio. Retorico e iniquo, perché il viaggio senza
ritorno scelto da Anthony chiude per sempre la sua tragedia
personale. Eppure la fine di questo ragazzo che non siamo
stati capaci di integrare nel nostro mondo ci impone una
volta ancora di prendere molto sul serio i problemi connessi
con le adozioni e le immigrazioni, e il cortocircuito fra
culture distanti che spesso ne consegue. Dobbiamo prenderli
sul serio soprattutto nella scuola, che dovrebbe essere il
luogo per eccellenza dell’integrazione. Quanto a Anthony,
il meno che possiamo fare è cooptarlo fra i morti che ci
appartengono, offrendo al suo povero ricordo il fiore di una
consapevolezza responsabile.
Alfredo Venturi
|