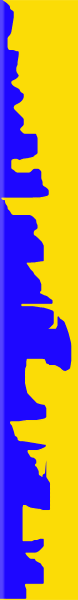Non
bastano le buone intenzioni per guarire i mali immensi del
continente, né serve a molto una politica di aiuti in
bilico fra assistenza caritativa e disordine
organizzativo, e per di più indebolita da egoismi
nazionali e bilanci asfittici – Sono del tutto inutili
quegli sforzi che ignorano l’esigenza fondamentale dello
sviluppo – Bisogna puntare sulle priorità vere:
costruire scuole invece che mandare armi, rilanciare
l’agricoltura invece che regalare cibo
Hic
sunt leones, stava scritto una volta sulle carte
dell’Africa: qui stanno i leoni. Con la sola eccezione
della parte settentrionale affacciata sul Mediterraneo e
della valle del Nilo, del continente si conoscevano soltanto
le coste e una fascia più o meno ampia a ridosso del mare.
Il resto era leggenda, misteriose profondità dalle quali
emergevano avorio e schiavi: era il cuore di tenebra, la
terra dei leoni. Poi l’esplorazione permise di conoscere
l’immensità di quel pezzo di mondo, i suoi fiumi, i
deserti e le foreste, la sua umanità varia e vitale. Ancora
pochi decenni, e in lontane capitali europee ecco i
diplomatici all’opera per farsi a fette l’immenso
territorio. E così comparvero carte finalmente dettagliate
con le loro grandi macchie di colore: rosa le colonie di sua
maestà britannica, violacei i possedimenti francesi, verdi
quelli italiani. Poi arrivò la decolonizzazione: culminata
all’inizio degli anni Sessanta del secolo scorso
nell’indipendenza di una ventina di paesi e conclusa, a
metà dei Settanta, con la libertà tardivamente restituita
a quello che fu l’impero portoghese.
Oggi
la rappresentazione cartografica del continente offre un
fitto reticolo di frontiere che dividono alcune decine di
stati. Sono gli stessi confini che avevano tracciato le
potenze coloniali, tagliando spesso popolazioni omogenee
perché obbedivano a criteri ben diversi da quello etnico,
criteri di ordine strategico o economico, perfino capricci
di corte. La frontiera fra Kenya e Tanzania, una linea con
andamento sudest-nordovest, a un certo punto volta
bruscamente, per includere il monte Kilimangiaro in
territorio tanzaniano: fu una rettifica, un grazioso dono
della regina Victoria a suo nipote, il Kaiser Guglielmo II,
che aspirava a veder troneggiare nei suoi possedimenti
africani una vetta oltre i cinquemila metri. Il Kenya era
infatti britannico, l’allora Tanganyika germanico: anche
se i nomadi Masai che percorrevano le terre divise dal
confine, sudditi a volte di Londra a volte di Berlino, erano
ben lontani dal concepire simili diavolerie geopolitiche.
Altra bizzarra creazione delle cancellerie europee la
striscia di Caprivi, che impedendo il contatto del Botswana
con l’Angola e la Zambia prolunga fino allo Zimbabwe il
territorio della Namibia. Prende il nome dal Reichskanzler
Leo von Caprivi, il successore di Bismarck, che voleva
garantire al possedimento tedesco dell’Africa di Sudovest
(nome coloniale della Namibia) l’accesso alle acque dello
Zambesi.
All’interno
di queste frontiere artificiali i paesi africani combattono
la loro ardua battaglia per lo sviluppo. Bisogna dire che a
mezzo secolo dalla decolonizzazione il bilancio non potrebbe
essere più deludente, né in più netto contrasto con gli
entusiasmi sollevati a suo tempo dall’affacciarsi dei
nuovi stati sovrani sulla ribalta internazionale. Il solo
barlume di luce è rappresentato dalle speranze suscitate
dall’Unione africana e dai suoi propositi di una sempre più
stretta integrazione: ma anche questo è un cammino
accidentato, irto di ostacoli, frenato da difficoltà
oggettive e egoismi nazionali. Nell’attesa dei tempi
migliori che può suggerire una buona dose di ottimismo
della volontà, il quadro dell’oggi è spaventoso.
Cominciamo con il dato che più interessa i lettori di
questo nostro periodico, quello che si riferisce alla
scuola. Ebbene, nel continente abitato da mezzo miliardo di
persone sono centoventi milioni i bambini e ragazzi in età
scolare privati dell’istruzione. La condizione
dell’infanzia è allarmante anche da altri punti di vista:
per esempio sono quattordici milioni i bambini ai quali
l’Aids ha strappato uno o entrambi i genitori.
Vogliamo
completare il quadro? È persino difficile inserirlo in una
dimensione intercontinentale: infatti dei trenta paesi che
guidano la drammatica graduatoria internazionale della
mortalità infantile, ventotto sono africani (le due
eccezioni si chiamano Cambogia e Afghanistan). E ancora: la
parte subsahariana del continente, l’Africa nera insomma,
presenta la tragica singolarità di essere l’unica regione
del mondo in cui negli ultimi decenni la speranza media di
vita si è accorciata invece che allungarsi. E poi le guerre
e le guerriglie, nonostante gli sforzi dell’Unione
africana se ne contano una quindicina e hanno fatto milioni
di morti, soprattutto nel Congo e nel Ruanda, alimentando i
lucrosi commerci dei mercanti di armi.
Esiste
un terzomondismo militante che tende a scaricare
sull’Occidente ogni colpa del disastro. Con analisi così
approssimative non si fa molta strada. Certo l’Occidente
ha le sue colpe e non sono poche, ma non bastano a fornire
una corretta chiave di lettura. La tratta degli schiavi non
fu soltanto occidentale, e a vendere la merce umana erano i
capi delle etnie africane. Lo stesso colonialismo non fu
soltanto brutale conquista ma s’intrecciò spesso con
lotte di potere locali. La corruzione che corrode le
economie del continente non si può definire una piaga
esclusivamente esogena. Autentiche responsabilità furono
invece l’assalto alle identità culturali (anche
attraverso il proselitismo missionario) e lo sfruttamento
economico fondato spesso su pratiche predatorie. Come le
monocolture di prodotti di pregio (cacao, caffè, cotone,
arachidi) che distrussero l’agricoltura di sussistenza.
Una volta si coltivava la terra per ricavarne cibo destinato
a tutti, non denaro riservato a pochi. Un errore analogo lo
si sta compiendo oggi attraverso la politica degli aiuti.
Nel continente assediato dalla fame arrivano carichi di
cibo, che fra l’altro servono a smaltire le nostre
eccedenze agricole, ma al di là della necessità
contingente questa pratica è controproducente, fa infatti
diminuire la propensione al lavoro e svaluta i risultati
della fatica. Che bisogno c’è di piegarsi nei campi se
prima o poi arrivano navi e aerei carichi di grano?
Bisognerebbe
invece investire sull’agricoltura, aiutare gli africani a
frenare la spinta all’urbanesimo, che è insieme
conseguenza e causa della progressiva desertificazione del
continente, trasforma le città in desolate megalopoli
popolate di gente senza lavoro, moltiplica nei formicai
urbani le insidie sanitarie. La malnutrizione, la malaria,
la tubercolosi sono fra le più frequenti cause di morte. E
soprattutto l’aids, che in certi paesi ha svuotato di
personale gli uffici, i servizi, le scuole. Anche in materia
sanitaria l’enfasi dovrebbe essere posta non tanto
sull’invio di farmaci (che pure sono necessari
nell’emergenza) quanto sulla creazione di strutture
stabili, sulla formazione di medici e infermieri, sulla
diffusione delle informazioni necessarie alla prevenzione.
Lasciando perdere certi paralizzanti pregiudizi ideologici o
religiosi: per esempio l’aids può e deve essere
combattuto diffondendo l’uso di profilattici, anche se si
tratta al tempo stesso di strumenti anticoncezionali
sgraditi agli integralisti delle varie fedi.
La
comunità internazionale ha indicato da tempo un obiettivo
per affrontare i problemi dello sviluppo in Africa e
altrove: destinare alla cooperazione lo 0,7 per cento della
ricchezza prodotta. Purtroppo ne siamo lontanissimi:
attualmente la media fra i paesi donatori non raggiunge lo
0,25 per cento. In tutto fanno 56 miliardi di dollari
all’anno: la cifra è imponente ma è circa la metà di
quanto servirebbe, secondo la Banca mondiale, per finanziare
i progetti in corso. Pochi giorni or sono è stata
annunciata la cancellazione di una parte della montagna di
debiti che i paesi poveri hanno accumulato nei confronti dei
ricchi: gran bella cosa, ma i suoi effetti concreti sono
limitati a quei casi in cui la restituzione del dovuto era
di fatto iscritta nei bilanci. In molti altri paesi quei
debiti erano già stati cancellati, in pratica,
dall’evidente impossibilità di rimborsarli.
L’Africa
ha ricevuto nel 2004 aiuti per circa diciassette miliardi di
dollari, ma in buona parte sono stati assorbiti dai costi di
funzionamento delle agenzie internazionali, mentre
un’altra parte si è perduta nei meandri della corruzione.
Inoltre gli aiuti sono spesso condizionati da clausole che
rispecchiano interessi nazionali: per esempio si offre di
finanziare la costruzione di una diga o di una fabbrica, a
patto che a realizzarla siano imprese del paese donatore.
Ovviamente non sono quasi mai quelle che offrono le
condizioni migliori. È necessario mettere ordine in tutto
questo, coordinare interventi più efficaci e
disinteressati. Bisogna che ci abituiamo, noi gente
dell’Europa e dell’Occidente, a sentirci direttamente
coinvolti nella grande questione africana. Se qualcuno non
si sentisse abbastanza motivato da un dovere elementare di
solidarietà umana, possiamo ricordargli che sono in gioco
anche i suoi interessi: vogliamo o non vogliamo attenuare,
se non rimuovere, le ragioni che spingono alla fuga milioni
di persone, esuli obbligati dalla miseria che bussano alle
nostre porte? Invece di abbandonarci a vani piagnistei
terzomondisti dobbiamo calarci nel concreto: per esempio
favorendo un massiccio programma di investimenti
nell’istruzione, capaci di creare generazioni in grado di
raccogliere la sfida. Infatti se si fanno le scuole, il
resto prima o poi verrà da sé.
Alfredo
Venturi
|