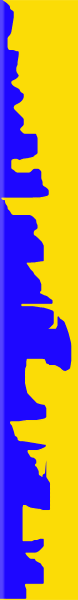|
Alla
fine degli anni cinquanta la Giustizia minorile fu affidata
ad un pedagogista che sarebbe stato fondamentale per molte
delle situazioni che si sarebbero verificate negli anni a
venire: Umberto Radaelli. Erano tempi difficili. Il fenomeno
della dissocialità giovanile sembrava diffondersi sotto
molte forme. Le borgate romane, già sotto l’occhio
attento di Pier Paolo Pasolini, i quartieri spagnoli a
Napoli, la Vucciria a Palermo: tre esemplificazioni di un
malessere che aveva (e continua ad avere) radici nella
povertà delle risorse, ma che soprattutto sembrava voler
dividere il Paese in due. Quello della ripresa economica,
alle soglie del boom e quello che, a tutti sembrava
convenire, rimanesse nelle stesse condizioni del secondo
dopoguerra.
I
tempi non erano difficili solo per le ragioni sociali cui si
è fatto cenno. Si stava appena uscendo dall’incubo del
Governo Tambroni e da tutto ciò che di negativo aveva
prodotto (compreso un tentativo, ormai antistorico, di
reprimere le proteste operaie con le cariche a cavallo dei
carabinieri). Troppe le similitudini, come avviene da alcuni
decenni, con la storia americana. Noi Tambroni, loro il
senatore Mc Carthy, entrambi ossessionati dal pericolo
comunista. Noi con “i ragazzi di vita”, loro con “una
gioventù bruciata”. Noi Bertolini con la sua “pedagogia
per i ragazzi difficili” (1965), loro con Albert Cohen
(1955).
In
questo clima nacquero gli “apostoli di Radaelli”, un
gruppo selezionato di direttori carcerari giovani, animati
da un solo credo: “tutti i ragazzi sono recuperabili”
(parafrasando il “Nessun uomo è un’isola” di Thomas
Merton (1955), vera bibbia per gli operatori dell’epoca).
Luigi Turco, Enzo De Orsi, Peppino Del Curatolo, e poi
Ziccone, Campanaro e Salvatore alcuni dei nomi che avrebbero
immolato la propria gioventù nel nome dell’ideale
trasmesso dal loro Direttore generale, Radaelli, dall’alto
della sua barba bianca: i ragazzi devono vivere bene negli
Istituti e devono sentire il vostro affetto.
La
premessa è fondamentale per definire, con gradualità, il
senso di una convinzione, oggi ormai condivisa, che rinvia a
due postulati secondo cui “il carcere non rieduca” e
“non si può pensare ad una politica penitenziaria, in
grado di produrre effetti, se non inserita in un sistema di
welfare”.
Era
il 1974. Gli stessi direttori che avevano profondamente
creduto nell’immagine riabilitativa delle case di
rieducazione, unitamente a personaggi della psichiatria
romana come lo stesso Antonucci o Carmine Saccu o Massimo
Ammaniti, ad avvocati illuminati come Guido Calvi o un non
ancora famoso Nino Marazzitta e a molti operatori dei
servizi sociali minorili, iniziavano a premere per la
chiusura delle carceri minorili, perché il problema dei
ragazzi si doveva risolvere lì dove nasceva: nel
territorio, incapace di dare sostegno alle esigenze delle
famiglie da cui provenivano.
Su
tutti aleggiava il verbo basagliano che aveva messo
profondamente in crisi la ideologia riabilitativa (Basaglia,
Basaglia Ongaro, 1971).
Le
sperimentazioni di Trieste e di Gorizia avevano il loro
fascino. Quei matti che giravano per le strade cittadine non
erano diversi dai ragazzi del Tommaseo o di Casal del Marmo
che, a metà degli anni sessanta, andavano in campeggio
sulle Dolomiti, accompagnati da questi “direttori della
nuova via” e da pochi educatori.
Erano
i tempi in cui molto si discuteva sull’alienazione
istituzionale. Da Goffmann (1961) a Foucault (1961), era
tutto un rincorrere a comprare libri da Feltrinelli.
Il
territorio: ecco la risposta. Invece che rinchiudere i matti
o i minori, era necessario strutturare risposte più
articolate nei mondi dove la violenza dei processi di
inurbamento stava producendo danni irreparabili.
I
Direttori di cui ho parlato tutto questo lo avevano
compreso. Gettando le basi per quella riforma del processo
penale minorile (D.P.R. 448 del 22 settembre 1988) che
sarebbe arrivata con quindici anni di ritardo. Ma
soprattutto evidenziando un aspetto, ai quei tempi,
assolutamente improponibile, per l’universo dei
penitenziari: le carceri dovevano aprirsi alla comunità
civile.
Allora
come oggi, il carcere vive un problema centrale, che è
quello della comunicazione. Diffondere la logica della
interprofessionalità non significa solo promuovere azioni
in cui sicurezza e trattamento si coniughino in armonia.
E’
molto di più. Significa incidere sugli stili personali
delle figure professionali, significa superare gli steccati
degli stereotipi. La polizia penitenziaria si è rinnovata.
Non c’è dubbio. La stessa area trattamentale (un’area
cui, se presto non verrà fornito un ricambio generazionale,
andrà verso l’estinzione della specie) ha compreso
l’importanza di una convivenza, fatta di accordi
quotidiani, di piccoli passi che, di fronte a certi eventi
negativi, possono essere facilmente messi in discussione. I
detenuti cambiano modo di pensare e di agire perché
“devono farlo” e non perché “vogliono farlo”. Come
i giocatori compulsivi che di fronte a certi livelli di
disperazione decidono di smettere perché non hanno
alternative e non perché realmente vogliono porre fine al
loro massacro. Come i tossici o come gli alcoolisti, i
detenuti, che sono stati, ovviamente, tossici, alcoolisti o
gamblers, smettono perché devono.
Ci
si chiederà: “ma non è giusto che sia così?”. Certo,
il discorso è, però, più complesso e riguarda
quell’aria di depressione che si vive in tante carceri
italiane dove lo stile della relazione è quello di un
piccolo paese.
“Si
è trattato solo di chiacchiere e sangue”: con questa
frase si conclude il film, molto teatrale, “I Fatti della
Banda della Magliana”. A tale proposito non posso non
citare la geniale frase illustrativa di una condizione, la
frase con cui Renatino De Pedis - il Dandi- si rivolge a
Pippo Calò - zio Carlo- per attenuarne l’ira, dopo la
mancanza di rispetto con cui Maurizio Abatino - il freddo-
si sarebbe rivolto: “dovete scusarlo, noi non abbiamo una
famiglia alle spalle come la vostra. Siamo ragazzi di
strada”.
La
Strada. Vengono tutti da lì. Una volta era Primavalle, oggi
è Corviale o Tor Bella Monaca o il Trullo a Roma. Una volta
erano i quartieri a Napoli. Oggi è Scampia.
Strade
su cui si affacciano palazzoni tutti uguali. Senza anima. E
dentro il carcere certe storie rimangono le stesse.
Il
cambiamento, quello vero, si concretizza solo quando la
porta del carcere si apre ed entrano in scena i volontari.
Attori,
spesso inconsapevoli, di un film che può andare a lieto
fine, se non si sbagliano certe mosse.
Il
ruolo del volontariato ha assunto, negli ultimi anni, il
giusto rilievo che non solo l’ordinamento penitenziario,
ma la storia sociale del nostro sistema, ha voluto e
imposto.
Aprire
non significa rinchiudere i cancelli dietro altre spalle
che, per svariati motivi, personali o di gruppo, decidono di
trascorrere una parte del proprio tempo, assistendo i
carcerati. Aprire significa portare fuori i detenuti.
Progressivamente.
Con l’aiuto dei volontari. Ma soprattutto con la
consapevolezza di un territorio in grado di produrre
“accoglienza”. Il carcere è luogo di assorbimento di
risorse. Anche di fronte ai direttori più progressisti,
come avviene da sempre con gli educatori, l’idea
dell’utilizzo dei volontari è in una logica di controllo.
Che il carcere non rieduchi è fatto altrettanto
assiomatico, quanto quello della funzione a favore di una
gestione di controllo istituzionale, da parte di tutti gli
operatori trattamentali, volontari compresi.
Il
problema è legato a come vengono utilizzate tutte queste
risorse e il loro dispendio.
Per
certi versi l’idea che il carcere apra le porte ai
detenuti e non solo agli esterni, sembra essere stata
ritardata proprio da questa disponibilità
assistenzialistica del mondo del volontariato. Una presenza
che ha attenuato l’entità di certe carenze storiche e
storicamente volute.
Sono
meno di cinquecento gli educatori che lavorano nelle carceri
italiane. Un numero ridicolo, di fronte agli oltre
quarantamila agenti di polizia penitenziaria.
I
ritardi di una politica penitenziaria che assegnasse un
reale valore alla dimensione trattamentale sono ormai
cronici. Forse, aldilà di Nicolò Amato e dei personaggi
dell’epoca, al trattamento non ci ha creduto nessuno. Se
non in una logica di contenimento.
La
presenza dei volontari ha costituito un comodo alibi.
Quando
le agenzie territoriali comprendono che il loro ruolo
equivale a dare un senso all’apertura dei portoni del
penitenziario, non solo per denunciarne le eventuali lacune,
ma soprattutto per incidere sui reciproci stili culturali,
allora le premesse cambiano.
Su
questo iter occorre insistere. Dando, soprattutto, corpo ad
un movimento unitario che non differenzi di molto gli
interventi.
La
preoccupazione trova facili stimoli se si pensa alla
attualità dei dati relativi alla presenza del volontariato
e delle imprese no-profit che offrono la solita immagine di
sperequazione tra Nord e Sud dell’Italia. Il 51% delle
imprese, emerge dalla Quarta Rilevazione della FIVOL (Frisanco,
2006a), è infatti attivo nel nostro settentrione, con una
ulteriore differenziazione che riguarda una netta prevalenza
nel Nord-Est, mentre solo il 27% produce occupazione nel
Meridione. Dati analoghi sulla consistenza dell’intervento
degli oltre 8000 volontari che lavorano nelle strutture
penitenziarie. Come determinato dalla Quinta Rilevazione
della FIVOL (Frisanco, 2006b), tra “le regioni spiccano in
positivo la Toscana per numero assoluto di presenza in
rapporto ai detenuti precedendo in questa graduatoria, il
Veneto e, alla pari, il Friuli, l’Emilia Romagna e la
Basilicata. Al contrario il rapporto meno favorevole tra
detenuti ed operatori non istituzionali si registra nelle
regioni del Molise e soprattutto della Campania”. Non a
caso, aggiungerei. Con un ulteriore dato sul quale
riflettere che è quello del rapporto numerico tra detenuti
e operatori esterni: 5 a 1 per il Centro (il migliore di
tutti), 10 a 1 per il Sud (il peggiore).
Ed
è proprio questo uno dei punti centrali da affrontare. In
Italia non si riesce a comprendere sino in fondo
l’importanza dell’economia no-profit. La storia degli
ultimi anni del nostro Paese ha chiarito che, tanto nei
sistemi neo-liberisti, quanto in una concezione classica di
Welfare State, un ruolo significativo è assunto da un
soggetto specifico che si chiama “privato sociale”.
Il
superamento di una concezione statalizzata, nella
organizzazione sociale del Paese, ha prodotto la necessità
di prevedere una ridistribuzione dei servizi, assegnando una
funzione centrale dapprima all’Ente Locale e
successivamente al Terzo Settore che rappresenta il naturale
interlocutore nella gestione di molte aree operative.
Questo
processo ha, ovviamente, un suo riflesso nel carcere, da
qualche tempo assunto come luogo privilegiato di attenzione.
In molte realtà italiane, gli enti Locali hanno iniziato a
collaborare con le strutture penitenziarie per individuare
percorsi comuni, tesi a favorire il reinserimento dei
detenuti. Sarebbe troppo provocatorio ribadire che ci sono
voluti quaranta anni per comprendere verità quasi banali.
E
la discontinuità, la mancata circolazione di informazioni
su quel che avviene in sede territoriale, la mancata
omogeneizzazione degli interventi rinviano alla necessità
di riflessioni profonde su come articolare un progetto
concreto in cui il carcere sia parte integrante di un
sistema di welfare.
La
sicurezza dei cittadini, è opportuno affermarlo con sempre
maggiore convinzione, passa attraverso alcune fasi
organizzative, in cui la rielaborazione del Codice Penale,
il potenziamento delle politiche di inclusione, il
consolidamento di un linguaggio socio-giuridico che attivi
un rapporto costante tra le politiche sociali e le politiche
penitenziarie, si propongono solo come alcuni degli elementi
irrinunciabili di questo percorso.
Ed
occorre accentuare i ritmi di certe consapevolezze. Troppe
le incongruenze e troppe le paure. Per un verso quel che, da
decenni, si propugna come unica modalità operativa
efficace, il “sistema di rete”, continua ad essere una
sorta di sinfonia incompiuta. Dall’altro gli stilemi
classici della malavita tradizionale fanno ormai parte del
passato.
Gli
operatori sono ancora intrappolati nella logica della
appartenenza professionale. Difficile trovare progetti e
fasi di lavoro in cui le Istituzioni si muovano
all’unisono. I percorsi formativi sono diversi, gli
interventi sull’utenza sono separati. “I miei
detenuti”, “i miei ragazzi”, sono le frasi con cui,
ancora oggi, senti parlare gli operatori carcerari e gli
operatori minorili, frasi dietro le quali si nasconde una
richiesta di riconoscimento della propria soggettività
professionale. Non riesce a decollare, o, comunque, è
ancora in una situazione di strutturazione, l’idea della
“integrazione tra servizi”. E se questo, episodicamente,
accade tra quelli istituzionali e territoriali, certamente
il prodotto non viene confezionato in una ipotesi più alta
di sistemi di servizi integrati. Con l’area
socio-sanitaria e quella socio-penitenziaria, spesso
distanti, ingabbiate in formalismi che dovrebbero essere
superati dalla tendenza a considerare l’utente come un
soggetto sociale unitario.
La
richiesta di sicurezza è naturalmente da comprendere.
Soprattutto l’esplosione della microcriminalità e le
gesta efferate di extracomunitari e delinquenza comune hanno
esasperato la quotidianità della gente.
Il
quadro presentato narra, dunque, di un momento di profonda
trasformazione, ma che nasconde insidie controriformistiche,
dietro ogni delitto che colpisca l’immaginario collettivo.
Del
resto l’antinomia tra politiche di sicurezza e politiche
di inclusione è al centro di un dibattito, non solo
politico e istituzionale, ma anche dottrinale, che, negli
ultimi anni, ha determinato, in particolar modo, ritardi.
Ritardi
nell’affrontare, con coerenza, problemi, la cui natura è
nota. Se è troppo semplicistico ridurre tutto alla
sperequazione economica e infrastrutturale tra Nord e Sud,
se è riduttivo pensare alla centralità, attuale, della
questione degli immigrati, se appare banale parlare ancora
di crisi dei valori, non si potrà, però,non riflettere sui
dati della popolazione detenuta. Chiunque ragioni in una
logica di analisi sistemica, provenga la deduzione anche da
una ottica neo-liberista, non potrà non accorgersi che i
tre quarti della popolazione detenuta in Italia è composta
da persone appartenenti a sole quattro regioni (Campania,
Sicilia, Calabria, Puglia nell’ordine di incidenza
numerica) e da cittadini extracomunitari.
Trovare
gli antidoti a questa situazione significa capovolgere il
senso storico del Paese. Una difficoltà immane, se si pensa
alle spinte indipendentiste e corporative di una parte del
nostro Settentrione, stanco di pagare i balzelli a “Roma
ladrona” e di sostenere il peso del meridione, che si
potrebbe regalare a Gheddafi.
Eppure
la strada da percorrere non può che essere quella della
integrazione. A tutti i livelli. Cominciando proprio dai
Servizi. Che un giorno o l’altro impareranno a interagire
sempre e costantemente e proseguendo per il mondo politico
che rischia tante “piccole rivolte sottoproletarie come
quella di Parigi”.
Il
tema è delicato e rinvia, anche in questo caso, alla
necessità di iniziare ad omogeneizzare il livello di
conoscenze e di linguaggio tra gli operatori.
Non
è possibile, infatti, pensare che non sia esteso, ovunque,
tanto tra gli operatori carcerari, tanto tra quelli dei
servizi territoriali, un livello di consapevolezza
nell’individuare nel Terzo Settore una risorsa oggi
irrinunciabile. Questo, spesso, corrisponde ad una chiusura
culturale nel rapportarsi a ciò che avviene oltre i confini
del proprio lavoro.
In
questa prospettiva, sarebbe auspicabile una riflessione sui
nuovi temi che agitano lo scenario del sociale.
Parlare
di globalizzazione e carcere, ad esempio, dovrebbe risultare
del tutto naturale, considerato quanto è stato scritto sui
rischi che tale processo attiva.
Jeremy
Rifkin, Ulrich Beck, Zygmunt Baumann (1999) sono solo alcuni
della generazione dei socio-economisti che, dalla metà
degli anni novanta, invitano gli studiosi, gli studenti, gli
operatori, i cittadini comuni, tutti gli appassionati di
scienze sociali, ad interrogarsi sulla molteplicità di
funzioni che la globalizzazione può esprimere.
Come
noto, Rifkin, ne “l’Era dell’accesso” (2000) - il
terzo dei suoi libri, dopo “La fine del lavoro” (1995) e
“Il secolo biotech” (1998) -, pone l’accento sulla
progressiva modifica dell’economia capitalistica,
sottolineando come la nuova economia in rete, la fusione
della micro-elettronica e della telecomunicazione, sta
determinando il cambiamento del senso di proprietà come
merce di scambio. Rifkin ha dimostrato l’emergere di una
economia che trasforma i beni in servizi e il tempo umano in
merce. Soprattutto ha introdotto il concetto di superamento
della territorialità degli Stati e la tendenza a
concentrare nelle Multinazionali e nelle grandi Imprese la
quasi totalità del potere economico. Un potere che
deriverebbe loro dall’accesso, appunto, al mondo
immateriale del cyberspazio. In tale ottica, la denuncia di
Rifkin riguarda la possibilità di “accesso” agli
strumenti produttivi e di controllo che non investirebbe più
del 15% dell’umanità.
E’
necessario spendere ancora qualche parola sul tema, perché,
per certi versi, “globalizzazione” può essere
interpretata anche come “lotta alla povertà”. Nel 2004
(Rebuffini, 2004) ha fatto un’analisi profonda del
concetto Monsignor Diarmuid Martin, Osservatore permanente
della Santa Sede presso le Nazioni Unite e il WTO
(l’organizzazione mondiale del commercio). Nel ricordare
come, a più riprese, i rappresentanti del Fondo Monetario
internazionale e della Banca Mondiale hanno evidenziato il
bisogno, nella interpretazione dei rapporti tra economia e
sociale nel contesto globale, di attivarsi nella lotta alle
povertà, Monsignor Martin ha sottolineato un’altra verità.
Quella per cui nessuno può contestare che vi sia mai stato
un “progresso sociale sostenibile senza crescita economica
sostenuta” ed in ogni caso che “la semplice crescita
economica di per sé non garantisce un progresso sociale
equo”. Nelle affermazioni successive, Martin ha chiarito
due altri concetti fondamentali. Il primo è quello del
rapporto tra etica ed economia. Il secondo è quello del
rapporto tra economia e conoscenza.
Rispetto
al primo punto occorre superare la logica per cui gratuità
e solidarietà, concetti sostanzialmente condivisi anche dai
liberisti, non debbano più rapportarsi alla chiave di
lettura della legge di concorrenza. Se il rischio non viene
superato, l’etica continuerà ad essere una sorta di
”cornice” che abbellisce il quadro, senza modificarne il
contenuto, in tal senso riprendendo le parole di Papa
Wojtila per il quale “la libertà economica è solo un
elemento della libertà umana”. Il secondo aspetto
riguarda la natura dell’economia moderna che non è più
solo una economia industrializzata, ma una economia fondata
sulle conoscenze. La principale risorsa di questa economia
è la persona umana. E sulle skills (le capacità) umane è
necessario puntare.
Le
economie che, in questi anni, hanno avuto maggiore successo
sono quelle che hanno investito nell’istruzione, nella
creazione di una cultura imprenditoriale locale,
nell’aggiornamento tecnologico dei lavoratori per
consentire loro di inserirsi nella economia globalizzata. Le
nazioni senza infrastrutture sociali sono destinate a
rimanere ai margini.
“Il
risveglio delle coscienze” che dovrebbe produrre, nello
scenario delle “società a rischio”, di cui parla questo
sociologo, la base per una democrazia reale, non può
ridursi soltanto alle proteste dei poveri di Parigi che
chiedono un diverso livello di attenzione.
Di
riforme il nostro Paese ha espresso bisogno. Di riforme
anche legate al modo di pensare. I pericoli della “glocalizzazione”,
tipicamente legata alla deplorevole tendenza a chiudere i
confini, anche solo regionali, possono essere sconfitti da
una “politica di welfare”, basata sulla partecipazione
solidaristica. Laddove la solidarietà non sia soltanto un
valore, ma un valore aggiunto di processi produttivi che
assegnino al Terzo Settore, e a ciò che rappresenta, il
giusto rilievo.
E’
questo il terreno da arare. Così come, nel campo di azione
del penitenziario, sarà indispensabile rendere attivo e
reale il sistema di rete di cui, da troppo tempo, si parla.
Puntando a rinforzare i canoni organizzativi della
“giustizia riparativa” (il nuovo eden degli operatori),
e a sperare che la riforma del codice penale finalmente si
concretizzi. Sul tema si è pronunciato, più volte,
Giuliano Pisapia, il presidente della Commissione
Ministeriale per la riforma del codice penale.
Il
grande penalista ha affermato testualmente “la
caratteristica di un codice penale equo, efficace, e nel
contempo capace di garantire anche le esigenze di sicurezza
della collettività, deve necessariamente avere come
presupposto la capacità di uscire dalla logica per cui l’unica
sanzione penale è quella carceraria. Mi riferisco ai
reati non gravi: una pena mite, ma certa, tale però da
evitare quel senso di impunità che spesso è la premessa
per un nuovo reato, è certamente più utile e più efficace
di una pena carceraria, che spesso è, invece,
l’anticamera della recidiva. Così come un altro strumento
è quello di misure prescrittive, quali il lavoro
socialmente utile”. Sul risarcimento del danno, come
risposta non sanzionatoria, Pisapia si è così espresso:
”se ci si limitasse a prevedere il risarcimento quale
sanzione di carattere penale, si finirebbe per creare una
inaccettabile disparità di trattamento, tra chi ha
possibilità economiche e chi, al contrario, si trova in uno
stato di indigenza. Il concetto di riparazione pone tutti
sullo stesso piano: ciascuno, sulla base delle proprie
possibilità, deve fare quanto necessario per attenuare le
conseguenze dannose del reato commesso. Allo stesso tempo la
minima entità del danno causato e l’occasionalità della
condotta illecita possono essere condizioni sufficienti per
prevedere la non punibilità in sede penale. Un diritto
penale minimo inciderà positivamente anche sui tempi,
vergognosamente lunghi, della giustizia”.
Queste
indicazioni che, fra qualche tempo, potrebbero tradursi in
realtà, sono legate ad una corrente di pensiero che
individua nel carcere, l’extrema ratio. Perché il tutto
si tramuti in efficacia sarà necessario che cresca il
livello di consapevolezza di tutti della opportunità di
certi percorsi che inseriscano il “progetto carcere” in
un sistema più ampio di ridefinizione delle risorse e dei
servizi. Se tutto ciò, con il tempo, dovesse tradursi in un
più alto livello di comunicazione interprofessionale, molto
cambierebbe, anche nella comunicazione con il mondo
politico. Ed allora un sogno si avvererebbe.
Perché,
in altre parole, le speranze di quei giovani direttori di
cui si è parlato all’inizio, erano legate all’idea
sovrana di “aprire il carcere”. Non solo per fare
entrare la comunità civile, percorso questo indispensabile
per rendere visibile la vita penitenziaria, ma soprattutto
per “far uscire i detenuti”.
Dietro
questa visione (basata sull’utopia del duo De Orsi-Turco,
per cui “nessun uomo può giudicare un altro uomo”),
c’era in particolare, non esplicita, inconscia e non
detta, una aspirazione. Quella di contribuire a creare i
presupposti perché “nessun uomo entri in carcere”. Un
giorno, non ci è dato sapere, forse la società fermerà
questa corsa verso l’autodistruzione e lascerà scendere
tutti. Nessuno escluso.
-
Antonio Turco
-
|