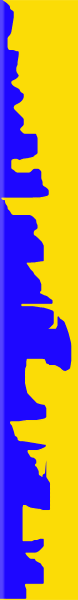|
1.
Boom
penitenziario e incarcerazione dei migranti
Da
anni ormai i dati relativi alla popolazione detenuta dei
principali paesi europei mostrano un impressionante trend
crescente, con l’unica importante eccezione della Francia.
In ognuno di essi si sta
procedono alla costruzione di nuove carceri e si
incrementano le spese destinate alle “forze della legge e
dell’ordine”, in primo luogo alle forze di polizia e al
personale carcerario adibito alla custodia. Di pari passo
si assiste in questi paesi alla proliferazione di misure
volte a prevenire o reprimere quanto potrebbe turbare il
tranquillo sviluppo delle relazioni pubbliche (si
diffondono per esempio i provvedimenti che vietano o
limitano la mendicità, si istituisce il coprifuoco per gli
adolescenti, ecc.), si ricorre al massiccio impiego della video-sorveglianza
in luoghi e mezzi di trasporto pubblici. Il controllo
elettronico è sempre più usato, nonostante che esso tenda
non a sostituirsi ma ad aggiungersi alla carcerazione.
Inoltre sono radicalmente cambiate le retoriche che
accompagnano la detenzione: essa viene dipinta sempre meno
come strumento di reinserimento sociale e sempre più come
mezzo di incapacitazione e neutralizzazione degli autori dei
reati.
La
rapida progressione con cui, in questi paesi, cresce la
quota della popolazione considerata in aperto conflitto
con la giustizia e con cui si diffonde la convinzione che
essa andrebbe sottoposta a misure meramente repressive, pone
un problema di trasformazione qualitativa delle politiche
penali.
I dati sembrano suggerire che è accaduto qualcosa che rende
necessario, agli occhi dei governi e dell’opinione
pubblica, da un lato un ricorso alla istituzionalizzazione
delle persone molto più ampio rispetto ai decenni
precedenti e dall’altro una detenzione che si preoccupi
esclusivamente di escludere chi vi è sottoposto dalle
normali relazioni sociali.
Nei
paesi meta di massiccia immigrazione (Austria, Belgio,
Olanda, Germania, Italia, Spagna e Svezia), gli stranieri
rappresentano una percentuale rilevante della popolazione
detenuta, spesso tale da spiegare il suo aumento. Il loro
numero in questi paesi oscilla da circa un terzo a poco meno
della metà dei detenuti, una percentuale quindi decisamente
superiore a quella del numero degli stranieri presenti sul
territorio nazionale rispetto alla popolazione autoctona. Un
discorso a parte va fatto per Francia e Regno Unito, dove la
percentuale degli stranieri detenuti è relativamente bassa.
Questi paesi sono, o sono stati, caratterizzati da una
politica di facile concessione della cittadinanza,
specialmente alle persone provenienti dalle ex colonie, per
cui sono più indicativi i dati relativi all’origine
etnica dei detenuti.
L’Home Prison Service (2005) nel suo rapporto annuale del
2005, segnala che il 22% delle persone entrate in carcere
per la prima volta tra marzo 2004 e aprile 2005 apparteneva
a minoranze etniche. Dato che oltre il 12% dei detenuti sono
stranieri, similmente a quanto accade negli altri grandi
paesi europei meta di migrazioni, circa un terzo dei
detenuti non è autoctono. Per quanto concerne la Francia
(dove gli stranieri rappresentano comunque più di un quinto
dell’intera popolazione detenuta), è stato osservato (Palidda
1999, 42) che, se si tenesse conto dell’origine dei
detenuti, la percentuale di detenuti stranieri e d’origine
straniera sarebbe molto elevata, addirittura superiore alla
percentuale di afro-americani reclusi nelle carceri
statunitensi.
|
Paese[5]
|
Popolazione detenuta
|
N./100000 cittadini
|
Trend 1992 – 2001
n. e n./100000 cittadini
|
Detenuti stranieri (% sulla pop. det.)
|
|
Austria
|
8766
(9.6.06)
|
105
|
6913 (87)
– 6915 (85)
|
45.1
(1.11.05)
|
|
Belgio
|
9597
(8-2006)
|
91
|
7111 (71)
– 8764 (85)
|
42,0
(16.1.06)
|
|
Danimarca
|
4198
(17.10.05)
|
77
|
3406 (66)
– 3150 (59)
|
17.5
(28.2.06)
|
|
Eire
|
3080
(1.9.06)
|
72
|
2155 (61)
– 3025 (78)
|
9,0
(20.4.06)
|
|
Finlandia
|
3954
(1.4.06)
|
75
|
3295 (65)
– 3040 (59)
|
8,0
(1.4.06)
|
|
Francia
|
52009
(1.9.06)
|
85
|
48113
(84) – 46376 (78)
|
21,4
(1.4.03)
|
|
Germania
|
78581
(31.3.06)
|
95
|
57448
(71) – 80333 (98)
|
28,2
(31.3.04)
|
|
Inghilterra e Galles
|
79642
(29.9.06)
|
148
|
44719
(88) – 66301 (127)
|
12,5
(30.6.05)
|
|
Italia
|
59523
(31.12.05)
|
102
|
46152
(81) – 55136 (95)
|
33.32
(31.12.05)
|
|
Lussemburgo
|
768
(1.6.06)
|
167
|
352 (89)
– 357 (80)
|
75,0
(1.6.2006)
|
|
Nord
Irlanda
|
1464
(26.9.06)
|
84
|
1811
(112) – 877 (52)
|
0.8
(30-1-06)
|
|
Norvegia
|
3048
(1.8.06)
|
66
|
2477 (58)
– 2666 (59)
|
17.2
(1.8.06)
|
|
Paesi
Bassi
|
21013
(1.7.06)
|
128
|
7397 (49)
– 15246 (95)
|
31,7
(1.7.2006)
|
|
Portogallo
|
12870
(1.9.06)
|
121
|
9183 (93)
– 13500 (131)
|
17,3
(31.12.04)
|
|
Scozia
|
7212 (29.9.06)
|
141
|
5357 (105) – 6172 (122)
|
1.3 (1.9.04)
|
|
Spagna
|
64183 (15.9.06)
|
145
|
35246 (90) – 46962 (117)
|
29,7 (21.4.06)
|
|
Svezia
|
7450 (1.4.06)
|
82
|
5431 (63) – 6089 (68)
|
26.3 (1.10.05)
|
La
letteratura stranamente non tende a mettere questo dato
sulla popolazione carceraria in correlazione con le
politiche migratorie seguite dai vari paesi europei. Eppure
sembra irrealistico pensare che non ci sia alcun nesso tra
l’alto tasso di carcerizzazione degli stranieri e il loro
status giuridico. Spesso gli stranieri sono costretti a
vivere, nel migliore dei casi, in condizioni di grande
precarietà, che rendono molto difficile difendere i propri
diritti, o, nella peggiore delle ipotesi, si vedono
attribuire lo status di irregolari, che non consente loro di
esercitare praticamente alcun diritto. L’aumento dei
migranti nelle carceri europee va di pari passo alla
rilevazione di un gran numero di migranti irregolari
presenti nei diversi paesi e a frequenti
“regolarizzazioni” che attribuiscono ad una parte di
loro uno status legale, spesso precario e che quindi
modifica di poco le loro condizioni di soggetti senza
diritti.
In
questo saggio cercherò di mostrare come le politiche dei
vari Stati europei si siano orientati verso una strategia
volta a favorire la presenza di stranieri irregolari sul
loro territorio, quelli che riescono a rimanere per un
discreto lasso di tempo, senza incorrere nelle maglie della
giustizia penale, vengono poi periodicamente fatti oggetto
di regolarizzazione di massa. Sosterrò poi che questa
politica, apparentemente paradossale, trova la propria ratio
in una profonda cesura del rapporto tra Stato e popolazione.
Sulla scorta delle analisi di Foucault, argomenterò che si
sta passando da una fase in cui lo potenza dello Stato era
legata alla sua capacità di rendere produttiva e
disciplinata la popolazione ad una fase in cui lo Stato può
limitarsi a selezionare i suoi cittadini. Questo passaggio
comporta l’abbandono di strategie inclusive di
riconoscimento dei diritti di cittadinanza a favore di una
concezione della cittadinanza che si erge come un muro che
esclude i migranti che giungono in Europa. Sosterrò infine
che il carcere, modificando il suo tradizionale ruolo di
strumento di disciplina, si è erto a perno di queste
politiche, svolgendo, di fatto, la funzione di selezionatore
dei migranti destinati ad essere espulsi, di quelli
destinati alla clandestinità perenne e di quelli che si
possono avviare a percorrere l’accidentato sentiero che li
porterà ad uno status legale e a godere di un paniere
progressivamente crescente di diritti.
2.
Il
governo delle migrazioni tra produzione dell’irregolarità
e sanatorie
Con il termine
regolarizzazione si intende l’autorizzazione a soggiornare
concessa dallo Stato a cittadini stranieri presenti
irregolarmente sul proprio territorio. Nel secondo dopo
guerra, sino alla crisi economica dei primi anni ’70, i
principali paesi europei di destinazione dei flussi
migratori (Germania, Francia, Belgio, Olanda, Regno Unito)
hanno gestito, di fatto, la presenza irregolare di stranieri
attraverso regolarizzazioni permanenti. Questa politica è
stata adottata fino alla fine degli anni ottanta del secolo
scorso anche dai paesi dell’Europa meridionale, verso cui
si sono diretti i flussi migratori via via che i paesi del
Nord Europa, tradizionale destinazione dei migranti, hanno
introdotto rigidi limiti all’ingresso di cittadini di
paesi terzi. Contemporaneamente anche queste nazioni hanno
progressivamente introdotto vincoli sempre più stringenti
all’ingresso degli stranieri.
Ormai da un paio di
decenni si è diffusa tra i governi europei la prassi di
ricorrere a programmi di regolarizzazione per gestire i
migranti sprovvisti di documenti di soggiorno. Molti paesi
europei si sono orientati verso una strategia basata sulla
restrizione degli accessi regolari, la sostanziale
tolleranza (al di là delle retoriche) di un alto tasso di
migranti che soggiornano irregolarmente e poi ad ondate
cicliche vengono regolarizzati. Queste politiche comportano
che in Europa è oggi presente una massa di migranti privi
di uno status regolare e quindi senza diritti. Secondo il
Terzo Rapporto di Caritas Europea (2006) sulla povertà sono
circa 5 milioni.
Inoltre un mezzo straordinario, come la regolarizzazione,
per gli immigrati è diventata paradossalmente oggi
nell’Unione uno dei canali più importanti, da un punto di
vista numerico, di acquisizione di uno status legittimo.
Negli ultimi
vent’anni si è assistito all’emanazione di una lunga
serie d’interventi puntuali (definiti “sanatorie” o
provvedimenti one-shot): misure straordinarie
finalizzate a concedere il permesso di soggiornare solo a
coloro in grado di dimostrare la presenza all’interno dei
confini prima di una certa data, precedente all’emanazione
dell’atto normativo. A volte questi provvedimenti hanno
mirato alla regolarizzazione di quasi tutti gli stranieri
non in regola presenti (la legge italiana 39/1990, detta
“legge Martelli”, aveva questo scopo) o sono sfociati,
attraverso il progressivo ampliamento del bacino dei
possibili beneficiari, nella regolarizzazione di tutti
quelli che potevano vantare un inserimento lavorativo e non
avevano precedenti penali (di nuovo in Italia questo
percorso si è compiuto in occasione dell’approvazione
della legge 40/1998,
cosiddetta “legge Turco-Napolitano”). In Francia,
paese in cui ci sono state solo due provvedimenti one-shot,
esisteva un sistema di regolarizzazione permanente che
consentiva, in ogni momento, a chiunque poteva dimostrare di
trovarsi sul territorio nazionale da oltre dieci anni di
acquisire uno status regolare. Questa possibilità è stata
abrogata nel 2006.
In Francia si sono
avute due sanatorie una nel 1981 e nel 1997. Questa seconda
sanatoria prese avvio il 25 giugno 1997 quando Chevènement, Ministro degli Interni del governo
Jospin, pubblicò una circolare che definiva le modalità di
riesame dei casi degli stranieri in situazione irregolare.
Il 28 ottobre 1997, 140.000 stranieri irregolari avevano
presentato la loro domanda.
Tra il 1995 e il 1998 c’è stata una sanatoria in Grecia e
due in Belgio.
La politica del governo
italiano in questo campo sarà esaminata in dettaglio nelle
prossime pagine perché si può assumere come emblematica,
probabilmente per il fatto che l’Italia è diventata
destinazione di immigrazioni nello steso periodo in cui
prendeva consistenza l’idea di un mercato unico mondiale
(anche della forza lavoro). Come vedremo, in Italia da un
lato le sanatorie hanno rappresentato senza ombra di dubbio
il canale privilegiato di acquisizione di status di
residenti regolari dei migranti, dall’altro ormai da anni,
i dati relativi agli stranieri detenuti mostrano un
impressionante trend crescente. Al
31 dicembre del 1998 erano 11.973, pari al 25,04% del
totale; dopo un anno erano 14.507, pari al 27,13% della
popolazione detenuta; al 31 dicembre del 2000 erano
diventati 15.582, pari al 29,3% dei detenuti presenti nelle
carceri; a fine 2001 erano 16.294, corrispondenti al 29,5%
delle persone complessivamente detenute; nel 2002 arrivavano
ad essere il 30,2% della popolazione detenuta, raggiungendo
la cifra di 16.788; nel 2003 i migranti in carcere erano
diventati 17.007, pari al 31,44% dei 54.237 detenuti
complessivi. Il 31 dicembre del 2004, risultano 17.819
stranieri presenti nelle carceri italiane su una popolazione
detenuta pari complessivamente a 56.068 persone; la
percentuale dei migranti è giunta quindi al 31,84% dei
detenuti complessivi (se si prendono in esame le donne
detenute, la percentuale delle straniere è molto maggiore:
su 2.589 donne presenti nelle carceri alla fine del 2004,
erano straniere 1.131, pari al 43,85%). A fine 2005 la
percentuale dei migranti sale ancora arrivando al 33,32%
(sono 19.836 su una popolazione detenuta di 59.523 persone).
In quest’anno si registrano due dati eclatanti: i migranti
rappresentano il 45% dei soggetti entrati in carcere dalla
libertà nel corso dell’anno; sono straniere il 46,43%
delle donne che risultano detenute a fine anno (1.302 su
2.804).
In
Spagna, dove l’arrivo massiccio di immigrati si è
verificato nello stesso periodo, la gestione del fenomeno è
stata del tutto simile a quella italiana: poche possibilità
per entrare legalmente, grande diffusione del lavoro nero e
una lunga serie di sanatorie, la prima nel 1985, quando si
approvò la prima legge sull’immigrazione, e dopo nel
1991, 1996, 2000 e 2001. L’ultima sanatoria è stata
varata nel 2005, il regolarizzando doveva dimostrare di non
avere precedenti penali nel suo paese, di essere arrivato in
Spagna prima dell’agosto del 2004
e di avere un contratto di lavoro per almeno sei mesi. La
legislazione sull’immigrazione approvata nel 1985 è stata
modificate negli ultimi anni in tre occasioni - legge
4/2000, 8/2000 e 14/2003 – introducendo ogni volta
parametri più rigidi per l’ingresso degli stranieri e
restringendo i loro diritti. Il risultato di queste scelte
è che secondo l'Istituto nazionale di statistica (Ine),
in Spagna vivevano nel 2005 più di un milione e mezzo di
immigrati clandestini. Quelli con i requisiti per presentare
la domanda di regolarizzazione erano stimati tra i 500 e gli
800mila.
2.1. La
restrizione dei canali legali d’immigrazione
Il
continuo ricorso alle sanatorie e l’enorme numero di
migranti senza permesso di soggiorno avrebbe dovuto spingere
i governi a rendere più facile il percorso di ingresso
degli stranieri, consentendo in primo luogo la conversione
del permesso di soggiorno per motivi di turismo in permesso
di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo,
qualora il migrante nel periodo di permanenza sul territorio
sia stato in grado di mettersi nelle condizioni di
accedervi. Il
permesso di soggiorno, infatti, rende il migrante titolare
di un patrimonio di diritti la cui preservazione dipende
necessariamente dall’inserimento nel mondo del lavoro
regolare e dall’osservanza di una serie di doveri. Tanto
più sostanzioso è questo patrimonio, tanto più esso
rappresenta un efficace stimolo a non percorrere le strade
dell’illegalità (se quelle legali non vengono ostruite da
troppi vincoli). La presenza sul territorio di
migranti irregolari, invece, rende impossibile garantire
loro i diritti
fondamentali della persona, senza dimenticare che il mancato
rispetto dei minimi salariali e delle disposizioni in
materia fiscale e contributiva, oltre a costituire un grave
danno economico per il lavoratore e per lo Stato,
rappresenta un fattore di concorrenza sleale ai danni dei
lavoratori regolari, nazionali o stranieri che siano.
Gli
Stati europei hanno invece percorso la via inversa. Una
giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo
ormai consolidata,
riconosce ad ogni Stato un potere sovrano in merito
all'ammissione, al respingimento, all'espulsione e
all'estradizione dello straniero che migra per motivi di
lavoro. In questo ambito, gli Stati europei, invece che
allargare le possibilità di ingresso per ricerca di lavoro
per combattere l’immigrazione clandestina, hanno teso, da
un lato, a restringere i canali di ingresso e, dall’altro,
hanno concepito un sistema dei visti che lega la regolarità
del soggiorno al contratto di lavoro, rendendo comunque
precario lo status degli immigrati e quindi scoraggiando la
loro stabilizzazione sul proprio territorio. Ancora più
rilevante è la politica restrittiva adottata nei confronti
dei flussi migratori per motivi familiari ed umanitari. In
questo settore il potere discrezionale degli Stati dovrebbe
essere limitato dalla presenza di norme di diritto
internazionale che configurano un vero e proprio diritto
soggettivo al ricongiungimento familiare o alla protezione
umanitaria. Con riferimento al governo di questi flussi si
parla infatti di embedded liberalism, ossia di un
contesto istituzionale che “vincola enormemente il potere
decisionale dei singoli Stati, riducendo drasticamente la
loro capacità di determinare il volume e la composizione
dell'immigrazione” (Zanfrini 2004, 123). Gli ordinamenti
giuridici dei paesi europei dovrebbero sentirsi infatti
pressoché costretti a riconoscere ai migranti il diritto di
ricongiungersi con i propri familiari e il diritto di Asilo,
in forza rispettivamente dell'art. 8 della Convenzione
Europea sui Diritti dell’Uomo
(CEDU) e di tutta una seria di trattati internazionali in
materia di rifugiati che hanno il loro capostipite nella
Convenzione di Ginevra. Nonostante queste norme, di fronte
alla crescita esponenziale delle migrazioni umanitarie e per
motivi familiari gli Stati europei hanno fatto di tutto per
limitare il diritto dei migranti a fare ingresso nel loro
territorio.
Emblematica
è la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare.
Di fronte alle dimensioni eclatanti raggiunte dai
ricongiungimenti familiari, che secondo alcune stime (Zanfrini
2004, 123) rappresentano circa la metà degli ingressi
regolari registrati ogni anno nei paesi dell'Unione europea,
la direttiva cerca di ridurre al minimo il diritto
all’unità familiare riconosciuto dall’art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Essa, infatti,
impone agli Stati membri di riconoscere il diritto al
ricongiungimento esclusivamente al coniuge del soggiornante
e ai figli minorenni. E’ rimessa alla discrezionalità dei
singoli Stati la possibilità di ricongiungimento familiare
con gli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o
del suo coniuge, se a carico di questi ultimi e privi di un
adeguato sostegno familiare nel paese di origine, con i
figli maggiorenni non coniugati o incapaci di provvedere al
proprio sostentamento per ragioni di salute, con il partner
legato al soggiornante da una relazione stabile e duratura o
formalmente registrata. Per questi soggetti non si può
quindi parlare di titolarità di un diritto al
ricongiungimento familiare da far valere nei confronti degli
Stati ospiti. Il diritto al ricongiungimento degli stessi
soggetti, ma in altre condizioni (genitori dotati di un
proprio reddito nel paese di origine, i figli maggiorenni
autosufficienti e/o coniugati), non è proprio preso in
considerazione. Inoltre la direttiva prevede un periodo di
soggiorno legale di almeno a due anni come condizione per la
richiesta di ricongiungimento, e prevede che gli Stati
possono far trascorrere fino a tre anni tra la presentazione
della domanda e l'effettivo rilascio del titolo di
soggiorno. Gli Stati possono anche limitare il diritto al
ricongiungimento familiare dei figli minori che abbiano già
compiuto dodici anni, condizionando il loro ingresso
all’espletamento di un esame circa le condizioni per la
loro integrazione, e possono esigere “che le domande
riguardanti il ricongiungimento familiare di figli minori
debbano essere presentate prima del compimento del
quindicesimo anno di età”. Queste ultime disposizioni,
che consentono agli Stati di vanificare del tutto il già
angusto riconoscimento del diritto alla unità familiare
riconosciuto dalla direttiva, sono state oggetto di un
ricorso per annullamento presentato il 22 dicembre 2003 dal
Parlamento europeo contro il Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-540/03). La Corte di Lussemburgo ha avvallato la
scelta dei governi europei sostenendo che le limitazioni
poste non sono discriminatorie e affermando, abbastanza
sorprendentemente e, a mio parere, in contrasto con la
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che l’art. 8
della CEDU non conferisce ad alcun membro della famiglia di
un migrante, neppure ai figli minorenni, “il diritto
soggettivo ad essere ammessi nel territorio di uno Stato”.
Con
lo slogan che l’immigrazione “deve essere scelta e non
subita”, una normativa sui ricongiungimenti familiari in
linea con la direttiva comunitaria è stata recentemente
approvata (maggio 2006) in Francia. La normativa, a conferma
della tendenza a non distinguere le politiche relative alle
migrazioni per motivi di lavoro, regolabili
discrezionalmente, e da quelle relative alle migrazioni per
motivi familiari ed umanitari, dove vigono una serie di
diritti dei migranti, si inserisce nel quadro di un generale
restringimento delle possibilità di accedere al territorio
francese (sono irrigiditi i criteri di selezione per gli
studenti stranieri, così come le condizioni di soggiorno
per i lavoratori, mentre aumentano i titoli richiesti per
fare domanda di ingresso).
A
riprova dello spirito che anima i governi europei, in una
lunga intervista al Journal du Dimanche, il ministro
Nicolas Sarkozy, promotore della legge, sostiene che quando
a partire dal 1974 l'immigrazione familiare ha cominciato a
sostituirsi a quella economica, si è provocato un
“guasto” nelle politiche di controllo
dell’immigrazione. Oggi l’immigrazione familiare, con
oltre 100 mila ingressi l'anno, rappresenta la gran parte
dell'intero movimento, mentre solo il 5% degli immigrati
regolari arriva in Francia per motivi di lavoro. Per cui se
il governo si limita alla regolamentazione
dell’immigrazione per motivi di lavoro perde il controllo
dei flussi migratori. Sarckozy imputa al forte aumento del
flusso legato alle dinamiche familiari i problemi di
integrazione, la formazione di ghetti e l'impoverimento del
tessuto sociale delle periferie francesi. In conclusione
passare da un’immigrazione “subita” a
un’immigrazione “scelta” vuol dire limitare gli
ingressi per motivi familiari per favorire l'arrivo di
lavoratori stranieri utili all'economia.
Anche
in Germania il governo sta discutendo una riforma della
regole dell’immigrazione che prevede assunzioni veloci per
i lavoratori stranieri qualificati e un giro di vite sui
ricongiungimenti familiari. In Danimarca le politiche
adottate negli ultimi anni, hanno portato secondo uno studio
pubblicato da “Le Figaro”nel marzo 2006, ad una
riduzione dell'80% del numero delle richieste di asilo e del
65% delle domande di ricongiungimento familiare. In Austria
nel 2005 è stato allungato il periodo necessario per
chiedere asilo.
La
degradazione del “diritto” all’unità familiare dei
minori a mera situazione di fatto da trattare con
benevolenza è resa evidente dalle ultime sanatorie
approvate o discusse nei paesi del nord Europa: queste, che
possono essere considerate dei provvedimenti di
“grazia”, assumono come criterio per concedere un
permesso di soggiorno ad una famiglia irregolare la presenza
di bambini la cui vita è fortemente radicata nel paese
ospite. In Francia, dove pure l’attuale governo considera
disastrosa l’esperienza delle precedenti sanatorie, è
stata emanata una circolare il 13 giugno del 2006 che
consentiva ai prefetti di concedere il permesso di soggiorno
alle famiglie straniere con bambini nati in Francia o
giuntivi “in tenera età” che non parlano la lingua del
loro paese d’origine. Sono state accolte 6.924 delle oltre
30.000 domande di sans papiers. Questo numero è
irrisorio se si considera che le stime parlano di
200.000/400.000 immigrati clandestini presenti attualmente
in Francia.
Anche
il governo Tedesco sta valutando la concessione di un
permesso di soggiorno di lunga durata ai cittadini stranieri
che vivono irregolarmente in Germania, ma non possono essere
espulsi perché hanno figli perfettamente integrati nella
società tedesca. Secondo le stime dello
stesso governo sarebbero tra i 150.000 e i 200.000 gli
immigrati interessati a questa sanatoria, per la maggior
parte profughi dalla ex Jugoslavia che si sono visti negare
negli anni scorsi il riconoscimento del diritto di asilo.
2.2.
Le politiche italiane: migranti e clandestini
L’analisi
delle politiche migratorie italiane ha come punto di
partenza obbligato la legge 39/1990 (cosiddetta legge
Martelli). Questa legge per la prima volta si propone di
disciplinare in modo organico l’immigrazione, cercando di
evitare che si formino sacche di irregolarità. A questo
scopo il legislatore prevede
l’emanazione di un decreto governativo annuale (il
cosiddetto “decreto flussi”) per la definizione dei
criteri di ammissione dei lavoratori immigrati e delle
misure atte al loro inserimento sociale.
Contestualmente il legislatore offre agli stranieri presenti
irregolarmente sul territorio nazionale la possibilità di
sanare la loro posizione.
Gli effetti di questa sanatoria si dispiegano nel corso del
1991, quando essa consente a 234.841 persone di mettersi in
regola.
Secondo
l’Istat (2004, 9) il primo gennaio 1992 risultavano
regolarmente presenti in Italia 648.935 stranieri. Molti di
loro erano entrati o si erano trattenuti irregolarmente sul
territorio italiano, avevano poi acquisito il permesso di
soggiorno grazie alle tre sanatorie che si erano succedute
dal 1982 al 1990. Prima della Martelli, nel 1982, una
circolare del ministero del lavoro permise di regolarizzare
circa 2.500 persone, poi la legge 943 del 1986 (al titolo IV)
consentì a 118.709 persone di acquisire un permesso di
soggiorno, così che nel 1987 i migranti regolarmente
soggiornanti passarono da 450.277 a 572.103 (con un
incremento del 27,1%).
Grazie alle sanatorie, nel decennio immediatamente
precedente al rilevamento dell’Istat, si erano dunque
messe in regola poco meno di 357.000 persone. Se fossero
tutte rimaste in Italia fino al 1992, avrebbero
rappresentato ben più della metà degli stranieri presenti
al primo gennaio di quell’anno: è realisticamente
ipotizzabile che circa la metà degli stranieri presenti sul
nostro territorio al primo gennaio 1992 fossero entrati nel
territorio statale, o vi avessero soggiornato,
irregolarmente e dopo qualche anno di clandestinità
avessero usufruito di una sanatoria. Questo calcolo
approssimativo è confermato dall’Istat (2004, 10),
secondo il quale oltre un terzo dei migranti presenti sul
territorio nazionale il primo gennaio del 1992 era
costituito da individui che avevano beneficiato della legge
n. 39 del 1990, in maggioranza africani e asiatici.
Gli
effetti dell’instabilità dei permessi rilasciati in base
alla sanatoria del 1990 si fanno sentire nel corso del 1992:
a fine anno risultano circa 160.000 permessi non rinnovati,
con una marcata riduzione dei migranti regolarmente
soggiornanti il primo gennaio dell’anno successivo che
sono circa 589.000, quindi 60.000 in meno. L’Istituto
nazionale di statistica osserva che un tale esito “era in
parte prevedibile” dato che la legge Martelli “puntava
essenzialmente a portare alla luce la quota illegale della
presenza straniera” e quindi consentiva agli irregolari di
sanare la loro situazione con grande facilità: per ottenere
il permesso di soggiorno bastava dimostrare di essere in
Italia alla data del 31/12/1989, solo al momento del rinnovo
del permesso di soggiorno si doveva dimostrare di avere un
lavoro. Rimarrebbe da chiedersi quanti, dei 160.000 migranti
a cui non fu rinnovato il permesso di soggiorno, hanno
effettivamente lasciato il territorio nazionale. Mancano
tuttavia i dati che consentano di rispondere a questa
domanda.
Anche
dopo la legge Martelli, come è noto, il legislatore non ha
smesso di ricorrere alle sanatorie, anzi i dati mostrano che
le sanatorie, e non i meccanismi che presiedono
all’ingresso, sono state dal 1990 in poi il principale
mezzo attraverso cui i migranti hanno potuto accedere allo
status di residenti in regola. Nei
primi anni di applicazione della legge 39/90, i decreti
flussi si sono limitati a permettere l’ingresso secondo le
modalità previste dalla legge 943 del 1986, quindi in
pratica per la sola chiamata nominativa, senza peraltro
fissare il numero massimo di ingressi consentiti. La
chiamata numerica di lavoratori residenti all’estero,
fatta esclusivamente basandosi su liste organizzate per
competenza professionale, è utilizzata solo da industrie
medio-grandi per lavori ad alto contenuto tecnico, per i
quali l’incontro tra domanda e offerta può prescindere
dall’instaurarsi di un rapporto di fiducia tra lavoratore
e datore di lavoro. Ad essa, invece, non hanno fatto
ricorso, pressoché mai, le piccole imprese, che
evidentemente hanno spesso preferito servirsi di migranti a
loro noti, presenti irregolarmente sul territorio nazionale.
Le limitazioni imposte dal decreto sui flussi hanno dunque
proposto, come canale quasi normale d’accesso al titolo di
soggiorno, un percorso tracciato dalle seguenti tappe:
ingresso irregolare o per motivi di turismo, soggiorno
irregolare, che consente di trovare un inserimento nel mondo
del lavoro sommerso, e sanatoria.
Dal
gennaio 1993 al dicembre 2002 i migranti regolarmente
soggiornanti passano da circa 589.000 a circa 1.503.000. Su
questo dato influiscono le sanatorie disposte nel 1995 dal
decreto legge 489 (cosiddetto “decreto Dini”) e dal
decreto legge del 16/10/98, emanato immediatamente dopo
l’approvazione della legge 40 del 1998 (cosiddetta
“legge Turco-Napolitano”), che hanno permesso
rispettivamente la regolarizzazione di 246.000 e 215.000
migranti circa. Quindi, ancora una volta, dei circa 914.000
stranieri che in un decennio acquistano un titolo di
soggiorno regolare sul territorio statale, oltre la metà
(circa 461.000) non ha seguito il percorso previsto dalle
norme, ma ha soggiornato clandestinamente per qualche tempo
sul territorio italiano.
Come chiarisce l’Istat (2004, 10 e 11), è grazie
alla sanatoria predisposta con il d.l. 489 del novembre 1995
che gli stranieri regolarmente soggiornanti al primo gennaio
1997 sono il 35% in più di quelli dell’anno precedente e, analogamente, alla
base della crescita di circa 250.000 migranti regolarmente
soggiornanti, verificatasi tra gennaio 1999 e gennaio 2000,
sta “la regolarizzazione avviata con il D.p.c.m. del 16
ottobre 1998 e poi definita con il D.l. n. 113 del 13 aprile
1999”. Ma il dato più interessante posto in evidenza
dall’Istituto di statistica è che i migranti
regolarizzati in entrambe le occasioni, al contrario di
quelli regolarizzati con la legge Martelli, si sono
dimostrati capaci di conservare il loro status di regolari e
di rinnovare i loro permessi di soggiorno.
Ancora una volta quindi si può stimare che per almeno la
metà dei 1.503.000 migranti presenti sul territorio
italiano al primo gennaio 2003 la conquista del permesso di
soggiorno è passata attraverso un periodo, più o meno
lungo, di clandestinità.
Questo
dato diventa ancora più eclatante con la sanatoria
predisposta con la legge 189 del 2002, per la quale
risultano presentate 702.156
domande, a fronte delle quali risulta che al 31 dicembre
2003 gli stranieri non comunitari residenti erano aumentanti
di oltre un terzo (circa 533.000 unità) rispetto al primo
gennaio, raggiungendo il numero di 2.036.682, mentre i
permessi di soggiorno erano arrivati a 2.193.999.
Questo balzo in avanti è dovuto ai migranti che hanno
ottenuto la sanatoria, stimata dall’Istat di circa 650.000
persone,
la stragrande maggioranza dei quali prevede di restare in
Italia per un periodo ragionevolmente lungo, visto che si
affretta a prendere la residenza. Questi dati statistici
portano a concludere che non si dovrebbe essere lontani
dalla realtà se si afferma che quasi due terzi dei migranti
oggi legalmente residenti in Italia è passato attraverso un
periodo più o meno lungo di permanenza clandestina sul
nostro territorio.
Questa
stima appare realistica, tenendo conto anche del fatto che
il migrante assunto per chiamata nominale non di rado è un
soggetto che auto-sana la propria posizione sul territorio
nazionale. Spesso, infatti, questi migranti non sono
all’estero, come vorrebbe la legge, ma presenti in modo
irregolare sul territorio nazionale, e magari già lavorano
per un datore di lavoro “onesto”, che alla pubblicazione
del decreto flussi, richiede la loro assunzione, per
permettere loro di godere delle più elementari forme di
protezione previste per i lavoratori. Se la domanda del datore
di lavoro rientra nella quota, il migrante fa rientro nel
suo paese di origine, ottiene un regolare visto di ingresso
e torna nel nostro paese dove gli viene rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro che lo protegge
dalla forme più odiose di sfruttamento. Se si tiene poi
conto che quasi un quarto dei permessi di soggiorno
esistenti alla fine del 2003 risultava rilasciato per motivi
di famiglia,
si arriva alla conclusione che la stragrande maggioranza dei
migranti che dispongono di un permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, lo hanno ottenuto grazie ad una sanatoria.
Volendo essere rigorosi, poi, tra coloro che hanno acquisito
un titolo di soggiorno sfruttando la condizione di
irregolarità andrebbero anche calcolati tutti i migranti
che si sono serviti indirettamente della sanatoria per
entrare nel territorio dello Stato, cioè tutti quei
migranti che sono entrati grazie al ricongiungimento
familiare con lavoratori che hanno usufruito di una
sanatoria.
Il
messaggio, quindi, che le nostre politiche migratorie
comunicano è che se un migrante vuol entrare in Italia deve
essere pronto ad affrontare un periodo di clandestinità sul
nostro territorio e forse anche a varcare clandestinamente
la frontiera. I dati relativi all’ultima sanatoria,
gli unici che abbiamo relativi al rapporto tra migranti
entrati irregolarmente e overstayers, cioè diventati
“clandestini” perché rimasti alla scadenza del permesso
di soggiorno, dicono che il 75% delle oltre 700.000 persone
che avevano chiesto di regolarizzarsi erano entrate in
Italia regolarmente e vi sono rimaste dopo la scadenza del
visto o dell’autorizzazione al soggiorno.
Come nel resto
di Europa, il continuo ricorso alle sanatorie e l’enorme
numero di migranti che acquisivano il permesso di soggiorno
per questa via è stato lungi dal convincere il legislatore
italiano della necessità di rendere più facile il percorso
di ingresso degli stranieri. In
particolare il legislatore si è sempre rifiutato di
consentire la conversione del permesso di soggiorno per
motivi di turismo in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato o autonomo, qualora il migrante nel
periodo di permanenza sul territorio sia stato in grado di
mettersi nelle condizioni di accedervi. Questo passo sarebbe
stato di fondamentale importanza dato che, come riconosce il
governo nell’ultimo documento programmatico, la
maggioranza dei “clandestini” è rappresentata non da
migranti che si sottraggono ai controlli alla frontiere, ma dai
cosiddetti “overstayers”. Siamo cioè “in presenza di
un numero notevole di soggetti che, entrati legalmente,
permangono dopo la scadenza di visti o permessi di
soggiorno”.
Ad una politica di maggior apertura
certo non ostava la difficoltà di inserire i migranti nel
tessuto sociale e/o nel mondo del lavoro. La stabilizzazione
dei migranti regolarizzati con sanatorie a partire dal 1995
mostra che il contesto sociale e lavorativo italiano era in
grado di assorbire (e di fatto, al momento della
regolarizzazione, aveva già assorbito) un numero di
migranti molto maggiore di quelli cui era consentito
l’ingresso regolare. Il legislatore italiano non ha però
mai proceduto in questa direzione. Recentemente ha
addirittura intrapreso la strada inversa, rendendo sempre più
difficile l’ingresso dei migranti e procedendo
contestualmente alla più grande sanatoria fino ad oggi
effettuata.
Il
sistema predisposto dalla legge Martelli fissava due
principi regolativi dell’ingresso dei migranti, che sono
poi rimasti inalterati: perché il migrante potesse entrare
in Italia erano previsti un requisito soggettivo e uno
oggettivo. Dal punto di vista soggettivo il migrante doveva
dimostrare “la
disponibilità in Italia di beni o di una occupazione
regolarmente retribuita” (art. 3 comma 6). Dal punto di
vista oggettivo non doveva essere superato il limite di
ingressi fissato di anno in anno dal decreto previsto
dall’art. 2 comma 3 della stessa legge (questo meccanismo
era già previsto dalla legge 943 del 1986). Potevano dunque
entrare in Italia i migranti che avevano un lavoro, o
comunque un reddito, nel limite dei numeri fissati di anno
in anno dal decreto interministeriale. Un percorso agevolato
di ingresso avrebbe dovuto crearlo il meccanismo che è
stato definito dello “sponsor” previsto sempre
dall’art. 3 comma 6 della legge.
La norma stabiliva che l’immigrato
“sponsorizzato” poteva entrare in Italia alla ricerca di
un lavoro, previa accettazione da parte del Ministero
dell’interno della fideiussione da parte di un garante
pubblico o privato. Nel caso in cui lo straniero avesse
trovato un’occupazione il permesso di soggiorno sarebbe
stato modificato in permesso per lavoro, altrimenti alla
scadenza l’interessato avrebbe dovuto far ritorno nel
paese di provenienza.
Il
meccanismo disegnato dalla legge Martelli non è mai andato
a regime, perché i decreti flussi hanno di fatto consentito
l’ingresso solo per chiamata lavorativa nominale.
A testimonianza del mancato funzionamento della
“sponsorizzazione”, vigente la legge Martelli, sta il
fatto che il governo, nel “Documento programmatico
relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri
nel territorio dello Stato” del 2001 (approvato dal
Consiglio dei Ministri il 15-03-2001), considerava una novità
introdotta dalla legge 40 del 1998 “la procedura di
ingresso per ricerca di lavoro tramite uno “sponsor”,
italiano o straniero regolarmente soggiornante, che
garantisce per un anno la permanenza sul territorio
nazionale dello straniero”. Quindi
la necessità di ricorrere alle sanatorie potrebbe essere
ragionevolmente fatta discendere dal fatto che, prima
dell’approvazione della legge 40, in realtà non esisteva
un meccanismo di ingresso regolare in Italia diverso dalla
chiamata nominativa del datore di lavoro.
Con
la legge 40 del 1998, poi confluita nel testo unico
sull’immigrazione dello stesso anno (d.lgs 289 del 1998) e
il relativo Regolamento di attuazione (d.P.R. n. 394 del
1999), viene ribadito il meccanismo degli ingressi previsto
dalla legge del 1990 e viene regolato dettagliatamente il
meccanismo della “sponsorizzazione”, cui il governo
sembra attribuire un grande rilievo. Ma neppure la nuova
normativa ha garantito una reale corrispondenza tra capacità
di assorbimento del sistema economico-sociale italiano e
concessione dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno. Le oltre 700.000 domande presentate per la
sanatoria del 2002 mostrano che tra il 1998 e il 2002 un
gran numero di migranti è entrato e/o ha soggiornato
irregolarmente in Italia. Queste persone, sebbene
irregolarmente presenti sul territorio nazionale, si sono
inserite nel mercato del lavoro e nel contesto sociale,
tanto che al momento della sanatoria sono state in grado di
indicare un alloggio ed hanno trovato un datore di lavoro
disposto non soltanto ad assumerle,
ma addirittura a dichiarare che negli ultimi tre mesi
avevano lavorato per lui in nero e a metterle in regola sul
piano contributivo.
Ciò
che rasenta il grottesco nello sviluppo della politica in
materia di ingressi dal 1992 ad oggi, non è tanto la sua
miopia, ma il fatto che i documenti ufficiali del governo
tra l’approvazione della legge Turco-Napolitano e quella
della legge 189 del 2002 (la cosiddetta “legge
Bossi-Fini”) mostrano che lo stesso governo è pienamente
consapevole dei limiti e dei difetti della politica che sta
seguendo. La relazione di accompagnamento al decreto flussi
del 2001 (presentata il 14/3/2001) si segnala per un
notevole lapsus. Il governo sembra consapevole che i canali
di immigrazione clandestina sono gli unici effettivamente
disponibili. Infatti, parlando delle quote riservate ai
paesi con cui sono stati conclusi accordi di riammissione,
dichiara che esse servono a tener “aperto un canale di
immigrazione legale e controllato, alternativo a quello
clandestino fornito dai mercanti di esseri umani”
(corsivo mio). Nell’inconscio del governo sembra esserci
la consapevolezza che il canale normale di immigrazione è
la clandestinità e che vadano aperti anche dei
canali legali.
Nel
primo “Documento programmatico relativo alla
politica dell’immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato”, emanato a norma dell’art. 3
della legge n. 40 del 1998, con decreto del Presidente della
Repubblica del 5 agosto 1998, il governo sembrava
consapevole del fatto che era necessaria una
liberalizzazione degli ingressi per evitare l’immigrazione
clandestina. Ripercorrendo i dati del 1997, infatti, notava
che, assumendo come campione generale i circa
92.000 nuovi permessi rilasciati a cittadini provenienti da
paesi a forte pressione migratoria (Europa Centro-orientale,
America Centro-meridionale, Africa ed Asia ad esclusione di
Giappone e Israele), il permesso di soggiorno per motivi di
lavoro era solo il terzo tipo di permesso rilasciato. Per
motivo di lavoro erano entrati solo poco più di 16.000
immigrati (circa il 17%). Lucidamente il governo attribuiva
questa quota esigua al fatto che, vigente la legge Martelli,
l’ingresso per lavoro era “in pratica possibile quasi
esclusivamente solo in presenza di una richiesta di
assunzione nominativa da parte di un datore di lavoro”.
In
questo documento il problema dei limiti dei canali di
ingresso era chiaramente percepito. Il governo osservava con
sospetto che la quota maggiore (quasi 24.000, pari a circa
il 26% del totale) dei nuovi permessi di soggiorno era stata
rilasciata per turismo e annotava che essa, con ogni
probabilità, "nasconde" una certa quota di
ingressi di cittadini stranieri intenzionati a fermarsi in
Italia per motivi diversi dal turismo ma privi di quei
requisiti, quali la richiesta di ricongiungimento familiare
o la chiamata lavorativa, che consentono l’ottenimento di
titoli di soggiorno di ben diversa natura e durata (corsivo
mio).
L’impraticabilità
della strada di accesso rappresentata dal permesso per
motivi di lavoro emergeva, anche se il documento non lo
dice, anche dalla circostanza che la seconda tipologia di
permesso di ingresso più utilizzata era il ricongiungimento
familiare (nel ‘97 erano stati poco più di 23.000, circa
il 25 % del totale). Ancora nel 2001 il governo si mostra
perfettamente consapevole del problema e nel nuovo
“Documento programmatico” afferma che “per
pervenire ad un effettivo controllo dei flussi […] non è
sufficiente stabilire ‘a priori’ delle quote di
ingresso, ma è necessario prevedere delle norme che
consentano un ingresso regolare per facilitare l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro, così da scoraggiare un
afflusso clandestino di forza lavoro destinata a svolgere
lavoro ‘in nero’, che costituisce un fattore di
indebolimento della politica di programmazione dei flussi”.
Ci
si immagina che un governo, forte di queste consapevolezze,
sia ricorso in modo massiccio all’istituto che meglio si
prestava a eliminare il collo di bottiglia degli ingressi
legali: quell’istituto della sponsorizzazione che la legge
40 e il regolamento del 1999 avevano dettagliatamente
disciplinato. In effetti nel “Documento programmatico”
del 2001 il governo attribuisce grande rilevanza a questo
istituto che “consente ad un cittadino straniero, iscritto
in apposite liste tenute presso le Rappresentanze
diplomatiche italiane all’estero, di richiedere un visto
di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro,
dimostrando di avere la disponibilità di mezzi di
sostentamento per un ammontare di circa 4 milioni, una
copertura sanitaria, un alloggio idoneo e una somma
occorrente per il rimpatrio”. Nelle parole del governo la
sponsorizzazione dovrebbe rappresentare la soluzione dei
problemi di ingresso regolare, dato che essa consente “un
ingresso regolare per un anno ad uno straniero ad un costo
inferiore di quello richiesto dai trafficanti per un
ingresso clandestino”.
Se
però si analizzano i decreti sui flussi del governo di
centro-sinistra e in particolare l’uso che il governo ha
fatto dell’istituto della sponsorizzazione, prima che le
modifiche introdotte dalla legge Bossi-Fini lo abolissero,
si rimane molto delusi: il governo per due anni non utilizza
la sponsorizzazione e per consentire la regolarizzazione
degli stranieri già presenti sul territorio nazionale
centellina l’ingresso legale dei nuovi migranti. Il primo
campanello d’allarme si trova nel “Documento
programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e
degli stranieri nel territorio dello Stato” del 1998,
emanato prima di emettere il primo decreto flussi vigente la
nuova normativa. In questa sede, infatti, il governo
ipotizza di limitare l’uso della “sponsorizzazione”
(art. 21 legge 40 del 1998 e 23 T.U.) ai migranti
provenienti dai paesi con cui sono stati conclusi accordi di
reingresso. Contemporaneamente alla minaccia di limitare
l’uso di questo strumento per i migranti che ancora devono
giungere sul territorio italiano, il governo ipotizza, a
conferma del privilegio attribuito alla legalizzazione
mediante sanatoria, che “in via eccezionale, per il 1998 e, in parte minore, per il 1999, potrà
essere consentito, per un limitato contingente di lavoratori
presenti in Italia anche in situazione di irregolarità,
l’attivazione del meccanismo delle garanzie prestate da
terzi ai sensi dell’art. 21, con il rilascio di un
permesso di soggiorno per un anno ai fini di inserimento nel
mercato del lavoro”. Si ipotizza dunque di trasformare il
meccanismo principe di facilitazione degli ingressi regolari
in uno strumento di sanatoria.
Questi
due propositi delineano abbastanza chiaramente lo spirito
della politica migratoria seguita nei mesi successivi. Il
decreto del Ministro degli Affari Esteri per la
programmazione dei flussi emesso in data 24 dicembre 1997,
quindi ancora vigente la legge Martelli, consente
l’ingresso per lavoro a tempo indeterminato e determinato,
incluso quello stagionale, fino a 20.000 cittadini
extracomunitari. Emanata la legge 40/98, il governo, in
coerenza con quanto sostenuto nel “Documento
programmatico” del 1998, ritiene necessario integrare
questa quota e, in data 16 ottobre 1998, viene emanato un
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale si consente il rilascio di un permesso di soggiorno
per motivi di lavoro subordinato ed autonomo per altri
38.000 migranti. Però in questa quota vengono compresi
anche coloro che erano già presenti in Italia alla data
dell’entrata in vigore della legge 40/98, purché in
possesso di determinati requisiti (idonea occupazione
lavorativa subordinata o autonoma, disponibilità di un
alloggio).
In altre parole, il primo decreto flussi successivo alla
legge Turco-Napolitano stabilisce di utilizzare le quote
previste per l’ingresso regolare ai fini della sanatoria.
Il risultato è stato, come riconosce il “Documento
programmatico” del 2001, che nel 1998, a fronte di 58.000
posti teoricamente disponibili, sono effettivamente entrati
per svolgere attività di lavoro subordinato circa 28.000
stranieri a cui sono stati rilasciati regolari permessi di
soggiorno. Il minor numero di ingressi per lavoro registrato
nel 1998 rispetto alla programmazione è dovuto, in massima
parte, all’avvio delle procedure di regolarizzazione
attraverso l’emanazione del decreto flussi integrativo che
riservava, di fatto, la quota di ingressi ai possibili
regolarizzandi.
Inoltre
il primo decreto sui flussi, vigente la legge
Turco-Naplitano, non ha consentito l’utilizzo della
sponsorizzazione perché il Regolamento di attuazione è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo il 3 novembre
1999, circostanza che ha impedito l’utilizzo di questo
istituto la cui normativa, completamente ridisegnata, doveva
essere integrata appunto dal Regolamento. La tanto decantata
“sponsorizzazione” non viene utilizzata neppure l’anno
successivo, quando, ancora una volta, la sanatoria viene
anteposta al regolare ingresso. Il governo infatti decide di
attendere l’esito della sanatoria prima di emanare il
nuovo decreto flussi. Il 4 agosto, quindi quasi a tre quarti
dell’anno, viene emanata una Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri che stabilisce una quota di ingresso
pari a quella dell’anno precedente (cioè di 58.000 unità).
Ma nessuno di questi posti è usufruibile attraverso il
meccanismo della sponsorizzazione: 54.500 sono destinati a
lavoratori subordinati e 3.500 a quelli autonomi. In
conseguenza di queste scelte, nel 1998 e nel 1999 nulla è
cambiato rispetto agli anni precedenti: per entrare in
Italia serve di fatto la chiamata nominale (unica modesta
eccezione sono i 3.500 ingressi previsti per lavoro
autonomo). Come accadeva sotto la disciplina della legge
Martelli, gli ingressi regolari per ricongiungimento
familiare sono molto superiori a
quelli per lavoro subordinato: nel 1998, a fronte di 47.433
permessi di soggiorno rilasciati per ricongiungimento
familiare, figurano 26.063 permessi di soggiorno rilasciati
per lavoro subordinato. Nel 1999 questi ultimi sono 29.405,
contro 43.500 permessi per ricongiungimento familiare.
Nel
2000 viene emanato un decreto flussi
che sembra finalmente corrispondere al disegno della legge
Turco-Napolitano. Si prevedono 63.000 posti, così
suddivisi: 28.000 riservati alla chiamata diretta del datore
di lavoro per lavori a tempo determinato o indeterminato,
2.000 per lavoratori autonomi, 18.000 per lavoratori
provenienti dai paesi con cui erano stati sottoscritti
accordi di riammissione dei migranti irregolari, e
finalmente 15.000 per lavoratori assistiti da sponsor (senza
restrizioni sui paesi geografici di provenienza: “provenienti
da qualsiasi paese extracomunitario”). Nonostante i
timori del governo sull’utilizzo di questi ultimi posti,
essi andarono esauriti nei 60 giorni previsti.
Nel
2001 il governo sembra prendere atto dell’esperienza
dell’anno precedente che così sintetizza nella relazione
di accompagnamento del nuovo decreto flussi: eccesso di
domanda da parte delle imprese rispetto alle quote
dell’ultimo decreto flussi e velocità di esaurimento
quote anno precedente: i livelli massimi stabiliti dal
decreto flussi 2000 sono stati raggiunti con largo anticipo,
sia per lavoro subordinato, che per lavoro autonomo o
ricerca di lavoro, indicando una richiesta elevata.
Il
decreto flussi del 2001
contiene dunque meno vincoli: vengono aumentati gli ingressi
per lavoro subordinato che sono portati a 50.000, a cui
vanno aggiunti 33.000 ingressi per lavoro stagionale, e
vengono ridotti a 11.5000 i posti riservati ai paesi con cui
sono stati stipulati accordi di riammissione, ma vengono
nuovamente previsti solo 15.000 ingressi mediante
sponsorizzazione. Nella relazione di accompagnamento al
decreto il governo sembra quasi volersi giustificare per
aver previsto questa quota. A dispetto della rilevanza che
aveva attributo a questo istituto nel quadro delle politiche
migratorie e delle sue considerazioni sul rapido esaurimento
delle quote dell’anno precedente, il governo dichiara di
voler andare con i piedi di piombo nel suo utilizzo e di
voler sottoporre a verifica i suoi risultati. Si legge
infatti nella relazione: questa categoria di lavoratore
extracomunitario, pur prevista nella legge 40/1998, è stata
utilizzata per la prima volta solo nel 2000. Si tratta ora
di verificare gli esiti del primo anno di applicazione
tramite un’azione di monitoraggio che verrà effettuata
allo scadere dei 12 mesi concessi dalla legge per ricercare
lavoro. Il monitoraggio riguarderà sia l’inserimento
sociale e le soluzioni abitative che la verifica della
realizzazione concreta del progetto di lavoro.
La
previsione di una nuova quota di 15.000 ingressi per
migranti provvisti di sponsor è presentata come una
concessione eccezionale, invece che come il perno di una
politica tesa a favorire gli ingressi regolari. Il governo
afferma di essersi deciso a questo passo considerate “le
richieste delle associazioni di mantenere aperto questo
importante canale di accesso al mercato del lavoro, anche
alla luce del minore impatto sul territorio assicurato dalla
presenza dei prestatori di garanzia (i cosiddetti
sponsor)”.
Non
sorprende dunque che con la legge Bossi-Fini, nonostante la
grande massa di migranti irregolari che tutte le ricerche
segnalavano essere provocati dalla chiusura dei canali di
afflusso legale, il legislatore abbia abolito l’istituto
della sponsorizzazione, provocando, come rileva l’Istat
(2004, 12), una diminuzione dei permessi di lavoro al 1°
gennaio 2003 rispetto all’anno precedente. L’abolizione
dello sponsor non è l’unica previsione della legge
189/2002 che restringe il già angusto percorso di ingresso
legale nel nostro paese. La legge ha infatti subordinato
l’ingresso del migrante all’esistenza di un
pre-contratto di lavoro già firmato con il quale il datore
di lavoro garantisce la disponibilità di un alloggio
conforme alla normativa sull’edilizia popolare, nonché il
pagamento delle spese di rientro nel paese di origine. È
stata inoltre limitata la possibilità per uno straniero
regolarmente residente di ottenere un permesso di soggiorno
per motivi familiari per i suoi genitori.
Le
progressive restrizioni dei già angusti canali di accesso
regolari e le continue sanatorie fanno emergere una chiara
volontà politica di privilegiare il meccanismo del
soggiorno irregolare come strumento di inserimento sociale
dei migranti. I dati statistici e l’evoluzione normativa
mostrano chiaramente che governo e parlamento italiano
preferiscono che uno straniero cerchi un lavoro e tenti di
inserirsi socialmente partendo da condizioni di clandestinità
(e quindi privo di ogni garanzia e titolare di pochissimi
diritti), piuttosto che usufruendo della
“sponsorizzazione”, di un permesso di soggiorno per
turismo, per ricerca di lavoro o per residenza elettiva.
2.3.
Le forche caudine dell’illegalità: governare i
migranti attraverso il diritto penale
Le
progressive restrizioni dei già angusti canali di accesso
regolari e le continue sanatorie mostrano l’emergere in
tutta Europa una chiara volontà politica di privilegiare il
meccanismo del soggiorno irregolare come strumento di
inserimento sociale dei migranti. I dati statistici e
l’evoluzione normativa mostrano chiaramente una tendenza a
preferire che uno straniero cerchi un lavoro e tenti di
inserirsi socialmente partendo da condizioni di clandestinità
(e quindi privo di ogni garanzia e titolare di pochissimi
diritti), piuttosto che usufruendo di un permesso di
soggiorno per turismo, per ricerca di lavoro o per residenza
elettiva. La politica europea dell’immigrazione sembra
sempre più caratterizzata dall’uso dell’irregolarità
come una forca caudina, di fronte alla quale un gran numero
dei migranti deve abbassare la testa, se vuole riuscire ad
accedere alla condizione di regolarità. Il messaggio che le
politiche migratorie comunicano sembra essere: se un
migrante vuol entrare nella “fortezza Europa” deve
essere pronto ad affrontare un periodo di clandestinità e
forse anche a varcare clandestinamente la frontiera.
La
scelta di governare il fenomeno dell’immigrazione
attraverso le sanatorie ha naturalmente pesanti costi in
termini di sacrificio della legalità. E’ ovvio che la
presenza di una massa rilevante di “clandestini” (siano
essi migranti entrati irregolarmente o overstayers,
cioè soggetti che, entrati legalmente, permangono dopo la
scadenza del permesso di soggiorno) comporta un numero
enorme di azioni illegali (praticamente tutte o quasi quelle
compiute dai clandestini e da chi entra in relazione con
loro dandogli un lavoro, affittandogli una casa, eccetera)
ed un numero consistente di azioni penalmente sanzionate.
Infatti le persone presenti
irregolarmente sul territorio, solo per espletare le loro
esigenze vitali, incorrono inevitabilmente nella commissione
di irregolarità amministrative e di reati (o la causano):
essi, infatti, oltre a lavorare “in nero” con tutte le
evasioni contributive, assicurative e previdenziali che
questo comporta, spesso lavorano in mercati illegali,
falsificano documenti, non ottemperano all’ordine di
allontanarsi dal territorio nazionale o al divieto di non
farvi rientro e così via. I pochi dati disponibili relativi
all’Italia confermano lo stretto legame tra carcerazione e
irregolarità. Nel “Documento programmatico relativo alla
politica dell’immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato 2001-2003” il governo sostiene che
dalle segnalazioni pervenute al C.E.D. del Dipartimento
della P.S. il 30 settembre 2000 si ricava che il numero dei
detenuti stranieri titolari di permesso di soggiorno, in
rapporto al totale dei cittadini extracomunitari
regolarmente soggiornanti, era, infatti, più o meno
equivalente al dato relativo all’incidenza percentuale dei
detenuti italiani e stranieri regolarmente soggiornanti
rispetto al totale della popolazione. Il tasso di detenzione
degli stranieri non-comunitari regolarmente soggiornanti era
pari allo 0,10%, mentre quello della popolazione complessiva
regolarmente soggiornante (quindi stranieri titolari di
permesso di soggiorno e cittadini italiani) era dello 0,07%.
Questi dati trovano conferma nel “Rapporto sulla sicurezza
2004” redatto dal Ministero degli interni, da quale
risulta che su 611.000 persone arrestate nel corso del 2005
il 28,12% erano migranti irregolarmente presenti sul
territorio nazionale, mentre la quota di migranti regolari
è quasi irrilevante.
Se
esiste, dunque, una popolazione che statisticamente ha la
propensione a commettere reati puniti con la detenzione,
questa non è la popolazione dei migranti tout court,
ma la popolazione dei migranti privi di permesso di
soggiorno. Proporsi di regolare
l’accesso dei migranti allo status di persone legalmente
residenti attraverso il percorso “irregolarità-sanatorie”
vuol dire scegliere di governare i migranti attraverso il
diritto penale e il carcere. Il
rapporto tra irregolarità e criminalità ripropone la
domanda: perché i legislatori e i governi europei
preferiscono affrontare i costi sociali e politici della
criminalità dei migranti irregolari, piuttosto che
facilitare l’accesso regolare al territorio nazionale ed
elaborare politiche sociali capaci di farsi carico della
popolazione presente sul territorio?
3.
Un
nuovo paradigma di governo: dalla cittadinanza inclusiva alla cittadinanza escludente
Per
rispondere alla domanda, che le politiche di governo
dell’immigrazione europee fanno sorgere spontanea, credo
siano necessarie alcune premesse. In primo luogo la
situazione descritta mostra che le
società europee sono società liberali, cioè società
tolleranti, vocazionalmente aperte, che accolgono
identità collettive anche contrapposte le une alle altre,
società che accettano non solo comportamenti devianti, ma
tassi consistenti di illegalità che implicitamente
considerano fisiologici. Proprio queste caratteristiche
comportano che esse siano percorse da una costante ansia di
rassicurazione, permanentemente mobilitate al controllo di
ciò che, di volta in volta, percepiscono come
“rischioso”.
Una
discussione delle politiche adottate dalle società europee
contemporanee per integrare i migranti e le fasce sociali
marginali deve poi necessariamente tener conto del fatto che
gli Stati del vecchio continente
stanno facendo i conti con il progressivo indebolimento
della loro sovranità interna,
a fronte della forza della razionalità del mercato
globale. La loro “potenza”, ma direi la loro esistenza
in quanto entità che si possono definire ancora, in qualche
senso non solo formale, “sovrane”, dipende dal grado in
cui i loro abitanti investono sulla propria
“valorizzazione”,
rischiano il proprio capitale, sfruttano fino in fondo la libertà
d’azione che riescono a conquistarsi, afferrano tutte le chances che si presentano loro, sono, in poche parole,
opportunisti e cinici in un contesto di scarsità che non
offre a tutti le stesse possibilità. Ma governare cercando
di sviluppare queste capacità è quasi un ossimoro: vuol
dire cercare di gestire l’ingestibile,
di controllare ciò che non può, e non deve, essere posto
sotto controllo, cioè la libertà degli attori, libertà
dalla quale dipende la produzione e la circolazione della
ricchezza e, più in generale, lo scambio sociale
complessivo. La strategia neo-liberista, adottata per
uscire da questo vicolo cieco, fa
proprie forme economiche e gestionali che trattano la
libertà ora come un “costo” ora come un fattore di
“rischio”. Questa modalità di governo richiede
meccanismi sempre più sottili,
elastici e pervasivi di sorveglianza:
il controllo diventa lo strumento principale per gestire
“i rischi della libertà”, assunta a pietra
angolare dell’organizzazione economico-sociale.
Le tesi che Foucault ha sviluppato
nei corsi tenuti al Collège de France tra il 1977 e il 1979
mi sembrano uno strumento essenziale per analizzare le
modalità di integrazione sociale che in questo momento
storico caratterizzano le società europee e il ruolo che il
carcere gioca in esse. In queste lezioni si trovano,
infatti, analisi che suggeriscono una
ragione profonda soggiacente alle politiche che negli ultimi
anni hanno portato molti paesi europei a lesinare la
concessione dei diritti di cittadinanza ai migranti. Per
circa un secolo, a partire dalla seconda metà
dell’Ottocento, l’integrazione sociale in Europa è
stata condotta attraverso una politica della cittadinanza
(intesa come paniere di diritti) inclusiva: caratterizzata
tanto da un progressivo aumento dei soggetti ammessi a
godere dei diritti di cittadinanza, quanto da un progressivo
allargamento del paniere di questi diritti. Oggi i governi
europei tendono ad adottare politiche di cittadinanza “eslcudenti”:
la percezione della necessità di ridurre progressivamente i
diritti sociali riconosciuti sembra aver creato la
predisposizione ad accettare l’idea che nei loro paesi
esista una larga fascia di soggetti privi di diritti, una underclass.
La tesi che propongo è che la ragione di questo mutamento
vada cercata nella percezione, non chiaramente tematizzata,
ma latente, che i fenomeni migratori hanno trasformato la
popolazione, ossia l’oggetto privilegiato dell’azione di
governo, da dato fisso legato ad uno specifico territorio, a
risorsa mobile, ampiamente selezionabile e manipolabile,
Questa trasformazione sta provocando una crisi strutturale
di quella che Foucault ha definito “biopolitica”, cioè
di quelle tecnologie che dalla fine del XIX secolo hanno
rappresentato lo strumento di governo delle società
europee.
3.1. Prendersi
cura della popolazione
Come
è noto, nella prima metà degli anni Settanta del secolo
scorso, Foucault concentra la sua attenzione sullo sviluppo
delle tecniche disciplinari. Queste sono presentate come
strumenti indispensabili di governo degli individui nelle
società moderne, incomparabilmente più complesse di quelle
dell’ancien régime. La sua analisi, in quegli
anni, è per molti versi parallela a quella di Gerhard Oestreich
che aveva sottolineato l’importanza del progetto disciplinare,
in particolare della Polizeiwissenschaft
dello Stato assolutista, considerando il suo sforzo
minuzioso di regolamentare la vita collettiva e
individuale come il presupposto della democratizzazione
politica del XIX secolo.
Foucault
(1975) sembra prendere sul serio la tesi di Tocqueville
(1840, tr.
it. 303), che nella De la démocratie en Amérique,
studiando il primo grande regime liberal-democratico, aveva
affermato che il potere che “faceva presa sui corpi”,
che aveva garantito la sopravvivenza dei regimi
assolutistici, non è adatto alle liberal-democrazie: per
governare questi regimi non serve un potere cruento, ma un
potere capace di “far presa sulle anime”. La disciplina,
cioè il sistema di pratiche che investe il corpo del
singolo individuo per renderlo socialmente compatibile ed
economicamente produttivo, è la tecnologia attraverso cui
si esprime questo potere. Tocqueville
osserva che con il passaggio dai regimi dispotici, fondati
sulla coercizione, ai regimi liberal-democratici, fondati
sul consenso, si avverte con forza l’esigenza di
addestrare i soggetti ad essere dei buoni cittadini.
Nell’esercizio dei propri diritti, gli individui devono
comportarsi secondo criteri morali e razionali (i due
termini per il contrattualismo illuminista sono in larga
parte sinonimi): la “disciplina”
conforma gli individui ai criteri dell’ordine in cui si
trovano inseriti.
Le
tecnologie disciplinari e la scienza della polizia hanno
come obbiettivo garantire il benessere della popolazione e,
attraverso questo, la potenza dello Stato. Nel
corso del secolo XVIII si sviluppa un sapere, chiamato dai
tedeschi Polizeiwissenschaft, che consisteva ne
“la teoria e l’analisi ‘di tutto ciò che tende ad
affermare e ad aumentare la potenza dello Stato, a fare un
buon uso delle sue forze e a procurare la felicità dei suoi
sudditi’ e, principalmente, ‘il mantenimento dell’ordine
e della disciplina, i regolamenti che tendono a rendere la
vita comoda ai sudditi e a fornire le cose di cui hanno
bisogno per vivere’”. A questo sapere lo Stato affidava
le sue possibilità “di determinare e di migliorare la sua
posizione nel gioco delle rivalità e delle concorrenze tra
gli Stati europei e garantire l’ordine interno con il
‘benessere’ degli individui” (Foucault 1979, 79):
L’interesse
di uno stato di polizia [police]
riguarda ciò che fanno gli uomini, la loro attività,
la loro “occupazione”. L’obiettivo
della polizia [police]
è il controllo e la presa in carico dell’attività
degli uomini in quanto tale attività può costituire un
elemento differenziale nello sviluppo delle forze di uno
stato (Foucault 2004a 329-330).
La
polizia [police], infatti, è l’insieme delle tecniche, degli interventi e dei mezzi che
assicurano che il vivere, il fare di più che semplicemente
vivere, cioè il coesistere, il comunicare, saranno
realmente convertibili in forze di stato, cioè saranno
effettivamente utili alla costituzione e all’incremento
delle forze dello stato. Con la polizia [police] quindi si disegna un cerchio che parte dallo stato, come potere di
intervento razionale e calcolato sugli individui,
e ritorna allo stato, come insieme di forze in crescita o da
far crescere, passando per la vita degli individui, che ora,
in quanto semplice vita, diventa preziosa per lo
stato (Foucault 2004a 334).
Tanto
secondo l’analisi di Foucault che per quella di Oestreich,
le tecnologie disciplinari si rivolgono ai singoli
individui. E’ il singolo individuo che viene osservato e
sorvegliato. Il suo comportamento vagliato, analizzato,
esaminato. Il movimento del suo corpo nello spazio
scomposto, e poi razionalizzato, reso più efficiente. Perno
della disciplina è un addestramento ad un costante
auto-esame, il soggetto disciplinato è quello capace da
solo di normalizzare le sue azioni e le sue reazioni.
La disciplina dunque muove dalla singolarità individuale
per rendere anonimi gli individui perché autoconformatisi
ad uno schema generale.
3.2.
Dalla disciplina alla
“governamentalità”
La
disciplina fabbrica individui partendo dai corpi che essa
controlla. Nella prima metà degli anni settanta Foucault,
come Oestreich, sembra convinto che essa sia in grado di
risolvere il problema dell’ordine garantendo
l’adeguamento del comportamento individuale a quello
collettivo. A
partire dalla fine del Settecento, secondo l’analisi che
Foucault sviluppa in Surveiller et punir,
ci si rende conto che per creare una società
liberal-democratica stabile è necessario apprestare una
serie di istituzioni “disciplinari” -- non solo i
penitenziari, ma anche i manicomi, gli ospedali, le scuole,
ecc. -- in grado di produrre il tipo di cittadino adatto al
nuovo sistema politico.
Nei
corsi tenuti nel 1977/78
(“Sécurité, territoire, population”) e
nel 1978/9 (“Naissance
de la biopolitigue”) Foucault sembra muovere dalla
constatazione del fallimento delle tecniche
disciplinari. Il tema centrale dei corsi sembra, da un lato,
l’incapacità del progetto disciplinare di raggiungere
l’obbiettivo di rendere gli individui ordinati e
produttivi, dall’altro l’analisi di una tecnologia di
governo che, prendendo consapevolezza dell’insufficienza
della disciplina, si affianca alle politiche incentrate su
di essa, finendo per renderle marginale. Questa tecnologia
è definita da Foucault “governamentalità”.
Paradossalmente, secondo Foucault, la nuova strategia di
governo utilizzata dagli Stati per aumentare la loro potenza
si dipana non attraverso meccanismi di assoggettamento degli
individui sempre più rigorosi, ma attraverso una
limitazione del potere di controllo delle burocrazie dello
Stato moderno.
Attraverso
l’introduzione dei termini bio-potere
e bio-politica Foucault
presenta questo passaggio non come un cambio repentino di
programma di ricerca, ma come un progressivo allargamento
del suo sguardo che da una tecnica di governo, la
disciplina, estende il proprio orizzonte fino a
ricomprenderne un’altra che ad essa si affianca:
Con
la scoperta dell’individuo e la scoperta del corpo
addestrabile, la scoperta della popolazione è l’altro
grande nucleo tecnologico intorno a cui si sono trasformati
i procedimenti politici dell’Occidente. E’ stata
inventata quella che chiamerei, in opposizione all’anatomo-politica
di cui parlavo prima, la bio-politica (Foucault 1976, tr. it. 164).
In
effetti la sua analisi dei dispositivi “biopolitici”
mette a fuoco una presa in carico di un corpo sociale che
sempre più emerge come “popolazione”, non riducibile ai
corpi individuali che la compongono. Oggetti della
biopolitica sono i problemi della natalità, della mortalità,
della longevità (Foucault 1997, 156-7), intesi non come
problemi dei singoli individui, ma come dati statistici che
evidenziano lo stato di benessere della popolazione.
Per
Foucault la “biopolitica” nasce quando, con la crisi del
sistema feudale, entra in crisi anche “la maniera di
governare e di governarsi”. In questo periodo si assiste
alla nascita di nuove forme di rapporti economici e sociali,
di nuove strutture politiche e di un nuovo tipo di soggetto.
Il perno della nuova modalità di gestione del potere, la
“biopolitica” appunto, è rappresentato da uno spostamento
di accento dal territorio alla popolazione e, quindi,
dall’apparizione di nuovi obiettivi e, dunque, di nuovi
problemi e di nuove tecniche di governo (Foucault 1979, 74).
Lo
spostamento dell’attenzione dal territorio alla
popolazione è collegato all’affermarsi del sistema di
Vestfalia. Foucault sottolinea che il fenomeno si verifica
quando, tramontato il sogno di ricostruire la Roma
imperiale, si afferma una nuova percezione storica che non
mira più all’unificazione di tutte le sovranità nate
dalla disgregazione dell’impero, ma è consapevole che i
nuovi Stati devono lottare gli uni contro gli altri per
assicurarsi la sopravvivenza. L’emergere della popolazione
come oggetto principale del governo è collegato con la
percezione che ciò che sta diventando importante, per la
legittimità del potere di un sovrano su di un territorio,
è la conoscenza e lo sviluppo delle forze su cui può
contare uno Stato. Quando il mondo si profila come uno
spazio in cui si esplica la concorrenza tra Stati, il
problema principale diventa quello delle tecniche razionali
che permettono di sviluppare le forze dei singoli Stati. In
questo contesto si sviluppano due nuove tecniche di gestione
del potere. Da un lato nasce “una tecnologia
diplomatico‑militare che mira ad assicurare e sviluppare
le forze dello Stato con un sistema di alleanze e
l’organizzazione di un apparato militare”. I Trattati di
Vestfalia, che mirano a cristallizzare un equilibrio
europeo, sono il prodotto più importante di questa
tecnologia politica. Dall’altro nasce la “polizia” [police],
“intesa nel senso che si dava allora a questo termine,
vale a dire l’insieme dei mezzi necessari per far
crescere, dall’interno, le forze dello Stato”. Oggetto
di queste due tecniche di potere è la coppia
popolazione‑ricchezza: dall’arricchimento mediante
il commercio ci si attende la possibilità di aumentare la
popolazione, la mano d’opera, la produzione e l’esportazione,
e quindi la possibilità di dotarsi di eserciti forti e
numerosi (Foucault 1979, 76-7).
La
biopolitica nasce e si sviluppa per la convinzione che la
popolazione è “naturalmente” dipendente da molteplici
fattori che possono essere modificati artificialmente. Essa
è quindi un problema “politico”, governabile attraverso
la tecnologia della “polizia” a cui viene affidata la
gestione del problema popolazione‑ricchezza nei suoi
differenti aspetti concreti: fiscalità, carestia, spopolamento,
ozio‑mendicità‑vagabondaggio.
Il
passaggio dal disciplinamento dell’individuo al governo
della popolazione è presentato quasi come una naturale
estensione dell’ambito dell’attività di polizia, in
quanto attività mirata a creare le condizioni perché
“l’essere si converta in benessere”. La polizia,
sostiene Foucault, nel XVIII secolo si occupava di “tutto
ciò che va dall’essere al benessere, di tutto ciò che
il benessere è in grado di produrre al di là
dell’essere” (Foucault 2004a, 238). E’
l’attività di polizia che consente il passaggio dalla
sovranità alla biopolitica, che consente allo Stato di fare
il salto dal potere “di lasciar vivere e di far morire”
al potere “di far vivere e di lasciar morire”. Essa si
interessa all’uomo non in quanto essere dotato di virtù o
appartenente ad un certo ceto sociale, e neppure in quanto
detentore di ricchezze da sottoporre a prelievo fiscale.
Oggetto del suo interesse è l’attività svolta dagli
individui. La polizia nasce dunque come gestrice delle
tecnologie disciplinari ma a poco a poco ci si accorge che
la relazione di potere col soggetto o, più esattamente, con
1’individuo, non può basarsi soltanto sulla soggezione,
che permette al potere di prelevare al soggetto beni,
ricchezze e, eventualmente, anche il suo corpo e il suo
sangue, ma che il potere deve esercitarsi sugli individui in
quanto costituiscono una specie di entità biologica, che dev’essere
presa in considerazione se si vuole utilizzare la popolazione
come macchina per produrre ricchezza, beni o altri individui
(Foucault 1976, tr.
it. 164).
Secondo
la narrazione di Foucault, la polizia nella sua attività si
rende conto dell’insufficienza delle tecnologie
disciplinari individualizzati per garantire il benessere
della popolazione e gradualmente trasforma la propria
funzione: la scienza della polizia “diviene il calcolo e la tecnica
che permettono di stabilire una relazione mobile –
ma, ciò nonostante, stabile e controllabile – tra
l’ordine interiore dello stato e la crescita delle sue
forze” (Zanini 2006, 126).
Le
tecniche di governo che Foucault connota con il termine
“biopolitica” sono dunque caratterizzate dall’idea che
la popolazione non è la semplice somma dei soggetti che
abitano un territorio, una somma che sarebbe il risultato
della volontà, da parte di ciascuno, di avere dei figli o
di una legislazione che favorirebbe o scoraggerebbe le
nascite. La popolazione è una variabile dipendente da un
certo numero di fattori che non sono esclusivamente naturali
(il sistema delle imposte, 1’andamento della circolazione
monetaria e la ripartizione del profitto sono determinanti
essenziali del tasso di popolazione) (Foucault 1979, tr.
it. 78).
Le
tecnologie biopolitiche non configurano la popolazione come
un insieme di soggetti di diritto, ma neppure come un mero
agglomerato di braccia destinate al lavoro (anche se questa
riduzione si può riscontrare in alcune teorizzazioni di
fine settecento, per esempio quella di Bentham). Come
sottolinea Foucault (1979, 79) la popolazione è vista
“come un insieme di elementi che, da un lato, è collegato
al regime generale degli esseri viventi (la popolazione
appartiene alla ‘specie umana’, nozione nuova per
l’epoca e da distinguere da quella di ‘genere umano’)
e, dall’altro, può costituire il punto di applicazione
per interventi concertati (con la mediazione delle leggi,
ma anche attraverso mutamenti delle abitudini, dei modi di
fare e di vivere, che si possono ottenere con le ‘campagne’)”.
Nella
trasformazione della Polizeiwissenschaft in
“biopolitica” trova le proprie origini il Welfare
state. L’apparato dello Stato sociale nasce con
l’affermarsi della convinzione che per amministrare la
popolazione occorre ridurre la mortalità infantile,
prevenire le epidemie, assicurare attrezzature mediche sufficienti,
intervenire nelle condizioni di vita degli individui
imponendo norme relative all’alimentazione, alla gestione
dell’ambiente o all’organizzazione delle città. Le
radici del Welfare
state affondano nel progressivo emergere della necessità
che lo Stato si faccia carico della gestione della
popolazione, al fine di assicurarne il benessere ed
aumentare in questo modo la propria potenza economica e
militare. La diretta connessione tra la presa in carico
della popolazione e la potenza di uno Stato emerse con
grande evidenza con le difficoltà che i coloni Afrikaner
crearono all’Inghilterra, massima potenza coloniale
dell’epoca, nelle due Guerre
Boere (1880-1881 e 1899-1902). Non è un caso che
fu proprio in Inghilterra
che, alla fine del XIX secolo, cominciarono ad emergere le
prime strutture dello Stato sociale. Anche nella Germania
bismarkiana il primo embrione di Stato sociale si andò
strutturandosi sotto la pressione delle politica aggressiva
sviluppata dalla Prussica a fine Ottocento. Questa forma di
governo della popolazione nel corso del XX secolo sembrò
capace tanto di soddisfare le esigenze di potenza degli
Stati quanto di “gestire” le rivendicazioni del
movimento operaio. Grazie a questa capacità con le due
guerre mondiali essa si affermò in tutta Europa, per
consolidarsi come strumento essenziale di ricostruzione
economica nel corso del secondo dopoguerra.
Collegando
le istituzioni disciplinari allo sviluppo, dalla seconda metà
del secolo XVIII in poi, di ciò che fu chiamata medizinische
Polizei, hygiène publique, social medicine, Foucault
traccia il quadro generale di “una biopolitica che tende a
trattare la ‘popolazione’ come un insieme di esseri
viventi e coesistenti che presentano tratti biologici e
patologici particolari e, di conseguenza, dipendono da
saperi e tecniche specifiche” (Foucault 1979, 80). Il Welfare
state non è che l’ultima metamorfosi delle tecnologie
biopolitiche: è l’ultimo dispositivo tecnologico
attraverso cui gli Stati hanno cercato di prendersi cura
della popolazione per aumentare la loro potenza economica (e
militare).
Foucault
presenta quindi una narrazione continuista facendo leva sul
dato che la gestione di una popolazione non si effettua
governando i fenomeni globali, ma implica interventi in
profondità che vanno a modificare i dettagli dei
comportamenti, implica, in altre parole, che governo e
disciplina si coordinino e non si oppongano l’uno
all’altra.
Non
bisogna quindi leggere il processo in termini di sostituzione
di una società di sovranità con una società di
disciplina, a sua volta rimpiazzata da una società,
diciamo, di governo [gouvernement].
In realtà
siamo di fronte a un triangolo: sovranità, disciplina e
gestione di governo [gestion gouvernementale]; obiettivo
principale della gestione di governo è la popolazione, e i
suoi meccanismi essenziali sono i dispositivi di sicurezza (Foucualt
2004a, 111).
Concettualmente
però il salto è enorme: le tecniche disciplinari prendono
in carico la popolazione intesa come un insieme di individui
resi adatti, abili e pronti a compiere le funzioni che la
società richiede, ma la cui individualità si esaurisce
nell’abilità acquisita. I membri della popolazione sono
in sostanza soggetti passivi che rispondono meccanicamente
alle sollecitazioni che vengono dall’esterno. La società
disciplinare non prevede che ci si possa servire “in
maniera attiva del loro atteggiamento, della loro opinione,
del loro modo di fare”. Mentre la disciplina penetra il
reale sino al dettaglio per impedire, ostacolare o reprimere
ciò che non si conforma ad una norma prestabilita; la
“governamentalità” favorisce o suscita delle
dinamiche, degli eventi e dei comportamenti cercando di
mantenerli entro limiti mutevoli e strategicamente
funzionali (Pandolfi 2006, 97-8).
Mettendo
a fuoco le tecnologie disciplinari Foucault aveva spostato
l’attenzione dal problema hobbesiano della fondazione e
della legittimazione del sovrano, ai processi di assoggettamento
e di dominazione, alle strategie locali per mezzo delle
quali il potere investe i corpi e plasma gli individui.
Aveva messo in ombra il problema della legittimazione dei
vertici statali, le teorie contrattualiste e quelle
costituzionali, per analizzare le modalità di esercizio del
potere nelle carceri, negli ospedali, nei manicomi laddove
il suo esercizio non si richiama a nessuna norma giuridica
legittimante. Questo radicale spostamento del cuore del
problema dell’ordine politico assumeva, comunque, la
sovranità dello Stato come suo perno centrale: era la
“ragion di Stato”, la capacità dello Stato di aumentare
la propria potenza nell’arena della politica
internazionale, a costituire, ad un tempo, il metro di
valutazione del funzionamento delle tecnologie disciplinari
e la bussola che guidava la loro diffusione. Con il ricorso
alla nozione di “governamentalità” si fa più netta la
presa di distanza dalla riflessione filosofico-politica
incentrata sul problema della genesi (e della
legittimazione) del sovrano. Foucault, infatti,
introducendo questo concetto assume che, a partire dalla
fine del XIX secolo, il metro di valutazione delle tecniche
di governo cessa di essere un metro “politico”, relativo
alla sfera statuale: il successo della tecnologia di governo
non si desume più dal fatto che siano stati prodotti dei
buoni cittadini che contribuiscono con la loro opera alla
potenza dello Stato. Il criterio di “veridizione” delle
politiche diventa economico, il mercato assurge a giudice
del successo o meno delle tecniche di governo: “L’introduzione
dell’economia all’interno dell’esercizio politico, sarà
questa, credo la posta in gioco essenziale del governo” (Foucault
1978, tr. it. 17).
L’ottica
foucaultiana porta a vedere questo processo come uno
sviluppo lineare che allontana progressivamente la tecnica
di governo dall’idea che il suo campo di azione sia
delimitato dalla legge che rappresenta allo stesso tempo la
volontà del sovrano e il suo limite. Sembra di essere di
fronte allo sviluppo del processo che, da un lato,
ridicolizza l’idea di un potere sovrano che si esprime
attraverso i divieti e le autolimitazioni, e, dall’altro,
mostra che il governo degli uomini è in effetti condotto
attraverso un potere capace di renderli produttivi, di
mettere a frutto le loro energie. Se la disciplina degli
individui si presenta come un esercizio del potere
eminentemente praeter legem, la “governamentalità”,
assumendo a punto di riferimento il mercato e l’economia
politica come scienza per la valutazione della propria
efficienza, dissolve totalmente la struttura della sovranità.
Essa è la tecnologia di governo che adegua l’esercizio
del potere alla centralità del mercato e rende, quindi,
estranea al governo l’idea stessa di una volontà sovrana.
Se il governo della popolazione va valutato in termini
economici questa viene in rilievo come un insieme di
portatori di interessi e di bisogni irriducibili e indipendenti, intangibili dalla
volontà del sovrano. Le tecnologie di governo non possono
far altro che regolare ed ottimizzare i rapporti e le
dinamiche che si sviluppano tra questi interessi (Foucault 1978,
tr. it. 25).
In
effetti l’oggetto della governamentalità, più che la
popolazione, è la libertà di muoversi sul mercato dei suoi
componenti. La creazione di un ambiente pensato per il
mercato, e non per la sicurezza degli individui, ha come
naturale conseguenza che i soggetti si pensano come attori
del mercato. Il soggetto viene trattato come
indisciplinabile titolare di un diritto ad agire come vuole,
il mercato si erge, ed è eretto, ad unico armonizzatore
delle libertà individuali, ai meccanismi regolamentatori si
chiede di “laciar liberi” e garantire che si sia
“lasciati liberi”. Questo ambiente non è neutrale: esso
“produce” il soggetto libero attore di mercato. Gli interventi governamentali, molto più occulti e altrettanto pervasivi
di quelli tradizionali, mirano a sostenere la logica di
mercato responsabilizzando gli individui per l’uso che
essi fanno della propria libertà e dell’autovalorizzazione
del “capitale umano”
di cui sono dotati (Foucault 2004a, 45), in una rapida enumerazione sostiene che riguardano “la produzione, la
psicologia, i comportamenti e i modi di fare di produttori,
acquirenti, consumatori…”). Attraverso la
regolamentazione dell’ambiente favorevole al mercato si
attua, in effetti, una forma di disciplinamento sui
generis che agisce “adeguando”
il soggetto al mercato: l’intera vita dei soggetti è
sussunta al mercato. Il soggetto che si pensa come “imprenditore
di sé”, non è il soggetto libero, ma il soggetto reso
libero dalla governamentalità.
Il
risultato paradossale è che la libertà che la
governamentalità garantisce è la libertà di muoversi sul
mercato, quella stessa che secondo Hobbes lasciava la
sovranità. Ciò che è cambiato è
che, mentre per Hobbes questa libertà derivava dalla
rinuncia del sovrano di regolamentare il mercato, oggi essa
“costituisce l’indice generale sotto il quale dovrà
venire collocata la regola destinata a definire tutte le
azioni di governo” (Foucault 2004b, 125). Lungi dallo
svilupparsi grazie al non intervento del sovrano, essa
richiede la mobilitazione dell’apparato statale per essere
garantita, o per essere garantita meglio che altrove. Quello
governamentale è uno Stato che al contrario di quello
hobbesiano non ha come propria ragion d’essere la
protezione degli individui. Assistiamo al capovolgimento
della funzione che Karl Polyani (1944) assegna alla
politica: essa non protegge gli individui dal mercato, ma il
mercato contro le ansie e le inscurezze che il suo operare
crea negli individui. L’economia del potere delle società
governamentali si esplica attraverso il mantenimento di un
delicato e sempre mutevole equilibro tra libertà e
sicurezza rispetto al pericolo, “tra la produzione della
libertà e tutto ciò che, producendola, rischia di
limitarla e di distruggerla” (Foucault 2004b, 65).
3.2. Governamentalità,
mercato e “popolazione”
Foucault
dunque tende a raffigurare disciplina e governamentalità
come forme simili di esercizio del potere, presentandole in
contrapposizione a sovranità e diritto. Questa
connotazione, tanto della disciplina e quanto della
governamentalità, come modalità di esercizio produttivo
del potere, gli consente di configurarle come due tecniche
di governo che operano in maniera sinergica riducendo sempre
più drasticamente lo spazio della sovranità a favore di
quello della “regolazione”. La popolazione è il campo
in cui questa sinergia si dispiega: essa, se si guardano gli
individui uti singuli, è il campo in cui si
dispiegano le tecnologie disciplinari, se la si guarda nel
suo complesso è l’oggetto delle tecnologie di governo
suggerite dall’economia politica. Le tecniche disciplinari
si sviluppano perché le società complesse non riescono ad
essere governate dal potere sovrano attraverso la legge.
L’affermazione del mercato, che espande progressivamente
il proprio ambito geografico, e la competizione tra Stati,
che si sviluppa all’interno del sistema di Westfalia,
rendono insufficienti le tecniche disciplinari e una scienza
di polizia che assume a suo riferimento la politica di
potenza condotta dallo Stato. La disciplina è sicuramente
una tecnica produttiva di potere, ma non consente allo Stato
di reggere la concorrenza economica che garantisce la sua
potenza, via via si fa strada l’idea che si deve lasciare
campo libero al mercato ed utilizzare l’economia politica
per misurare la produttività dell’intervento della
polizia. In questo modo la finalità generale dell’azione
di governo, ovvero il potenziamento dello Stato, può
oscillare, a seconda dell’evenienze, in un continnum
che comprende tanto le tecniche disciplinari quanto quelle
governamentali.
Questo
percorso di lineare allontanamento dalla sovranità, che si
esprime attraverso la legge, e di progressivo sviluppo di
tecniche produttive di governo nasconde però alcune
importanti rotture. In primo luogo gli individui che
compongono la popolazione sono assunti come soggetti che si
costituiscono, e si devono costituire, liberi dal
condizionamento delle meccaniche disciplinari, sono
soggetti, che almeno quando operano sul mercato, seguono le
ragioni dell’interesse e si muovono nei diversi
arcipelaghi sociali del mondo usando una libertà che deve
esser loro costantemente garantita, pena vederli dirigersi
verso altri lidi dove mettere a frutto le proprie energie. L’interesse che li guida, scrive Foucault (2004b, 223), è “una
forma di volontà, che è al tempo stesso immediata e
assolutamente sogettiva”. Tanto lo spazio delle
discipline è lo spazio di piena visiabilità garantita
dai dispositivi della
sorveglianza panoptica, quanto lo spazio della
governamentalità è lo spazio degli interessi che,
secondo l’insegnamento di Hayek, rende un peccato mortale
di ubris ogni tentativo di costruire uno sguardo
capace di renderlo intelleggibile per programmare un
intervento sulle sue dinamiche. E’ uno spazio refrattario
tanto alla sguardo del sovrano quanto a quello
dell’ispettore: esso non è, e non può essere, oggetto di
governo, ma metro di verifica dell’utilità sociale
proprio delle funzioni di governo (Foucault 2004b, 52-3 e
231-32). Lo
spazio della governamentalità inverte il rapporto tra Stato
e mercato che ancora lo spazio disciplinare presupponeva:
nello spazio governamentale si sviluppa “uno Stato sotto
la sorveglianza del mercato, anziché un mercato sotto la
sorveglianza dello stato” (Foucault 2004b, 120). Siamo di
fronte ad un laissez
faire in cui il mercato non è più un principio di autolimitazione del
governo, che il sovrano sceglie nella sua autonomia
politica, ma “una sorta di tribunale economico che
pretende di misurare l’azione del governo rigorosamente in
termini di economia e di mercato” (Foucault 2004b, 253).
La
previsione di Foucault sembra essersi avverata. Oggi la
globalizzazione dei mercati finanziari è sempre più spesso
presentata come una forza irresistibile che gli Stati devono
necessariamente assecondare, rinunciando al governo
dell'economia. Allo stesso tempo si è diffusa un'ideologia
(Scott 1997) secondo cui il nuovo mondo del capitale nomade,
in cui sono saltate tutte le barriere create dagli Stati,
renderebbe la vita di tutti migliore. La libertà, in primo
luogo di commercio e di movimento dei capitali, sarebbe
l'humus che permette alla ricchezza di crescere come non ha
mai fatto, beneficiando tutta la popolazione mondiale. Ci si
va convincendo in sostanza che il mercato è senza ombra di
dubbio il migliore allocatore delle risorse e quindi il suo
funzionamento di grandissima importanza per il benessere
dell'intera umanità e la stabilità dell'organizzazione
sociale planetaria.
Il
mercato sembra aver ottenuto la sua vittoria definitiva: ha
rotto gli argini che lo iscrivano all’interno della
sovranità statale, sono le sovranità statali ad essere
iscritte all’interno della logica del mercato. Si inverte
il rapporto tra ragion di Stato e mercato: fino a ieri era
la ragion di stato definire le modalità di sviluppo del
mercato per assicurare la potenza dello Stato; oggi è il
funzionamento del mercato che definisce i limiti in cui può
operare la ragion di Stato per assicurare la potenza dello
Stato stesso. Una tale inversione implica un cambiamento
profondo: fino a quando il mercato si riusciva a sviluppare
grazie agli interventi di un governo guidato dalla ragion di
Stato il suo sviluppo coincideva con lo sviluppo del
benessere di una popolazione data, attraverso la scienza di
polizia prima e il Welfare state dopo. La potenza
dello Stato era legata alla capacità di sviluppare
politiche di cittadinanza inclusiva, fondate sulla
progressiva espansione delle fasce della popolazione ammesse
a godere dei diritti e dei servizi sociali. Quello che
Foucault non aveva previsto è che, con la globalizzazione
dei mercati (compreso il mercato del lavoro), la popolazione
diventasse anch’essa una risorsa “mondiale”, non più
legata ad una specifica sovranità: la popolazione è una
delle tante risorse che deve circolare liberamente e non più
un’entità definita dalle tecniche biopolitiche.
In
effetti la governamentalità cessa di essere una modalità
di governo della popolazione in senso stretto. Per
riprendere la terminologia di Tocqueville, essa non è una
modalità di esercizio del potere che esercita la sua presa
sull’anima, come la disciplina. Se la sovranità è la
modalità di governo di un territorio, la disciplina degli
individui, la governamentalità regola non la popolazione,
composta da soggetti “intangibili”, che devono essere
“lasciati fare” (Foucault 2004b, 220), ma l’ambiente
in cui essa vive. Il governo della popolazione è un governo
mediato, il potere in effetti interviene sull’ambiente in
cui si sviluppano le relazioni di mercato cercando di
favorire il gioco della domanda e dell’offerta, le
dinamiche dello scambio, la valorizzazione o la svalutazione
delle risorse umane disponibili, la concorrenza.
L’azione di governo mira all’ottimizzazione delle
condizioni che consentono l’esercizio di un libero agire
di un soggetto, non disciplinabile, ma sensibile alle
variazioni delle opportunità strutturali offerte
dall’ambiente in cui si trova ad operare.
A
dispetto della ripetuta affermazione di voler tagliare la
testa al re, di voler estromettere la sovranità
dall’analisi del governo, le tesi di Foucault
presuppongono un ruolo forte della sovranità statale: ciò
che distingue la popolazione dalle altre merci che circolano
sul mercato è il fatto che essa è oggetto delle politiche
dispiegate dagli Stati sovrani. E’ questo dato che
costituisce la “popolazione” in quanto entità distinta
dalla “mano d’opera”, è questo dato che permette di
rappresentare politiche disciplinari e politiche
governamentali come un continuum. Ma nel momento in
cui il mercato diventa il frame della ragion di
Stato, esso non lascia più il tempo per “farsi carico
della popolazione”. Le persone circolano in tempi rapidi,
come le merci, se non rapidissimi come le risorse
finanziarie: questo comporta non solo il superamento dei
lentissimi meccanismi disciplinari, ma anche di quelli
biopolitici, inesorabilmente lenti, rispetto alla velocità
del mercato. Le tecnologie biopolitiche, come i
meccanismi disciplinari, hanno come fine la potenza dello
Stato, mirano al consolidamento della sua potenza, e
quindi, nozione che a Foucualt non piace, della sua
“sovranità”. Sotto questo profilo l’economia, la
centralità del mercato, non sembra mettere in discussione
l’idea di ragion di Stato, limitandosi a fornirle un nuovo
parametro. Essa però finisce per rendere impraticabili
tanto le tecniche disciplinari quanto quelle miranti al
controllo della popolazione. Il mercato può essere
assunto come frame in cui iscrivere l’esercizio
della sovranità, ma questa iscrizione sembra cancellare
l’idea di una popolazione presa in carico dallo Stato.
La
biopolitica si fonda sull’assunzione che ogni Stato ha una
data popolazione e deve intervenire su di essa, regolando i
meccanismi della nascita e della morte e stabilendo le
condizioni della vita: attraverso il biopotere lo Stato
regola le nascite, disciplina le vite e proceduralizza le
morti. Con le grandi migrazioni che negli ultimi decenni
hanno investito gli Stati europei viene meno la popolazione
intesa come insieme di individui predefinito su cui
intervenire regolando la nascita o la morte. Paradossalmente
l’avverarsi delle previsione di Foucualt sull’emergere
del mercato come elemento di “veridizione” delle
politiche, fa venire meno la nozione che egli pone al centro
della sua analisi. Oggi lo Stato non è in grado di
“governare” la popolazione nel senso che Foucault dà a
questo termine. Essa è diventata un insieme continuamente
ridefinibile attraverso l’accoglimento l’espulsione dei
migranti e la marginalizzazione dei cittadini. Questo
mutamento stravolge le fondamenta della biopolitica,
modifica radicalmente il problema dell’ordine politico e
sociale. Grazie alle migrazioni la manipolabilità della
popolazione è aumentata a dismisura. Lo Stato può
selezionare con molta più facilità la propria popolazione:
può costruire, attraverso una serie di meccanismi ora
inclusivi ora escludenti, una popolazione di soli attori
capaci di stare sul mercato, senza bisogno di
“disciplinare” gli appartenenti ad una sua supposta
popolazione predeterminata che se ne dimostrano incapaci, o
di predisporre l’ambiente che li porti a pensarsi, e
quindi da agire, come imprenditori. Non è più necessario
produrre i “buoni” cittadini o gli “utili”
imprenditori di se stessi: basta selezionarli.
3.3.
Selezionare la popolazione
L’invito
a praticare una politica di selezione della popolazione
migrante, ma forse subdolamente anche quello di proseguire
con politiche che incoraggino l’immigrazione illegale a
scapito di quella legale, si trova in The
EU Economy 2005 Review. Rising International Economic Integration: Opportunities
and Challenges. La Commissione sostiene che
l’immigrazione può "greasing the wheels" of labour
markets. I
lavoratori migranti, infatti,
may ease labour shortages in areas in which nationals
do not want to work and, as they are often more
responsive than local workers to labour market conditions,
they may smooth the adjustment to regional differences or
shocks. Moreover, increasing human capital through
immigration would contribute to long-term growth, in
addition to the purely quantitative impact of increasing the
labour force. Indeed, attracting foreign talent is likely to
become an ever more important challenge, in particular for
migration policy (COM 2005, 12, corsivo mio).
La
Commissione suggerisce sostanzialmente un doppio binario nel
governo dell’immigrazione. Da un lato ci sono i
“lavoratori migranti”, giovani proveniente soprattutto
dall'Africa settentrionale, dalla Turchia e dal Medio
Oriente, che possono ingrossare le file dei migranti che
fanno i lavori rifiutati dai cittadini. Questi immigrati,
provenendo da paesi in cui un aumento incontrollato della
popolazione giovanile unito a un’elevata disoccupazione
darà abbondante disponibilità di lavoratori per decenni
futuri, sono pronti ad adattarsi a qualsiasi condizione il
mercato del lavoro offra. Si tratta di ragazzi che migrano
spesso già sapendo che
andranno a ingrossare le file dell’underclass,
che troveranno cioè,
da irregolari, un’occupazione saltuaria nel mercato
sommerso lavorando nel settore agricolo,
o nelle micro-imprese del settore edile, dei traslochi,
delle pulizie e dell’assistenza domestica.
Dall’altro lato, ci sono i “talenti” che possono
arricchire il capitale umano dello Stato ospite e che vanno
blanditi con l’accesso ad un paniere di diritti di
cittadinanza consistente.
I
suggerimenti della Commissione hanno trovato pronta
accoglienza in Francia dove la già ricordata nuova
normativa sull’immigrazione, approvata a maggio 2006,
prevede un nuovo permesso di soggiorno denominato “capacité
et talents”, di durata triennale, rinnovabile (ed esteso
anche ai familiari), riservato a studenti brillanti,
lavoratori fortemente specializzati, personalità e
studiosi, ritenuti capaci di contribuire “in modo
significativo e duraturo allo sviluppo dell'economia
francese o all'espansione della Francia nel mondo o allo
sviluppo del suo paese d'origine”. Presentando in
Parlamento questo nuovo permesso, Sarkozy ha sostenuto che
la Francia “ha il diritto di decidere quanti immigrati
devono entrare e sceglierli in base alla sua capacità di
accoglienza e ai suoi interessi”, specificando che
l'obiettivo è “attirare le competenze delle quali il
paese ha bisogno”. Una tale dichiarazione mostra
chiaramente che è un puro artificio retorico il riferimento
alla capacità delle persone, a cui viene attribuito il
permesso di soggiorno, di contribuire allo sviluppo dei
paesi di origine. Questo dato è stato subito colto dagli
esponenti politici Africani. Il presidente del Senegal
Abdoulaye Wade, ha protestato sostenendo che
"sceglieranno delle persone formate, come
intellettuali, ingegneri, medici" e aggiungendo: “io
spendo del denaro per formare le persone, ma quello che
faccio è un tantino assurdo: sto formando delle persone che
svilupperanno l'economia francese”. Anche il
rappresentante dell'Onu in Costa d'Avorio, Alpha Blondy, ha
criticato questo nuovo tipo di permesso di soggiorno
sostenendo che esso “riporta ai tempi dello schiavismo
quando i mercanti sceglievano i più vigorosi e quelli che
avevano i denti migliori”.
In
Gran Bretagna, insieme ad un piano di controllo elettronico
delle frontiere, si sta discutendo un sistema a punti per
cercare di privilegiare gli immigrati considerati più
“utili”. L’Italia, come abbiamo visto, non ha mai
sviluppato politiche capaci di attirare “talenti” dai
paesi terzi, ma ha immaginato fin dal 1990 di regolare i
flussi immigratori attraverso quote stabilite annualmente in
base alle esigenze del mercato del lavoro. La Spagna sta
muovendosi verso un sistema simile a quello italiano, è
infatti in discussione la proposta di dividere i permessi di
soggiorno per settori economici, in modo da favorire di
volta in volta l’afflusso di lavoratori per i settori più
bisognosi di manodopera.
Il
venir meno della convinzione che la popolazione sia una
risorsa data che va presa in carico e curata per aumentare
la forza dello Stato, la fine, in altre parole, della
biopolitica, spinge dunque verso una società in cui il
“biopotere” perde gran parte della sua rilevanza: verso
una società in cui la politica smette di prendere in carico
i soggetti sia singolarmente che collettivamente, di
dedicarsi a, o di predisporre l’ambiente per, la loro
trasformazione, e si limita a filtrarli e selezionarli.
Questo mutamento rappresenta una rottura traumatica
dell’ordine politico e sociale liberale così come lo
abbiamo conosciuto per oltre due secoli. Esso mette in crisi
tanto le “discipline” quanto le tecnologie
“biopolitiche” che hanno permesso il mantenimento
dell’ordine nell’epoca moderna. Questa fenomeno mette in
discussione, come afferma Foucualt (1979, tr.
it. 43) facendo però riferimento alla sola crisi
delle discipline, “la conoscenza stessa, la forma della
conoscenza, la norma ‘soggetto‑oggetto’, oltre a
interrogare i rapporti tra le strutture
economico‑politiche della nostra società e la
conoscenza (non nei suoi contenuti veri o falsi, bensì
nelle sue funzioni di potere‑sapere)”.
Siamo
di fronte ad “una crisi storico‑politica” che ci
ha lasciato, almeno per il momento, privi di modelli capaci
di guidare l’integrazione sociale. In questo quadro
l’inserimento sociale dei soggetti è pragmanticamente
considerato un esperimento, ed ogni esperimento va tenuto
sotto controllo. A questo fine si sono creati tutta una
serie di filtri selettivi: i soggetti vengono immessi nella
società, ma prima di immetterli a pieno titolo si controlla
che la società sia disposta a recepirli e, successivamente,
si controlla la loro interazione con la società stessa: se
la cosa non funziona, ci si lascia la possibilità di
estrometterli. La
resistenza ad ammettere sul territorio nazionale migranti
che fin dal loro arrivo sono titolari di un consistente
paniere di diritti, è allora perfettamente logica:
l’immediata concessione del permesso di soggiorno non
consente la “sperimentazione” dell’immigrato.
Altrettanto logica è la resistenza a concedere un permesso
di soggiorno che attribuisca la titolarità di questo
paniere di diritti per lungo tempo.
Se
la ragione governamentale non può e non deve essere
pianificazione delle attività della popolazione, ma solo
“programmazione strategica” delle condizioni che
favoriscono la libera competizione degli interessi
individuali, l’immigrazione irregolare, la
regolarizzazione selettiva, la precarietà dello status dei
migranti sono tutti strumenti ottimali per regolare una
popolazione che si trova sempre sospesa tra carenza
ed eccesso,
per governare una società in cui il lavoro salariato viene
considerato un’attività di impresa e la mobilità dei
migranti un investimento soggettivo sulle proprie capacità
di autovalorizzazione (Foucault 2004, 186-7 e 190-1).
Il meccanismo delle sanatorie, seguite dalla concessione di
permessi di soggiorno di breve durata, è invece
perfettamente coerente con questo nuovo modello di ordine.
Esso consente di verificare che sia ammesso a far parte
della popolazione dei titolari di diritti solo chi riesce a
farsi accettare e solo fino a quando vi riesce. Il percorso
tipico che devono compiere i migranti è caratterizzato
quindi da un periodo di clandestinità e marginalità in cui
i soggetti vengono messi alla prova: solo coloro che si
dimostrano “buoni cittadini”, che accettano cioè di
vivere senza garanzie, senza diritti e nella totale
precarietà, senza creare disturbo, vengono ammessi al rango
di “regolari” per poi continuare ad essere tenuti a
lungo sul filo del rasoio con permessi di soggiorno di breve
durata. Si crea dunque istituzionalmente marginalità sul
territorio dello Stato: la marginalità diventa una zona
sociale organizzata verso cui dirigere alcune fasce di
popolazione, diventa lo strumento di governo delle
migrazioni (e dei cittadini considerati “inadatti” alla
competizione economica).
4.
Dalla irregolarità alla criminalizzazione: il carcere come
filtro della popolazione
4.1.
Governare attraverso la criminalizzazione (dei migranti)
In
un quadro come quello descritto la politica si ritira in una
angolo e il suo ruolo sembra essere quello di garantire la
sicurezza di un restretto demos che vive nella polis
democratica, limitando i rischi provocati dal mercato (ma
non il mercato, che è globale e quindi per definizione
sottratto al controllo statale). La percezione
dell’inevitabile scarsità delle risorse utilizzabili
dallo Stato a scopi sociali, indotta dall’ideologia della
globalizzazione, ha diffuso la convinzione che la garanzia
dei diritti a favore delle maggioranze “autoctone” passi
necessariamente attraverso l’esclusione da questi diritti
dei soggetti migranti (e, in seconda battuta, dei cittadini
“non meritevoli”). temonos
In
questo contesto la criminalizzazione dei migranti sta
diventando una delle principali bandiere della
riunificazione della società (Melossi 2002, 259):
riunificazione realizzata a spese degli stessi migranti che
vengono usati come risorse del sistema produttivo e sono
esclusi allo stesso tempo dai circuiti assistenziali e
previdenziali. La maggioranza dell’opinione pubblica dei
paesi europei non potrebbe mai accettare che l’accesso ai
diritti di cittadinanza venga regolato sulla base di criteri
xenofobi o razzisti, non accetterebbe mai, in altre parole,
l’idea che i migranti debbano essere esclusi dai diritti
sociali perché di pelle nera o gialla, o perché hanno
usanze “incivili”. Né verrebbe facilmente accolta una
prospettiva puramente egoistica (con qualche venatura
schiavista): abbiamo poche risorse e quindi i migranti non
possono pretendere che noi rinunciamo alle nostre pensioni,
alla nostra possibilità di curarci, che sono già in
pericolo, per consentire loro un livello accettabile di
sicurezza sociale. Approcci di questo genere fanno presa
solo in alcuni settori minoritari, e spesso esasperati,
dell’opinione pubblica europea. Elevare a confine
dell’accesso dei diritti di cittadinanza il rispetto della
legge sembra invece asettico e politically
correct: non si può essere solidali con chi commette
dei crimini e attacca, spesso in modo violento, le persone e
i beni.
Abdelmalek “doppio”“buone
maniere”,Howard
Edwin ,atti
sociale
essa piuttosto una a conseguenza “logica”
dei comportamenti dei migranti stessi.
Il
meccanismo irregolarità-sanatorie appare funzionale non
solo alle logiche di mercato, ma anche alle logiche della
legittimazione politica. La condizione di illegalità dei
migranti, infatti, oltre a favorire il loro impiego con una
remunerazione irrisoria e a consentire la sopravvivenza di
imprese che non potrebbero permettersi di sopravvivere
retribuendo regolarmente i loro lavoratori, favorisce la
loro criminalizzazione. “proibiti”
come “droga” e “prostituzione”a Il radicamento a, nividuare ,, in un determinato territorio , e vi restano se effettivamente conquistarsi questi spazi
Riferendosi
agli Stati Uniti, Jonathan Simon (1997) ha sostenuto che
invece di governare la criminalità, si governa attraverso
la criminalità: la criminalità sarebbe usata dai
sostenitori dei programmi politici di tipo conservatore e
restauratore come uno strumento di creazione di egemonia e
di consenso. Forse sarebbe più corretto parlare di
“governo attraverso la criminalizzazione”, ma fatta
questa precisazione, l’idea di Simon coglie bene le
modalità con cui oggi in Europa si sta cercando di gestire
i migranti.
4.2. Verso una
dittatura della classe soddisfatta?
Loic
Wacquant (1999) ha parlato di passaggio dallo Stato sociale
allo Stato penale per descrivere il mutamento in atto: con
questo “slogan” Wacquant evidenzia che l’integrazione
sociale viene gestita sempre di più spesso attraverso
politiche penali e che il carcere assurge a sua matrice
fondamentale. Questa definizione, per quanto suggestiva, non
ci fornisce strumenti euristici per comprendere le
prospettive che abbiamo di fronte. L’analisi foucaultiana
della governamentalità evidenzia come sia strutturalmente
incompatibile con ogni forma di perequazione sociale una
tecnica di governo, che assume il mercato come parametro per
la propria valutazione. Non solo, infatti, una politica che
elegge il mercato a suo metro di valutazione non
può porsi come obiettivo la socializzazione dei
consumi e dei redditi. Essa deve anche essere consapevole
che il mercato ha bisogno
della disuguaglianza per funzionare: la
disuguaglianza (degli interessi, delle prestazioni, degli
scopi, delle remunerazioni, eccetera) è il motore della
concorrenza, che garantisce l’ottimizzazione della
funzione allocativa svolta dal mercato: “la concorrenza
basata sui prezzi presuppone e produce processi di
differenziazione; quindi, una politica sociale che si ponesse
come obiettivo una perequazione sociale, seppur relativa,
risulterebbe anti-economica, nel senso che violerebbe
i principi economici formali della stessa libera concorrenza”
(Zanini 2006, 138). Le
politiche governamentali quindi tutelano e riproducono uno
spazio differenziale che garantisca “la
molteplicità e la differenziazione delle imprese” (Foucault
2004,155): “La crescita economica […], di per sé, dovrebbe
garantire a tutti gli individui di raggiungere un livello di
reddito che permetta loro le assicurazioni individuali, l’accesso
alla proprietà privata, la capitalizzazione individuale o
famigliare, grazie a cui assorbire i rischi”(Foucault
2004, 150).
Sotto
questo profilo la governamentalità rappresenta
un’autentica rottura nella teorizzazione delle tecniche di
governo. Queste, infatti, mirano da sempre tutte, comprese
le tecniche disciplinari, a neutralizzare il conflitto
sociale. La governamentalità eleggendo il mercato, e quindi
la concorrenza, a propria bussola, ha invece bisogno del
conflitto,
non può mirare alla ricomposizione degli interessi dei
soggetti, il suo compito al contrario è quello di favorirne
la diversificazione. Questo metodo di governo crea un
ambiente rischioso, complesso, in gran parte percorso da
tassi ingestibili di illegalità che non possono essere
completamente neutralizzati perché esprimo i percorsi
individuali di soggetti che devono essere “lasciati
fare”, in quanto assunti come comunque produttivi di
ricchezza. E’ per neutralizzare questo ambiente che si
sviluppano politiche securitarie, che però devono essere
solo politiche di gestione dei pericoli, non di loro
neutralizzazione, dato che neutralizzare il pericolo
vorrebbe dire limitare la capacità del mercato di produrre
ricchezza. Lo Stato appare sempre meno legittimato a
definire i confini del mercato: non esiste più un mercato
legale e uno illegale o “nero”. Il mercato è globale
e in quanto tale fuori dal potere dei singoli Stati.
Il
rischio degli attori che si muovono su questo mercato, degli
imprenditori (spesso solo di se stessi) è socializzabile
esclusivamente nella forma del costo, si passa dalla neutralizzazione
del conflitto alla logica assicurativa.
Le socializzazione del rischio non può che essere
una sua privatizzazione, la tecniche governamentali non
possono indurre la società a occuparsi direttamente della
copertura dei rischi a cui gli individui sono soggetti;
possono solo riassegnarlo
al singolo soggetto, con l’auspicio che il mercato
garantisca ad ognuno un reddito sufficientemente elevato per
assicurarsi. La governamentalità inverte dunque la tradizionale tendenza-centripeta di
tutte le tecniche di governo, comprese quelle disciplinari,
delocalizzando presso i singoli individui la gestione del
rischio.
L’esempio
degli Stati Uniti, che per primi e più decisamente si sono
mossi lungo le nuove linee di politica criminale, mostra
come le nuove strategie penali, per quanto confuse e
tendenzialmente contraddittorie, hanno come denominatore
comune l’essere rivolte contro intere categorie sociali,
individuate normalmente in base alla loro marginalità
sociale e razziale, che vengono identificate come pericolose
(Santoro 2003). Questo dato non deve sorprendere: le nuove
politiche penali non fanno che rispecchiare la sclerosi di
quella che Peter Gloz (1986) ha definito “la società dei
due terzi”, una società cioè in cui una quota rilevante,
ma minoritaria, di individui è esclusa dal benessere e dal
possesso degli strumenti politici ed economici necessari per
raggiungerlo. Nei vari sistemi di welfare
i circuiti dello scambio politico ed economico hanno
presto operato una discriminazione sistematica fra gli
interessi protetti da organizzazioni dotate di un forte
potere contrattuale, quelli protetti da associazioni che non
occupano posizioni strategiche e, infine, quelli
“diffusi” che non dispongono di alcuna protezione
efficace. A questi fenomeni si somma, da almeno un ventennio
in Europa e da molto più tempo negli Stati Uniti, quello
dell’immigrazione di masse di diseredati, provenienti da
aree continentali caratterizzate da un tasso di sviluppo
scarso o nullo e da un’elevata densità demografica, alla
ricerca disperata dei vantaggi offerti dall’appartenenza a
“cittadinanze pregiate”.
Questa
situazione ha finito per dar vita ad una massa di soggetti
economicamente e politicamente molto deboli, esclusi
dall’effettivo godimento di quasi tutti i diritti. La
garanzia dei diritti a favore delle maggioranze e la
parallela necessità di restringere le garanzie sociali per
la crisi fiscale dello Stato ha trasformato, come ha
sostenuto John K. Galbraith (1992), le democrazie opulente
in “dittature di una classe soddisfatta”: i ricchi, gli
abbienti, i benestanti, che sono sempre esistiti, ma che in
passato erano minoranza e che oggi sono diventati
maggioranza. Costoro non sono più costretti a difendere i
propri privilegi favorendo il ricambio sociale: possono permettersi
l’immobilismo e rifiutarsi di dividere le risorse con i
nuovi poveri. Queste condizioni storico-sociali hanno
portato alla produzione in tutti i paesi europei di una
sottoclasse sociale più o meno estesa, spesso connotata
anche in termini etnici, cui è negato l’accesso legittimo
alle risorse economiche e sociali disponibili e che viene
rappresentata come pericolosa, percepita come una minaccia
per la sicurezza sociale e, in
conseguenza della sua esclusione,
per la sicurezza fisica e patrimoniale dei cittadini.
4.3.
Incarcerazione dei migranti e dualismo del sistema penale
In
società caratterizzate da una diffusa anonimità, la
distinzione tra il cittadino onesto e il “criminale” non
dipende tanto dalla condanna penale, quanto dalla pena
detentiva. L’opera di criminalizzazione degli stranieri
non potrebbe quindi reggersi senza un forte tasso di
carcerazione. Anche sotto questo profilo le politiche di
governo dei fenomeni migratori incentrate sul binomio
“permanenza irregolare/sanatorie” sono funzionali.
Questo binomio, infatti, permette di sovra-rappresentare gli
stranieri detenuti rispetto a quelli autori di reato. Se
molti migranti sono privi di uno status legale, all’alta
percentuale di stranieri detenuti non corrisponde
un’eguale percentuale di reati da essi commessi. I
meccanismi di deversion, probation, e parole
che, in forme diverse caratterizzano le modalità di
esecuzione penale in tutti i paesi comunitari, comportano
che sia molto più probabile che un migrante irregolare,
finisca in carcere, sia in esecuzione della pena che in
custodia cautelare, mentre un cittadino, o un migrante
regolare, per la stessa condanna normalmente sconta la pena
in misura alternativa, e se inquisito per lo stesso tipo di
reato evita la custodia cautelare in carcere, eccetera.
Questi meccanismi comportano che le condanne a pena
detentiva si trasformino in vera e propria carcerazione
soprattutto per gli stranieri irregolari. La difficoltà
dei migranti presenti illegalmente, in attesa di essere
regolarizzati, di dar conto di sé rispetto a una serie di
richieste, che vanno dal possesso dei documenti
d’identificazione a una residenza legale e stabile, a un
lavoro e/o un reddito, ha come conseguenza una più alta
applicazione nei loro confronti della custodia cautelare in
carcere. Da questa misura discende l’impossibilità di
scontare fin dall’inizio con modalità non detentive la
pena e, una volta in carcere, gli stessi fattori che hanno
portato all’applicazione della custodia cautelare
ostacolano la possibilità di usufruire delle modalità di
esecuzione della pena alternative alla detenzione.
Quest’uso
della detenzione segna una profonda cesura nella storia del
carcere. Con la fine della biopolitica il carcere è stato
capace di cambiare pelle e trasformarsi da perno del
disciplinamento, del reinserimento sociale degli elementi
riottosi, a fulcro dei meccanismi di selezione della
popolazione. Se, come scrive Foucault (1973, tr.
it. 40), “la forma‑prigione della penalità
corrisponde alla forma‑salario del lavoro”, forse si
può dire che la forma-precariato (o la “macdonaldizzazione”)
del lavoro corrisponde alla forma-espulsione della penalità.
Oggi la società, data la possibilità illimitata di
reclutare manodopera che le migrazioni offrono, e data
l’ossessione della scarsezza delle risorse utilizzabili
per fini sociali, ha deciso di non concedere una nuova
possibilità di vita sociale a chi ha commesso un reato.
Il
carcere sembra l'istituzione disciplinare che ha saputo
ridisegnare immediatamente la sua funzione, adattandosi alla
crisi fino a trasformarsi nel fondamentale baluardo
dell'ordine. Il dilagare dei grandi fenomeni migratori ha
comportato che negli ultimi anni la funzione politica
richiesta al carcere sia completamente cambiata. Non gli si
chiede più di produrre "buoni cittadini" del cui
giudizio e comportamento ci si possa fidare, bensì di
proteggere, per chi si è abituato ad usufruirne, quel Welfare state di cui si proclama il declino irreversibile. Gli si
chiede di fissare i limiti della cittadinanza sociale, di
alzare delle barriere che definiscano l'universo dei
"cittadini consumatori". E il carcere si è
prontamente fatto carico di questa domanda.
Via
via che il carcere perde la finalità risocializzante, la
detenzione dei migranti si svuota di ogni finalità che non
sia quella di stigmatizzarli come “classe pericolosa”.
Mentre per i cittadini europei non esiste un “altrove”
dove sia possibile collocarli, per soggetti, come i
migranti, per i quali questo “altrove” esiste, non
sembra ragionevole affrontare le spese del mantenimento in
carcere. Se lo scopo della pena detentiva è solo quello
incapacitante, e cioè solo quello di mettere il migrante in
condizione di non ledere gli interessi degli “onesti”
(ed “elettori”) cittadini, l’espulsione dello
straniero permette di conseguire lo stesso risultato. Venuta
meno, per il cambiamento delle modalità produttive e per i
fenomeni migratori, la fame di mano d’opera che aveva
caratterizzato l’industrializzazione nell’Ottocento,
niente più spinge a mantenere i migranti devianti
all’interno dello spazio politico statale. La politica
penale, finora costretta alla scelta tra la soppressione
fisica o la necessità di rendere il soggetto inoffensivo,
vuoi attraverso la deterrenza, vuoi attraverso la
rieducazione (o il disciplinamento), riacquista una
dimensione, andata perduta dopo i fallimentari tentativi di
deportazione di fine Settecento, e sconosciuta alla penalità
del secolo scorso: l’espulsione dei devianti dallo spazio
politico. L’espulsione può assumere due aspetti. Può
essere una vera e propria espulsione dal territorio dello
Stato e in questo caso il carcere gioca un ruolo
fondamentale, essendo ormai sempre più avanzata la sua
trasformazione da strumento contenitivo-deterrente-disciplinante
in strumento al servizio di questa nuova dimensione spaziale
delle politiche penali. L’espulsione dallo spazio politico
può però consistere anche in una semplice emarginazione
dei migranti dalla sfera della legalità.
La
necessità di controllare i migranti è divenuto un motivo
frequentemente richiamato per giustificare gli aspetti delle
nuove politiche penali che più stridono con la tradizione
costituzionale nord-occidentale, per far emergere con
chiarezza le logiche ad esse sottostanti conviene
concentrare l’attenzione sul l’Italia che si presenta
come un ottimo case
study per rilevare le tendenze delle nuove politiche
penali. L’Italia, infatti da un lato, come accennato, è
divenuto paese di immigrazione proprio nel periodo in cui la
globalizzazione economica e la sua ideologia si sono
affermati, dall’altro il governo italiano tra il 2001 e il
2006 sembra aver assunto senza remore la logica
governamentale della selezione della popolazione guidata
dalle esigenze del mercato come bussola per i suoi
provvedimenti normativi.
Fin
dagli anni novanta del Novecento, in Italia sembra
delinearsi un vero è proprio sistema di esecuzione penale
per gli stranieri, distinto, e più afflittivo, di quello
adottato per gli italiani. Questo diritto speciale sembrava
però il frutto non voluto di modalità dell’esecuzione
penale ritagliate sul modello di un cittadino che gode di un
network di relazioni a cui appoggiare il
reinserimento sociale. Erano le condizioni fattuali in cui
vivevano i migranti che producevano, nella fase di
esecuzione della pena, un diritto diversificato per gli
stranieri: un doppio binario per cui, a parità di pena da
espiare rispetto al cittadino italiano, gli stranieri si
trovavano assoggettati ad un surplus
di sofferenza legale. Le politiche penali erano in altre
parole formalmente caratterizzate da un razzismo in output
nonostante l’assenza di ogni razzismo in input,
anzi a dispetto di politiche spesso esplicitamente mirate ad
allocare carichi e vantaggi in assoluto rispetto del
principio di eguaglianza, se non addirittura tematizzanti la
colourblindness
quale loro criterio ispiratore.
Con i provvedimenti legislativi adottati nel 2002 la
discriminazione in output
è diventata una discriminazione in input:
il supplemento di sofferenza dei migranti si configura
sempre meno come una distorsione dovuta alle loro condizioni
e sempre più come una specifica scelta del legislatore. Per
quanto l’utilizzazione retorica delle rilevazioni
statistiche si affanni a mostrare che la discriminazione
colpisce i migranti perché sono oggettivamente più
pericolosi e “non meritevoli”, e non perché
“stranieri”, “diversi” o “colorati”, cercando di
preservare un’apparenza “universalistica” e il formale
rispetto del criterio della imparzialità rispetto alla
razza, è sempre più evidente l’affermazione di un vero e
proprio diritto speciale per i migranti che li pone in
condizioni di svantaggio anche formale.
L’uso
del carcere per .,
alal
na“”, disposti a sottoporsi ad un programma comunitariola fdella conclusione accade,i
dopo a suo favore
Il
legislatore italiano non si è limitato a dare un impulso
decisivo alla configurazione del carcere come un luogo in
cui il migrante (anche se era regolare al momento della
commissione del reato) viene rinchiuso in attesa
dell’espulsione. La legge 189 ha anche sanzionato
penalmente (prima come contravvenzione, e poi, di recente,
in conseguenza dell’intervento della Corte Costituzionale,
come delitto) la violazione dell’ordine di allontanarsi
dal territorio o di non farvi rientro e, come tutti i
legislatori europei, ha istituito centri di detenzione per
chi si trova nel territorio dello Stato sprovvisto di un
titolo di soggiorno, configurando così la reclusione come
un evento normale per coloro che vengono costretti dalla
legge stessa a vivere da “clandestini”.
Nel
2003 risultavano iscritti presso le procure italiane 16.138
procedimenti contro migranti per i reati di rientro sul
territorio nazionale dopo un procedimento di espulsione
(art. 13 comma 13 e comma 13 bis, art. 14 comma 5 quater del
T.U. del ‘98 sull’immigrazione, così come modificato
dalla legge 189 del 2002) e per non aver ottemperato
all’ordine di allontanarsi dal territorio (art. 14 comma 5
ter del T.U. del ‘98 anch’esso introdotto dalla legge
189/2002). Questi procedimenti hanno coinvolto 17.816
migranti (12.446 per il reato di non aver ottemperato
all’ordine di allontanarsi), la maggior parte dei quali è
stata trattenuta in carcere (solo per 4.753 di loro è stato
disposto il rilascio immediato).
D’altro canto i centri di permanenza temporanea hanno
ospitato tra il 2000 e il 2003 oltre mezzo milione di
persone (131.480 nel 2000, 134.332 nel 2001, 150.746 nel
2002, e 105.957 nel 2003) “colpevoli” di aver fatto
quello che le politiche italiane sull’immigrazione di
fatto istigano a fare: aver soggiornato clandestinamente sul
nostro territorio (cosa, è bene ricordarlo, che ancora di
per sé non è un reato).
Come
mostrano i numeri, la previsione di questo nuovo reato è un
potente meccanismo di stigmatizzazione: è lo strumento che
consente di portare a termine l’opera di connotazione
della popolazione migrante come un insieme di persone per
cui l’essere detenuto è un evento normale così come è
normale infrangere le leggi: la detenzione, il carcere,
segnano i criminali e quindi costituiscono la base del
congegno di esclusione politically
correct dalla cittadinanza sociale.
Cinicamente
si dovrebbe probabilmente gioire per il fatto che il potere
sembra voler finalmente rinunciare alla maschera
dell’uguaglianza dietro la quale si è sempre nascosto, ma
forse quella che chiamiamo civiltà (giuridica) non è che
un insieme di maschere che ognuno deve indossare, primo fra
tutti il Leviatano statale. Ai danni e ai rischi derivanti
dalla scelta di gestire i migranti attraverso il meccanismo
irregolarità-sanatoria, e quindi prevalentemente attraverso
strumenti penali, va aggiunta dunque anche la grave crisi
dello Stato di diritto.
Bibliografia
Agozino B. -Palidda
S. (1996), Immigrant Delinquency: Social Construction of
Deviant Behaviour and Criminalità of Immigrants in Europe,
European Union, , European Union, Bruxells.
Bell N. (2002), “The
exploitation of migrants in Europe”,
2002-11-04, http://www.forumcivique.org/index.php?lang=FR&site=MIGRATION&article=205
Bonetti P. (2004), “I profili generali della normativa italiana
sugli stranieri dal 1998”, in B. Nascimbene (a cura di), Diritto
degli stranieri, Cedam, Padova,
Burchell G. (1991),
“Peculiar Interests: Civil Society and Governing
`The System of Natural Liberty”“, in G. Burchell, C.
Gordon, P. Miller (eds.), The
Foucault Effect. Studies in Governamentality,
Chicago, The University of Chicago Press.
Burchell G. (1996),
“Liberal Government and Techniques of the
Self”, in A. Barry, Th.
Osborne, N. Rose (eds.),
Foucault
and Political Reason. Liberalism, Neo-Liberalism
and Rationalities of Government, Chicago University Press, Chicago.
Caritas Europa
(2006), Terzo Rapporto
Caritas sulla Povertà in Europa. "La migrazione: un
viaggio verso la povertà?
Chignola S. (2006), “Prefazione” a S. Chignola (a cura di), Governare
la vita. Un seminario sui Corsi di Michel Foucault al Collège
de France (1977-1979), Verona, Ombrecorte.
Commission of the
European Communities, Directorate General, Economic and
Financial Affairs (2005), The EU Economy 2005 Review.
Rising International Economic Integration: Opportunities and
Challenge, Brussells.
Ewald E. (1986), L'Etat providence, Paris, Grasset.
Foucault
M. (1973) “La société punitive”, Annuaire du Collège de France, 73e année. Histoire
des systèmes de pensée, année 1972‑1973, pp.
255-267, ora in M. Foucault, Résumé de cours,
Paris, Gallimard, 1994.
Foucault M. (1975) Surveiller
et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard.
Foucault M. (1976), "As
Malhas do poder", conferenza pronunciata alla facoltà
di filosofia dell'Università di Bahia, 1976, prima parte,
apparsa in Barbàrie, n. 4 estate del 1981, pp. 23-7, la seconda parte nel n. 5
del 1982, ora in Dits
et écrits,
1976-1988,
edizione
stabilita sotto la direzione di D. Defert et F. Ewald, Gallimard,
Paris 2001, IV, p. 193.
Foucault M. (1978), “La ‘gouvernamentalité’”, ora
in Dits et écrits, 1976-1988, edizione
stabilita sotto la direzione di D. Defert et F. Ewald, Gallimard,
Paris 20??, II,
pp. 635-657
Foucault
M. (1979), “Naissance de la biopolitique”, Annuaire du Collège de
France, 79e année. Histoire des systèmes de pensée, année
1978‑1979, pp. 367‑372, ora in M. Foucault, Résumé
de cours, Paris, Gallimard, 1994.
Foucault
M. (1997), Il faut
défendre la société. Cours au Collège de France, 1975-76, Gallimard-Seuil, Paris.
Foucault M. (2004a), Sécurité, territoire,
population, 1977-78, Gallimard-Seuil,
Paris.
Foucault M. (2004), Naissance de la biopolitique,1978-79, Gallimard-Seuil,
Paris.
Galbraith J.K.
(1992), The Culture of
Contentment, Harmondsworth, Penguin.
Gloz
P. (1985), Manifest für eine neue europäische Linke,
Wolf Jobst Siedler, Berlin.
Home Prison Service
(2005), Annual Report and Account, April 2004-March
2005, Home Prison Service, London.
Istat (2004), “La presenza straniera in Italia: caratteristiche
socio-demografiche”, Informazioni, n. 10, Giugno
2004, Roma.
E.
Melossi D. (2002), Stato,
controllo sociale, devianza, Milano, Bruno Mondatori.
Oestreich
G. (1989), Filosofia
e costituzione dello Stato moderno, a cura di P. Schiera, Bibliopolis, Napoli
Palidda S. (1999), “La
criminalisation des migrants”, Actes de la recherche en
sciences sociales, 129.
Pandofi
A. (2006), “La “natura”
della popolazione”, in S. Chignola (a cura di), Governare
la vita. Un seminario sui Corsi di Michel Foucault al Collège
de France (1977-1979), Verona, Ombrecorte.
Re L. (2006), Carcere e
globalizzazione.Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in
Europa, Roma-Bari, Laterza.
Santoro
E. (2003), “Crime and Punishment”, in R. Bellamy-A.
Mason (eds.), Polical Concepts, Munchester and New
York, Manchester University Press.
Santoro
E. (2006) “La fine della biopolitica e il controllo delle
migrazioni: il carcere strumento della dittatura democratica
della classe soddisfatta”, in F. Vassallo Paleologo-P.
Cuttitta (eds.), Frontiere
e diritti dei migranti, Napoli, ESI.
A.
Scott
A. (1997), "Globalization: Social Process or Political
Rhetoric?", in A. Scott (ed.), The
Limits of Globalization, London, Routledge.
Shaw C.D.-McKay
D. (1942), Juvenile
Delinquency and Urban Areas, University of Chicago
Press, Chicago.
Simon
J. (1997), “Governing Through Crime”, in L.M. Friedman
-G. Fisher (eds), The
Crime Conundrum, Boulder (Co), Westview Press, 1997.
Suherland E.H.- Cressey
D.R. (1924), Criminology,
Lippincott, Philadelphia.
Tocqueville A. de (1840),
De la démocratie en Amérique, ?????
Tournier P. (2000),
“Space I: enquête 1998 sur le populations pénitentiaires”,
Bullettin d’information pénologique, n. 22.
Wacquant
L., (1999), Les prisons de la misère, Paris, Raisons
d'Agir.
Weber
M. (1922), Wirtschaft und Gesellschaft, Mohr,
Tubingen.
Wilson W.J. (1987),
The Truly Disadvantaged, Chicago, University of
Chicago Press, Chicago.
Zanfrini L. (2004), Sociologia delle migrazioni, Editori
Laterza, Bari.
Zanini A. (2006), “Invarianza neoliberale. Foucault e l’economia
politica”, in S. Chignola (a cura di), Governare la
vita. Un seminario sui Corsi di Michel Foucault al Collège
de France (1977-1979), Verona, Ombrecorte.
-
Emilio Santoro
-
|