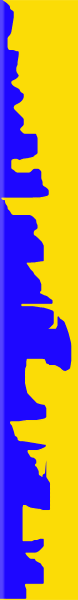|
Cercherò
di essere breve nella mia introduzione, però non posso fare
a meno, prima di entrare nel vivo, di fare un
ringraziamento. Il mio ringraziamento va anzitutto ai due
presidenti, al presidente che mi ha invitato, la
presidentessa del Centro Lapis, e al presidente che ha
ispirato l’invito, il presidente Scutellari del Tribunale
di Arezzo, che mi hanno consentito di rimettere piede in
questa bella cittadina, amministrata dal sindaco le cui
parole abbiamo ascoltato con tanto interesse ed al quale ho
per così dire espropriato la poltrona. Ma avrete pure
notato che ho curato che a occupare il posto che prima era
impegnato dal sindaco fosse il prof. Hulsman: perché non si
dica che l’autorità giudiziaria invade il campo di quella
amministrativa. Ho invece se mal non ricordo il piacere di
sedere dove prima sedeva S.E. il prefetto di Arezzo e per
quanto riguarda i rapporti fra l’autorità giudiziaria e
l’ufficio territoriale del governo non penso che possano
porsi questi problemi di campi invasi, perché l’autorità
giudiziaria è sempre rispettosa nei confronti di chi nella
provincia rappresenta il governo nel suo complesso e in
alcuni casi, per i poteri che competono al prefetto, anche
l’unità nazionale. Per via delle funzioni che ho sempre
svolto e svolgo, il mio pensiero peraltro non può non
andare alle forze di polizia, qui rappresentate dal
comandante della compagnia dei Carabinieri, dai funzionari
del Corpo forestale dello Stato, dai vigili urbani.
Probabilmente salterò qualcuno ma … già vedo su di me lo
sguardo preoccupato dei funzionari del corpo della polizia
penitenziaria: li avevo lasciati per ultimi perché a loro,
visto anche il tema che qui si tratta, va un pensiero
particolare. Perché spesso si dimentica che nelle carceri
oltre ai detenuti vi è anche il personale del corpo di
polizia penitenziaria, ci sono i funzionari e i dirigenti
del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e
spesso sia i cittadini, che noi appartenenti all’autorità
giudiziaria questo lo dimentichiamo, e non lo dobbiamo mai
dimenticare.
Voglio
essere breve per evitare di invadere il campo degli
illustri, anzi illustrissimi relatori. Però consentitemi
anche, viste le funzioni che svolgo, di rivolgere un
pensiero – ed è un piacere
quello di aver trovato qui il collega Gaetano Paci, della
direzione distrettuale antimafia della procura della
repubblica di Palermo, che è diciamo così la punta
avanzata dell’azione di contrasto dell’autorità
giudiziaria nei confronti della criminalità organizzata di
tipo mafioso- ai colleghi di tutte le direzioni distrettuali
antimafia, ventisei direzioni distrettuali antimafia in
Italia, che sono tutti impegnati fino allo spasimo nel
contrastare questi fenomeni criminali che mettono seriamente
in pericolo la vita della collettività.
É
ben strano il destino se oggi mi appresto qui ad introdurre
e coordinare un convegno nel corso del quale in buona
sostanza ci si interrogherà sul carcere, sulla sua utilità,
sul suo diritto di cittadinanza in uno Stato di diritto, se
sia opportuno parlare di alternative al carcere, o di
carcere alternativo, e forse anche della opportunità della
permanenza della stessa giustizia penale.
Se
per 29 anni avessi fatto il giudice, forse avrei potuto
salvarmi dietro le parole di Leonardo Sciascia, secondo cui
quello di giudicare non può essere un potere, e la scelta
della professione del giudicare dovrebbe avere radice nella
ripugnanza al giudicare, dovrebbe cioè consistere
nell’accedere al giudicare come ad una dolorosa necessità,
nell’assumere il giudicare come un continuo sacrificarsi
all’inquietudine, al dubbio, ad introvertire detto potere
come un dramma, a soffrirlo. E quindi concludere, dopo aver
fatto mie queste parole, dicendo che al dramma delle
reclusioni inflitte ha fatto da contraltare il mio personale
dramma, che la mia sofferenza si è accompagnata a quella
delle vittime dei reati oggetto del giudizio, sofferenza
questa che non va mai dimenticata, e a quella dei condannati
per i quali si aprivano le porte del carcere, che si
chiudevano alle loro spalle, per anni e anni e in tanti
casi, in teoria, per tutti gli anni della loro vita.
Invece,
per 29 anni ho fatto il pubblico ministero, ho cercato prove
di responsabilità e, sulla scorta di queste, ho richiesto
migliaia di anni di reclusione ed, in molti casi, condanne a
vita, e spesso le ho ottenute, come quando la Corte
d’Assise di Palmi il 25 novembre del 1997 ebbe ad
infliggere quasi cento condanne all’ergastolo. Forse il
maggior numero di applicazioni di tale condanna nella storia
dell’Italia moderna.
Potrei
trincerarmi dietro la spiegazione di aver solo fatto il mio
dovere, ma sarebbe un discorso forse troppo autoreferenziale,
e privo del tutto di quella carica spirituale che
caratterizza ogni azione umana, che per di più cadrebbe
facilmente sotto i colpi della critica di chi afferma che il
sistema della giustizia penale (vera e propria macchina
burocratica) opera soprattutto per giustificare la propria
esistenza, per legittimarsi dinnazi alla società. E,
soprattutto, significherebbe per certi versi proclamare un
esonero da responsabilità, scaricandole su chi, facendo
anch’egli parte di quel sistema, ha il compito di
confrontarsi giorno dopo giorno con gli effetti del mio
operato. Mi riferisco a coloro che operano all’interno del
sistema penitenziario, con i quali la magistratura, pur
nella separatezza delle funzioni, non può non interagire
idealmente e tecnicamente e, di fatto, interagisce nella
misura in cui una sua branca, quella di sorveglianza,
condivide in pieno quello sforzo di adeguamento della pena
alla natura umana dei condannati, soprattutto grazie a
quell’istituto che va sotto il nome di “TRATTAMENTO”.
Preferisco,
allora, nella consapevolezza di parlare a nome di centinaia
di altri come me, affermare di non aver agito mai nella
consapevolezza di operare per giustificare
l’esistenza del sistema di cui faccio parte, ma per
contribuire alla applicazione di
leggi che, nel bene e nel male, sono legittimamente
presenti nell’ordinamento giuridico dello Stato cui
appartengo, oggi più che mai alla luce dell’inserimento
nell’Olimpo del diritto, sul piano più alto della
gerarchia delle leggi, della legislazione
internazionale, senza la corrispondenza alla quale,
soprattutto in materia di diritti fondamentali dell’uomo
(e qui di tali diritti si tratta), nessuna legge di uno
Stato può esistere.
Piuttosto,
nella consapevolezza che senza un ordinamento giuridico una
società civile non può esistere, e che in tale ordinamento
esiste una legislazione penitenziaria che sin dal 1975 si
ispira a principi dei quali ci parlerà sicuramente uno dei
relatori di questa mattina, che abbiamo la fortuna di avere
qui, che non esito a definire uno dei principali ispiratori
della riforma penitenziaria.
Ed
ancora, nella consapevolezza che il progresso della civiltà
non ha limiti, purchè non si aspiri a società utopistiche,
a novelle Città del Sole, e che quindi la mente umana saprà
in materia di pene, od anche di non pene, distinguere
tra fatti e fatti, tra persone e persone e, per queste, non
già in base a razza, censo, posizione sociale o stabilità
e modo di presenza nel territorio dello Stato, religione,
ecc., ma in base alla loro vicenda personale, ed al loro
atteggiarsi nei confronti della azione posta in essere, di
chi o coloro i
cui diritti sono stati violati da tale azione, al modo
stesso in cui intendono la colpa e la sanzione inflitta,
circostanze tutte che potranno determinare anche il giusto
inquadramento del fatto: perché i fatti umani non sono solo
fatti e nella loro materialità non v’è solo materia.
Sul
punto si profilano qui in Italia interessanti modifiche
legislative in tema di allargamento dell’istituto della
messa alla prova.
Ciò
posto, si tratterà qui di vedere se è superabile quello
che si può definire il legame inscindibile tra carcere e
libertà, nel senso che non v’è libertà senza carcere e
non v’è carcere senza libertà. Intendendosi tale frase
nel senso profondo che per garantire le libertà dei più è
necessario limitare quella dei pochi che violano le regole
ma, nel contempo, che il carcere non avrebbe senso se non vi
fosse per gli incarcerati la speranza di una libertà che
consenta loro di non tornare in carcere.
Probabilmente
proprio dal primo degli illustri ospiti il prof. Louk
Hulsman sentiremo partire le prime formidabili ed autorevoli
bordate contro i sistemi vigenti, che si sostanzieranno
nella proclamazione della teoria dell’abolizionismo, non
solo del carcere, ma dello stesso sistema di giustizia
criminale da sostituire con altri sistemi (mediazione,
giustizia civile).
Le
sue tesi si trasformeranno in interrogativi che aleggeranno
in questa aula e come macigni peseranno sulle nostre menti e
le nostre coscienze.
Verranno
le risposte, di assenso o dissenso. Gli altri non meno
illustri ospiti di questa mattina potranno spiegare come un
moderno diritto penitenziario può garantire i diritti umani
e contemperarli con l’esigenza di proteggere la società
dal crimine.
Mai,
però, una risposta ad un abolizionista che sottopone agli
altri le sue argomentazioni potrà essere quella che forse,
in teoria, ha ragione ma, in pratica, non c’è modo di
fare diversamente da come di fatto avviene. Bisogna
rispondergli con argomentazioni serie, come serie sono le
sue.
E
se non vale quella cui si faceva sopra riferimento circa il
legame carcere-libertà, altre se ne diano.
Ma
si tenga anche presente che un pericolo terribile oggi
minaccia le società libere sempre più percosse da azioni
criminali quali quelle del terrorismo, della delinquenza
organizzata nazionale e transnazionale, e del crimine
economico-finanziario che canali sotterranei probabilmente
legano al primo ed alla seconda: che la erosione degli spazi
della giustizia penale sottragga alla giurisdizione
importanti ambiti che verrebbero per necessità di cose
(anche ordine pubblico) invasi dalla amministrazione di
polizia, con le immaginabili conseguenze in materia di
compressione dei diritti fondamentali della generalità dei
cittadini; per evitare la limitazione della libertà di
alcuni (quelli che hanno violato le regole), si
determinerebbe la limitazione generalizzata dei diritti di
tutti. E’ forte, cioè, il rischio che la alternativa al
sistema penale tradizionale sia lo stato di polizia. E
potrebbero farsi tanti esempi concreti.
Disse
un nomade del Sahara ad un occidentale “
a voi occidentali manca il deserto”. E mentre quello
lo guardava con aria interrogativa, aggiunse: “solo
chi è abituato a scavare nella sabbia per trovare l’acqua
pura, può andare al fondo delle cose e conoscere la verità”.
Forse,
in questi due giorni, scavando tra le incertezze ed i dubbi
del sistema carcerario e delle sue possibili alternative,
potremo trovare un po’ di verità.
-
Roberto Pennisi
-
|