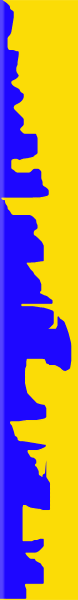|
Vorrei
risalire un versante del discorso che forse è stato meno
praticato e che è più congeniale a chi come me non ha una
costante esperienza di contatto con la realtà carceraria in
quanto piuttosto se ne occupa, pur avendo dei contatti anche
con la stessa, dal punto di vista degli studi e
dell’analisi dei dati, delle ricerche, ecc. Il passaggio
che mi porta a considerare la situazione specifica dei
soggetti così come è stata toccata efficacemente da chi mi
ha preceduto, è un passaggio che io riesco a praticare
leggendo dati, risultati di interviste, ricostruzioni
storiche dell’evolversi dei fatti, del pensiero, delle
culture. E purtuttavia credo che questo modo di avvicinarci
ala realtà del carcere ci dia la possibilità, che in fondo
rappresenta anche una grande risorsa, di riuscire a leggerlo
con un minimo di distacco, che consenta di elaborare delle
rappresentazioni, quindi anche delle proposte, che tendono a
sottrarsi rispetto alle costruzioni prevalenti, a quelle
acquisite e date per scontate, nel modo di porre le
questioni. Ritengo in altre parole che ci siano una serie di
elementi inconsapevolmente acquisiti, di luoghi comuni
inconsci, nel rappresentarsi il problema del carcere e della
pena, che uno studio invece di carattere statistico,
storico, culturale consente di fare emergere, e quindi di
decostruire.
Il
mio discorso quindi è un discorso che deve partire dalla
questione della recidiva che con voluta provocazione ho
indicato nel titolo del mio intervento come “onda lunga
della pena”, da considerarsi come un fenomeno che riassume
in sé molti elementi di queste inconsce acquisizioni che
costituiscono l’immaginario, il senso comune sulla pena, e
che nella sua drammaticità e nel modo in cui propone i
problemi nella stessa implicati, fa emergere appunto queste
distorsioni. Parto da una constatazione che nasce da un
confronto tra elementi diversi della storia del pensiero,
che
riguarda la storia della pena e del carcere. Cioè la
radicale antitesi che esiste tra il pensiero che sottende la
giustificazione dell’aggravamento di pena nel caso di
recidiva, e il pensiero dei criminologi che hanno studiato
come l’itinerario che porta verso definitive carriere
devianti passi proprio attraverso il reiterarsi della
punizione.
Da
un lato cioè, se noi leggiamo in controluce che cosa
giustifica l’aggravamento della pena, ritroviamo
inevitabilmente gli elementi della retributività da un lato
e della funzione rieducativa dall’altro; nel senso che la
retributività comporta rispetto a una persona che, pur
punita, non ha accettato, non ha interiorizzato il senso del
pagamento del suo debito attraverso la punizione, e,
nonostante l’esperienza attraversata, torna a delinquere,
un inevitabile aggravamento di pena. Se quindi questo non
gli è bastato, ciò significa che la sua volontà, che lo
porta appunto secondo il principio del libero arbitrio a
scegliere di nuovo di violare la legge, ha compiuto qualcosa
di più grave; e questa maggiore gravità inevitabilmente va
sanzionata con un aggravio di pena. E d’altra parte dal
punto di vista della rieducazione si potrebbe sostenere che,
visto che la prima esperienza, quella quantità di cura non
è stata sufficiente, è necessario un surplus di
trattamento, diciamo così, terapeutico,
un surplus di cura, perché sia effettivamente
rieducato visto che la cura precedente non è bastata.
Nella
sostanza tutti gli elementi che giustificano la pena si
appuntano attorno alla necessità di un aggravio di sanzione
per reagire a chi non ha capito la lezione.
Le
teorie dell’etichettamento sottolineano al contrario come
la successiva conferma del tipo di sanzione punitiva, che
viene applicata a chi ha intrapreso un comportamento
illegale, conduca ad approfondire e radicalizzare
l’interiorizzazione del ruolo deviante, facendo assumere
definitivamente l’identità deviante, strutturando
definitivamente il suo comportamento dentro questo ruolo. In
relazione allo stesso il sistema di relazioni in cui è
collocato va a ristrutturarsi in modo tale da confermarlo
sistematicamente, così da costruire aspettative di devianza
che troveranno conferme nei comportamenti devianti del
soggetto coinvolto. Quindi siamo di fronte a due pensieri
antitetici, il primo non a caso derivante da un legame che
nasce dal pensiero liberale e che unisce in un continuum che
andrebbe approfondito – e non ho qui il tempo di farlo –
tra pensiero classico e pensiero positivo, che partendo
dall’idea del rapporto tra stato e cittadino considera
tutti i cittadini uguali davanti alla legge, come entità
astratte, e applica la pena come una retribuzione negativa
rispetto al danno socialmente prodotto, o come una forma
standardizzata di rieducazione. Il secondo invece nasce
dallo studio scientifico del comportamento umano,
dall’analisi empirica dei fenomeni, e contrappone a quella
rappresentazione astratta e filosofica l’evidenza dei
fatti.
E’
chiaro che a fronte di questo conflitto, di questa tensione,
leggi come la recente cosiddetta ex Cirielli, in quanto
viene a sanzionare più duramente la recidiva, dimostrano
tutta la loro – lo dico senza falsi pudori –
arretratezza culturale, rispetto all’evolversi del
pensiero scientifico. Per non parlare di altri tipi di
arretratezza. Ma ciò che rinforza e ulteriormente
conferisce senso al carattere conflittuale di queste diverse
rappresentazioni noi possiamo appunto coglierlo, sul piano
applicativo di queste astratte costruzioni filosofiche, su
cui la giustificazione della pena si regge, attorno
all’idea della rieducazione attraverso un surplus di
sanzioni. Qui a lume di logica ovviamente - la scienza
medica ci conforterebbe in questo senso a livello metaforico
– il ripetersi di una cura che si è dimostrata sbagliata
non può avere altri effetti che aggravare la malattia.
Potremmo cioè esattamente rovesciare il ragionamento che
giustifica l’aggravio di pena in caso di recidiva. Se la
sanzione penale si è dimostrata inappropriata così da
determinare successive violazioni della legge, è
sostanzialmente irragionevole, corrispondente a una
irrazionalità puramente emotiva e non fondata in alcun modo
scientificamente, la ripetizione della stessa cura. Anche
perché si è dimostrato che una cura limitata non ha
funzionato da vaccino, anzi ha determinato un aggravarsi del
male.
E
d’altra parte un ulteriore aspetto che va assolutamente
colto è che, nell’esperienza della recidiva, si
riconferma fino in fondo l’estraneità
dell’atteggiamento, dell’esperienza del soggetto,
rispetto al significato della pena. Cioè la recidiva è la
rappresentazione concreta, fattuale del fatto che il tipo di
significati che la società ha inteso trasmettere al
soggetto attraverso l’irrogazione della sanzione
afflittiva, è un tipo di esperienza, riassume in sé un’
interiorizzazione di elementi, che sostanzialmente si
dimostrano distonici, se non addirittura del tutto estranei
rispetto alle capacità percettive del soggetto. Lo stesso
infatti vive immerso in un’altra dimensione culturale, in
un altro contesto di significati, in un altro ambiente
immaginario. Sono proprio questa estraneità e questa
lontananza che fanno emergere l’originalità del soggetto,
il quale riconferma l’habitat culturale da cui proviene,
rafforzato dall’esperienza detentiva, radicalizzato da
risentimenti e reazioni umanamente non gestibili in termini
di autocontrollo, molto spesso, e che quindi in quanto tale
esterna l’originalità del suo essere rispetto alle
definizioni giuridiche che gli sono state addossate.
La
recidiva in questo senso emerge dalla distanza fra l’idea
che del soggetto ha il diritto, e ciò che il soggetto
concretamente è nell’infelicità della sua esperienza.
Gli elementi che confermano queste mie considerazioni
nascono appunto da una ricerca abbastanza recentemente
fatta, i cui risultati sono stati pubblicati anche sulla
Rassegna criminologica penitenziaria, con la quale siamo
andati a intervistare un centinaio di ex detenuti che si
trovavano in carcere nuovamente dopo esperienze di
recidiva.Attraverso tale indagine abbiamo cercato di capire
come avevano vissuto la pena nella situazione precedente,
come avevano vissuto la situazione dell’uscita dal carcere
e come erano arrivati di nuovo a violare la legge e a
ritrovarsi detenuti.
In
sintesi, anticipando un po’ il senso di tutto ciò che
emerge dalla ricerca e che conferma le considerazioni da cui
sono partito, quello che più è dato cogliere è stato non
tanto il riprodursi – perché anche nella cultura
solidaristica si radicano dei luoghi comuni – delle
classiche difficoltà, la solitudine, la disoccupazione,
l’assenza di casa, la rarefazione dei contatti sociali,
l’emarginazione e via dicendo, cioè tutto quello che più
immediatamente ci rappresentiamo quando pensiamo alle
difficoltà di chi esce dal carcere; quanto piuttosto un
disorientamento culturale, un modo di percepire la realtà,
la propria realtà e quella dei rapporti sociali in cui si
è collocati, e la stessa esperienza detentiva che non
rientra nelle coordinate culturalmente istituzionalizzate
prevalenti nel nostro vivere civile. In altre parole,
anticipando in sintesi il maggior risultato emergente da
questa indagine, che poi esemplificherò con qualche dato,
si vive in una situazione di sospensione, di rarefazione
ideativa e percettiva dei contesti in cui si è collocati,
di difficoltà di ricostruire dei riferimenti, tale per cui
il significato delle azioni, dei comportamenti, delle
situazioni, non è percepibile nello stesso modo in cui è
percepibile nella realtà condivisa dalla maggioranza delle
persone, che sembrano essere rispettose della legge.
Ci
sono degli elementi che confermano questa situazione
percettiva di fondo, per esempio per quanto riguarda i
contatti con la famiglia. Il rapporto con la famiglia si
presenta in linea di massima molto positivo. C’è da parte
del detenuto una idealizzazione, in linea di principio, di
ciò che è la famiglia, quanto meno la famiglia di origine,
per cui il detenuto recidivo dice, nel 70 per cento dei
casi, che ha ottimi rapporti con la famiglia d’origine. Un
po’ meno, il 37 per cento, dice di avere ottimi rapporti
con la famiglia di nuova costituzione. Però quando andiamo
a verificare l’ottima qualità di questi rapporti
concretamente, dal punto di vista dei fatti, abbiamo solo un
19 per cento di soggetti che hanno preso contatti con la
famiglia prima di uscire dal carcere, cioè che si sono
attivati per essere aiutati davvero dalla famiglia.
Successivamente solo il 10 per cento si è effettivamente
poi rivolto alla famiglia una volta uscito dal carcere, a
fronte del fatto che d’altra parte il 40 per cento di
persone non si esprimono proprio su questo punto, cioè non
hanno nulla da dire a proposito dei rapporti con la
famiglia. C’è dunque una distanza enorme fra ciò che
viene affermato in linea di principio e viene idealizzato e
ciò che realmente accade, perché se la famiglia è una
specie di bene intoccabile, che va comunque riaffermato e
che costituisce un orientamento ideale verso cui riparare
nella situazione di difficoltà, o rivendicando comunque una
propria dignità affettiva, una propria appartenenza
affettiva che fa parte dell’immagine positiva del sé, nei
fatti poi questa consistenza di rapporti non esiste.
Altrettanto
noi possiamo dire a proposito del lavoro, un altro cardine
di quello che dovrebbe essere il reinserimento. Per quanto
riguarda il lavoro emerge una situazione di fatto molto
difficoltosa. Il 20 per cento era disoccupato dopo la
detenzione. Tutte le altre situazioni di lavoro sono
riferibili a lavori dequalificati e precari, i lavori fissi
erano stati ottenuti solo dal 20 per cento di detenuti.
D’altra parte il tema del lavoro nell’immaginario di chi
stava per uscire, con riferimento all’esperienza di
libertà precedente alla successiva detenzione, non era
recepito in termini di autoattivazione, tant’è che il 25
per cento non dice di essersi attivato per cercare un lavoro
prima di uscire. C’è quindi
un rapporto diretto fra la scarsa consapevolezza
dell’importanza della cosa, la difficoltà di attivarsi e
l’assoluta precarietà e scarsa qualità dell’esperienza
lavorativa nella fase successiva. Questa scarsa qualità,
questo carattere diciamo di difficoltà viene riconosciuto,
perché ad essere soddisfatti delle condizioni di lavoro
sono solo il 25 per cento, mentre il 56 per cento di chi
lavorava avrebbe voluto volentieri cambiare lavoro, in
quanto non era contento del lavoro ricoperto. Però quando
andiamo a cercare di misurare che difficoltà effettiva, che
peso effettivo ha avuto questa difficoltà nella recidiva, a
fronte di una scala di affermazioni possibili, a riconoscere
il lavoro come una difficoltà è solo il 10 per cento. E a
riconoscere il lavoro come la maggior causa della propria
ricaduta è solo il 5,6 per cento.
Emerge
allora qualcosa davvero di disorientante, cioè noi pensiamo
che lavoro significhi reinserimento, normalizzazione ,
rieducazione, reintegrazione civile e via dicendo, ma queste
persone hanno dentro qualcosa di diverso, sono cioè immerse
in una dimensione in cui queste considerazioni sono
necessariamente laterali rispetto al loro vissuto centrale e
dove l’aspetto fondamentale e più sostanziale molto
probabilmente – perché noi leggiamo in negativo, cioè
troviamo più spazi vuoti che spazi pieni, troviamo piccoli
spazi pieni che lasciano grandi spazi vuoti - il poco che
emerge da questi piccoli tratteggi ha a che fare con un
profondo vissuto precedente, con l’impossibilità di
entrare adeguatamente in rapporti sociali soddisfacenti, in
una dimensione di estraneità e di conflittualità con le
istituzioni che le vedono come nemiche essenzialmente, o
come termine continuo di un conflitto dal quale è
necessario proteggersi.
Quello
che è strano in questo carattere di luogo comune che il
termine lavoro assume, è che nonostante la difficoltà
lavorativa venga minimizzata come causa della recidiva,
viene invece massimizzata quando diventa una richiesta,
cioè quando si chiede che cosa bisognerebbe fare, il 25 per
cento dice “dateci un lavoro”. Non è molto per la
verità, è sempre una percentuale assai limitata, però
decisamente più consistente rispetto a quella piccola
percentuale che riconosce nel
lavoro una difficoltà nella recidiva. Forse è
l’emergere di un luogo comune, forse l’emergere di un
risentimento, di un bisogno di riaffermazione, di una
qualche rivendicazione.
Un
altro aspetto che viene fuori in modo significativo è il
fatto che nel momento in cui si pongono delle prospettive
sul da farsi e su chi dovrebbe fare, il carattere di
rivendicazione da parte degli ex detenuti nuovamente
detenuti è molto deciso: il 50 per cento dice che dovrebbe
essere lo stato ad aiutarli ad inserirsi, cioè dice
l’autorità centrale, non l’ente locale né i servizi
sociali, ma proprio lo stato, cioè è chi ha condannato,
chi ha deciso la reclusione che deve aiutarli nella
situazione dopo il carcere. Mentre le aspettative sono
abbastanza rarefatte e stereotipate, oltre al 25 per cento
di chi chiede lavoro c’è un altro 15 per cento che parla
della casa, c’è un buon 13 per cento che parla del
permesso di soggiorno, ovviamente con riferimento agli
immigrati. Ma c’è una sfasatura ancora una volta tra il
tipo, l’oggetto della richiesta, che è piuttosto
contenuto e rarefatto, e il referente della richiesta, che
è l’autorità centrale, individuata come il responsabile
di una possibile soluzione. E quindi esprime un
risentimento, una rivendicatività generica, piuttosto che
una richiesta specifica associata a delle misure concrete su
problemi concreti.
Sono
questi gli elementi – non ho tempo di illustrarne altri -
che intendo portare per parlare appunto di rarefazione.
Dicevo prima: il fatto di prendere atto di questo stato di
cose, che va unito al fatto che la recidiva ondeggia fra il
70 e l’80 per cento dei casi, e che quindi al di là delle
migliori intenzioni, delle migliori esperienze che in certi
contesti si possono sviluppare, delle idee possibili di
trattamento, - il fallimento della capacità rieducativa
della pena in termini statistici è assolutamente evidente
– non può non portare a interrogarci a fondo
sull’adeguatezza e sulla fondatezza dei riferimenti di
conoscenza, di giustificazione in termini di teoria di
pensiero, dell’applicazione della pena. Io non riesco a
scindere gli aspetti empirici, vedere queste persone così
disorientate e poco consapevoli, da ciò che socialmente
fonda la sanzione, la misura cui sono state sottoposte,
l’esperienza che forzosamente hanno attraversato, e che
continuerà ad essere applicata fin che la legge resta in
questi termini. E quindi ciò che resta centrale, credo che
questo sia il nucleo di tutto, al di là di tutte le analisi
più recenti sull’amministrativizzazione della pena, sulle
tecniche di controllo del territorio ecc. – e in
definitiva il fatto che la punizione resta in fondo sempre
fondata sostanzialmente sull’idea che bisogna pagare, che
se si sbaglia si paga, e che la società ha bisogno che chi
sbaglia in qualche modo sconti negativamente gli effetti del
suo errore.
Allora
ritengo, prendendo spunto da alcune considerazioni di Thomas
Mathiesen nel suo noto libro tradotto in italiano Perché
il carcere?, e cercando di approfondirle, che
sia fondata l’idea che la retributività della pena sia
ontologicamente impossibile. In che termini? Nei termini
della impossibilità di pensare effettivamente a una
quantità di sofferenza che sia proporzionatamente
comparabile con ciò che è la sostanza della violazione
della legge. Perché questo? E’ facile coglierlo: in fondo
la pena riassume tutte le forme di violazione della legge
attorno a un’unica idea riparativa, che è la privazione
del tempo di libertà. Ora, la privazione del tempo di
libertà non è come il denaro. Se è vero che la società
mercantile in cui la pena ha preso corpo ed è venuta alla
luce nella sua formulazione liberale classica, è una
società che ha assunto il tempo come valore di scambio, e
d’altra parte questo è stato tradotto anche in moneta, e
quindi c’è un’idea della capacità, del valore del
denaro di rappresentare in sé qualsiasi tipo di bene,
qualsiasi tipo di oggetto e quindi essere elemento possibile
dello scambio tra beni, tra risorse diverse, perché
riassume in sé il minimo comune denominatore di tutti i
valori possibili, al contrario il tempo di vita, cioè il
tempo della persona, il tempo del singolo, come esperienza
di quantità di libertà sottratta, non è un bene
oggettivo, non è un bene asettico, non è un simbolo che
rappresenta simbolicamente un valore di scambio; è un tempo
che si colloca profondamente nella specificità
dell’esperienza del soggetto, nella qualità della sua
realtà di vita, e in quanto tale non è comparabile con il
tipo di beni che gli articoli del codice penale intendono
proteggere attraverso questo tipo di sanzioni.
C’è
un fraintendimento profondo tra il senso del danno sociale -
che poi sono molto diversi i danni socialmente prodotti
dalle diverse condotte criminali – e la retribuzione di
queste condotte attraverso la privazione del tempo: come se
questo potesse essere misurato in termini equivalenti con la
qualità dei danni prodotti dai diversi comportamenti
illegali. Quindi è uno scambio sostanzialmente impossibile.
E’ uno scambio che se è impossibile dal punto di vista
pubblico, cioè del valore dei beni tutelati attraverso la
legge penale, lo è anche dal punto di vista privato. Dal
punto di vista pubblico l’impossibilità dello scambio è
resa evidente dal fatto che l’eterogeneità di cui ho
parlato finisce con l’essere superata dall’assunzione
dal punto di vista del codice del tempo di pena come
strumento di descrizione della gravità del fatto, di
materializzazione della gravità del fatto, piuttosto che
come effettivo strumento di uno scambio possibile.
Rovesciando il discorso, è la quantità di tempo che va a
descrivermi la qualità del reato, è un linguaggio in
qualche modo, ma non è corrispondente, misurabile con la
gravità dell’atto in sé, nella sua specificità.
Dal
punto di vista intersoggettivo siamo altrettanto di fronte a
una grande eterogeneità, e qui pongo un elemento a cui
sicuramente il discorso di Hulsman si è agganciato, vale a
dire il vissuto del danno del reato da parte della vittima,
che va collocato nella sua condizione sociale, nel sistema
di risorse di cui può fruire, che va differenziato a
seconda della identità sociale, dell’esperienza e della
percezione del soggetto; si tratta comunque sicuramente di
una cosa ben diversa dal tempo di libertà sottratto, che a
sua volta poi al suo interno si differenzia moltissimo a
seconda della condizione sociale dell’individuo
condannato. Quindi siamo di fronte a entità distorte,
sproporzionate, non scambiabili, in cui lo scambio
sostanzialmente perde di significato o meglio ne assume uno
puramente ideologico.
Eppure
c’è stato un pensiero, in età liberale, che ha
commisurato la gravità della pena alla sottrazione di
tempo. Ma dobbiamo considerare da dove viene questo
pensiero. Era il pensiero di chi aveva bisogno di dire basta
con i supplizi, basta con le torture, basta con le sanzioni
assolute, che annientano l’individuo di fronte alla
suprema autorità del sovrano offeso da ogni forma di
illegalità. E’ comprensibile che storicamente i pensatori
liberali intendessero porre un freno a questa esacerbata
crudeltà rappresentata dai supplizi, e ponessero la
questione della dolcezza della pena come antitesi rispetto a
quell’idea: ma pur sempre si muovevano in una dimensione
di necessaria applicazione di sofferenza, paradossalmente la
dolcezza della pena eredita la crudeltà e l’efferatezza
dei supplizi e in questo senso si porta dietro il peccato
originale, diciamo così, dell’annientamento del reo
rispetto alla supremazia del sovrano.
Oggi
storicamente siamo in una situazione in cui possiamo
seriamente cominciare a pensare di superare questo peccato
originale, di entrare più praticamente nel vivo dei
fenomeni sociali. Perché siamo ormai in una situazione di
pensiero e di capacità di analisi empirica e di studio dei
fatti molto, ma molto più avanzata rispetto alla
rappresentazione filosofica liberale del rapporto
stato-cittadini. E d’altra parte molto più ricca e
avveduta che non fosse la traduzione di quella
rappresentazione nel pensiero positivista che andava ad
attribuire al reo tutte le negatività possibili, in fondo
tornando a proiettare la supremazia dello stato sui
soggetti. Oggi siamo in una dimensione culturale, politica,
di conoscenza, di ricerca scientifica tale per cui possiamo
effettivamente entrare concretamente nella specificità
delle situazioni, quindi dei conflitti, per trovare le
risposte più adeguate. E allora la domanda che è da porsi
è se queste risposte si possono trovare necessariamente
ancora e solo attraverso l’afflittività della pena, o non
possono cominciare, almeno per una grande quantità di casi
e di situazioni, ad essere cercate e trovate nella
specificità del contesto in cui si dispiega il rapporto fra
i soggetti coinvolti nell’esperienza di illegalità.
Quindi, andando a vedere nella loro concretezza gli attori,
le situazioni, le aspettative, i danni, le reazioni, le
retroazioni, le rappresentazioni da parte dell’opinione
pubblica, ecc., con riferimento specifico ai casi che ci
troviamo a trattare.
Sono
convinto, e concludo, che secondo questa specificità, colta
prima che venga applicata la pena affittiva, in modo da
potere intervenire in modo adeguato, equilibrato, senza
sradicamenti, senza sconvolgimenti di sistemi di relazioni,
senza alterazioni d’identità drammatiche, senza
strumentalismi e ambiguità, ma vedendo davvero chi sono le
persone nel contesto in cui, soprattutto se sono
all’inizio, pongono in essere comportamenti socialmente
lesivi, una risposta adeguata a questo livello sia molto
più efficace, anche in termini di sicurezza, rispetto a una
risposta che interviene poi, quando ormai l’applicazione
della sanzione affittiva, per ciò che ideologicamente
rappresenta, – come eredità del pensiero liberale di cui
dicevo prima – ha già consumato tutti i suoi effetti
negativi. Da questo punto di vista la china da risalire è
molto più dura, le deformazioni da sistemare sono molto
più complesse, i danni prodotti sono molto più penetranti
rispetto invece al fatto di vedere la situazione
metodologicamente nella specificità del contesto.
In
questo senso la mediazione è un’ottima esperienza,
purché intervenga il più possibile al di fuori della
dimensione penale, purché rappresenti una sfera
d’intervento che non l’avvilisca a articolazione,
appendice residuale rispetto a tutta una dimensione di
penalità già consumata e già applicata. Che la persona
debba rivedere tutta la sua vita, tutti i suoi errori, alla
fine della pena, comporta una rielaborazione molto più
complessa e a sua volta deformante, rispetto al fatto che
fosse portato davanti alla giustizia il significato della
sua azione subito, di fronte alla vittima che ha subito il
danno e in questo contesto vada a ridefinire se stesso e a
ricucire il legame sociale. Queste sono scelte di fondo che
oggi si pongono come determinanti. Io credo che il nostro
legislatore sia oggi nelle condizioni di poter fare questo
salto di costruzione del problema, di rappresentazione del
problema e di scelte di forme diverse d’intervento.
-
Giuseppe Mosconi
-
|