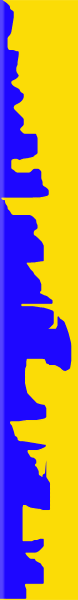|
Prima
di tutto un saluto a chi conosco e alle persone che per la
prima volta incontro, con una sottolineatura del mio piacere
di essere qui come provveditore regionale, funzione che ho
già svolto in Basilicata, una piccola realtà un po’
isolata, anch’essa con delle peculiarità di grande
interesse, ma con lo spirito d’avventura che ha sempre
connotato la mia vita professionale –
il dott. Di Gennaro mi ha sempre definito
“Pasionaria” – che mi ha sempre contraddistinto
affronto una nuova avventura professionale in una regione
così ricca, così vitale, che forse mi potrà anche
insegnare tanto. Quello che dirò sono semplicemente dei
flash, forse anche provocatori, e che non toccano certamente
la realtà della Toscana ma potrebbero riguardare diverse
realtà concrete.
Io
ho sempre guardato e guardo all’amministrazione
penitenziaria partendo da affermazioni assiomatiche di
valore. Noi abbiamo una norma penitenziaria bellissima che
potremmo forse migliorare ancora lavorando in particolare
sugli articoli che riguardano il lavoro penitenziario – mi
viene da dire ricordando quello che ha appena detto Di
Gennaro che secondo me bisogna investire su quegli articoli
cambiandoli e migliorandoli – io credo però che sia una
norma veramente eccezionale anche nel panorama europeo e poi
soprattutto alla luce del nuovo regolamento di esecuzione
del quale vediamo gli artefici, il presidente Margara,
Corleone… Anch’io ho dato un piccolo contributo a voi in
quel lavoro, e non posso che affermare che è un’ottima
norma che forse, come altre volte mi è venuto di dire, ha
alzato molto il bersaglio senza però regolare
il tiro. Gli operatori penitenziari, l’amministrazione
penitenziaria è restata, malgrado il crescere qualitativo
della norma, assolutamente – scusatemi l’affermazione un
po’ rude – assolutamente autoreferenziale. Io penso che
l’amministrazione si sia attestata troppo spesso su un
burocratese autoreferenziale che è stato sempre motivato,
anche correttamente, da una situazione d’impasse
generalizzata dovuta a quella sovrappopolazione
penitenziaria che ben conosciamo, nell’agosto 2006
c’erano 64 mila detenuti e 48 mila in misure alternative e
forse allora la motivazione degli operatori a non poter fare
era giustificata in parte.
Dopo
l’indulto noi abbiamo una nuova scommessa, quella di
riprendere in mano l’ordinamento, di riprendere in mano
quelle competenze così chiaramente distinte e indicate
nell’ordinamento, e che fanno capo sia al paradigma
retributivo che a quello trattamentale che a quello
riparativo. E tutti insieme dobbiamo ripercorrere secondo me
l’ordinamento, rileggerlo, io credo che al di là di
tantissima formazione che l’amministrazione ha dato in
questi trent’anni troppo spesso si è parlato di
managerialità e troppo poco di ordinamento penitenziario.
Quindi io credo che bisogna cominciare da questo,
l’indulto ci dà la possibilità non di fermarci e poi
adattarci a non fare, ma di riprendere fiato e riconsiderare
– e saremmo molto colpevoli come amministrazione se
perdessimo questa scommessa. Io sono fondamentalmente
un’ottimista, credo che bisogna e si può cambiare,
bisogna realizzare quella norma che definisco quasi
perfetta, e che ahimè per colpa di tutta una serie di
motivazioni invece non ha trovato compimento. Credo che
possiamo dire che l’amministrazione penitenziaria ha
assunto un atteggiamento reattivo, ci siamo posti in una
posizione difensiva, dove abbiamo portato come titolo per il
nostro non poter fare tutta una serie di motivazioni che poi
in effetti non trovano poi un fondamento assoluto.
Io
credo che una delle cose fondamentali in questi trent’anni
della riforma sia il fatto che si sono persi i significati.
Si è perso il significato di quello che è il dettato
normativo, si è perso il significato, al di là dei momenti
celebrativi, di quello che significa effettivamente diritto
del detenuto al trattamento, diritto ben chiarito anche
dalla nota sentenza della Cassazione, si è perso quasi
subito il significato di individualizzazione del
trattamento, come ho più volte scritto anche nelle
circolari emanate dal 2003 in poi. Ormai purtroppo nella
larga parte degli istituti penitenziari sul territorio
nazionale si intrattiene il detenuto, non si tratta. E la
differenza fra intrattenimento e trattamento passa
attraverso un concetto di individualizzazione così ben
definito dalla norma a cui non abbiamo saputo dare una
giusta collocazione, e che per me è strettamente legato a
un concetto di responsabilizzazione del detenuto rispetto a
un suo percorso di cambiamento. Questo significa che troppe
volte noi abbiamo assecondato la passività del detenuto, in
una sorta di buonismo certe volte, in una sorta di
sentimento di non essere adeguati a rispondere a questo
compito, ma troppo spesso abbiamo lasciato il detenuto
assolutamente passivo a rispondere a dei rituali
penitenziari che spesse volte sono anche irragionevoli.
Un
esempio per tutti: se trattamento significa lasciare che i
detenuti stiano nelle loro celle in pigiama la mattina,
secondo me è già un segno di quello che non sappiamo fare.
Già trattamento potrebbe essere sfidare il detenuto ad
assumere su di sé la propria capacità, la propria dignità
e veramente prendere in mano la sua vita, partendo da queste
piccole cose. E su queste piccole cose, io ho detto tante
volte alla polizia penitenziaria, s’incontrano
inevitabilmente questi due aspetti che abbiamo voluto
allontanare nelle dichiarazioni ideologiche o quant’altro,
della sicurezza e del trattamento. Perché quale polizia
penitenziaria si può sentire adeguata se fa solo mera
custodia, se non prende in mano quella che è una capacità
che peraltro è sancita anche dalle nuove norme che
riguardano le competenze della polizia penitenziaria, anche
nell’ambito del trattamento? Quindi c’è questa perdita
di significato, dobbiamo ritrovare il significato della
norma nella nostra quotidianità operativa, dobbiamo cercare
più che l’apparenza i risultati.
Noi
dobbiamo cercare di incentivare dei processi valutativi seri
che dimostrino alla comunità che la pena, sia essa
detentiva sia soprattutto misure alternative, con la
gradualità che la legge ha così ben definito, può
produrre un risultato, ma lo può produrre non solo sulle
spalle degli operatori penitenziari, lo può produrre
soltanto se andiamo a realizzare quello che veniva così ben
sintetizzato dal nostro ospite straniero in quel grafico con
la rete di collegamento fra i vari soggetti istituzionali,
la forte sinergia tra politica penitenziaria e politica
sociale. Bisogna sviluppare in ambito regionale una politica
penitenziaria chiara, riunendo la frammentazione fra i vari
istituti e servizi in un unico linguaggio politico da
coniugare con quello della Regione. Bisogna veramente fare
insieme politica penitenziaria e politica sociale, non
possiamo scoprire il problema dell’ex detenuto, di chi
esce dal carcere soltanto quando c’è l’indulto. Se è
vero che sono uscite venti, trentamila persone con
l’indulto, ci dimentichiamo che ogni anno escono dal
carcere circa 48 mila persone, una al giorno, due al giorno,
ma escono dal carcere e nessuno se ne occupa. Quindi
dovremmo riattivare il famoso art. 43, dovremmo riattivare
tutta una serie di modelli operativi che siano validi, che
siano efficaci.
Ecco,
io credo che da fare ne abbiamo tanto, anche senza cambiare
niente della legge. Quindi trattamento e non
intrattenimento, un richiamo forte agli operatori a mettersi
in una posizione pro-attiva per fare in modo che anche i
detenuti si mettano in una posizione pro-attiva. Un discorso
poi abbastanza importante sulle misure alternative. Un mondo
a me particolarmente caro perché l’ho diretto per dieci
anni e quindi non posso fare finta di non conoscere, di non
prenderlo sul serio nelle sue defaillances, nei suoi limiti.
Le misure alternative hanno segnato il passo vuoi per
mancanza di strumenti di strutture, questione ancor oggi
peraltro sottovalutata forse, il problema è al di fuori
degli operatori, è quello della massificazione degli
istituti giuridici che si riferiscono al sistema penale
esterno. Oggi come oggi se parliamo di affidamento,
detenzione domiciliare, semilibertà, art. 21, sembra quasi
che siano le stesse cose, e non solo nell’immaginario
collettivo ma ahimè anche negli operatori e ahimè anche
nell’amministrazione di sorveglianza. Quindi bisognerebbe
ridare a ciascun istituto giuridico la sua peculiarità e
ricostruire un sistema di gradualità.
L’ultima
cosa su cui mi chiamava a parlare il moderatore, la
mediazione. Lascio lo spazio all’amico Marinari per la
presentazione della tematica che lui certamente ben
rappresenterà, io come presidente della commissione
mediazione penale e giustizia riparativa, che ancor oggi è
in piedi presso il Dipartimento, sto lavorando su questa
tematica, quindi semmai nel dibattito potrò aggiungere
alcuni aspetti di interesse operativo per
l’amministrazione nostra, ma voglio anticiparvi che io sto
lavorando abbastanza su due fronti. Quella della vittima, di
cui abbiamo ampiamente parlato. La vittima in Italia non
esiste, non ha soggettività, non ha voce se non davanti ai
microfoni dei media che assillano e cristallizzano la
sofferenza e l’emozione dell’impatto del crimine o nei
momenti di ritorno emotivo nelle varie fasi del giudizio. La
vittima però non può oggi ritrovare significato in Italia
solo perché un reo vuole riparare. Su questa affermazione
molto assiomatica io sto lavorando e con il prof. Manconi il
nostro sottosegretario e anche col capo dipartimento perché
o l’Italia recepisce, crea norme e regolamenti di tutela
della vittima accogliendo la risoluzione del 2006 che
definisce con molta chiarezza quali sono i diritti della
vittima, oppure in effetti noi non possiamo fare quasi
nulla.
Oggi
esistono soltanto leggi di settore, la legge sulle vittime
della criminalità mafiosa o dell’usura, ma sono tutte
leggi che si riferiscono a dimensioni di monetizzazione del
danno, ma che non collocano la vittima quale soggetto che
abbia una voce, che abbia diritto all’informazione,
diritto di essere ascoltata, diritto di trovare un sostegno
economico e psicologico, direi anche un diritto a ricevere
un’offerta di mediazione. Se noi non creiamo questo
percorso di soggettività della vittima noi faremo un gran
danno alla vittima e provocheremo una vittimizzazione
secondaria secondo me estremamente grave. Quindi su questo
sto lavorando e spero – anche col Garante, perché ci sono
anche problemi di tutela della privacy della vittima, che
non si può andare a chiamare solo in virtù del fatto che
un reo vuole riparare. Bisogna ricorrere a forme di
riparazione indiretta – ce lo dirà il relatore dell’Ispac
– e altre forme indirette, dove non si prevede il consenso
o la presenza della vittima.
Altro
aspetto su cui sto lavorando è quello di sperimentare
modelli nuovi di giustizia riparativa e mediazione penale e
sociale, intendendo necessario, per questo percorso di
garanzia e di costruzione della soggettività della vittima,
costruire dei luoghi dove la riparazione e la mediazione può
essere fatta, nell’ambito di quei criteri e di quei
quesiti che i documenti internazionali chiaramente
espongono.
-
Maria Pia Giuffrida
-
|