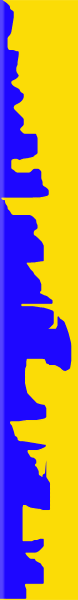|
Premessa
L’approvazione
dell’indulto rappresenta un’occasione storica, unica e
irripetibile per una radicale riforma del carcere, per
ripensare il senso della pena, per una giustizia fondata sul
diritto e sulle garanzie.
L’indulto era
una misura dovuta, non solo per ragioni di giustizia, umanità
ed equità ma soprattutto perché nelle carceri regnava un
regime di illegalità con la violazione costante del
Regolamento di esecuzione dell’Ordinamento penitenziario
che dal 2000 restava (e resta) inapplicato, calpestando così
i diritti dei detenuti. Il 2006 era iniziato con
l’approvazione della legge 21 febbraio 2006 n. 49,
contenente profonde modifiche al Dpr. 309 del 1990 sulla
disciplina degli stupefacenti, nota come legge
Fini-Giovanardi e dal carattere fortemente repressivo e
proibizionista.
L’applicazione
di questa legge assieme alla legge sull’immigrazione, la
Bossi-Fini, faceva prevedere un aumento del numero dei
detenuti oltre ogni limite di sopportabilità.
A fine luglio
invece il Parlamento ha votato con l’80% dei voti
favorevoli un provvedimento di indulto, determinando
l’uscita immediata dalle carceri di 23.580 detenuti,
portando le presenze da 62.000 ospiti a circa 38.000.
L’ultimo
provvedimento di clemenza risaliva al 1990 e pochi avrebbero
scommesso su una decisione positiva del Parlamento
soprattutto tenendo conto della maggioranza qualificata
prevista dalla Costituzione, dopo tanti accorati e
autorevoli appelli che avevano diffuso nelle carceri
italiane, prima speranze ed entusiasmi, a cui erano
subentrate disillusioni e frustrazioni.
Purtroppo una
ondata violenta di falsità e di disinformazione ha
accompagnato la decisione del Parlamento e la campagna
mediatica in nome della sicurezza e della certezza della
pena ha per mesi impedito un ragionamento sulle misure
indispensabili e urgenti perché l’indulto non si
risolvesse in un sogno di mezza estate. Così invece
di riflettere sulle molte questioni che l’indulto ha
disvelato, si insiste ad attribuire a una misura che pare
orfana di padri e madri, la responsabilità di tragedie
tremende: l’ esempio più eclatante è stato offerto dalla
strage di Erba attribuita a un “immigrato, tunisino,
uscito grazie all’indulto”. Così, senza vergogna,
strillavano i titoli dei giornali e delle televisioni.
Che cosa ci ha
detto l’indulto?
Prima di tutto ha
messo in luce una applicazione ridotta delle misure
alternative da parte di una magistratura di sorveglianza
troppo accorta e prudente: infatti molti dei detenuti
definitivi usciti grazie all’indulto erano nei termini per
usufruire di programmi di accompagnamento al ritorno in
società, ma stavano a marcire ammassati negli istituti di
pena. Troppe lacrime di coccodrillo sono state versate per
l’abbandono in cui si sarebbero trovati d’improvviso i
detenuti!
In secondo luogo
l’indulto ha reso evidente che chi esce dal carcere è
solo con il suo sacco di plastica nera dell’immondizia
perché il welfare non ha risorse per gli ultimi o ha altre
priorità.
Infine
l’indulto ha denunciato la presenza
di una detenzione sociale di massa costituita da
immigrati colpevoli solo di non essersi allontanati
dall’Italia, da tossicodipendenti che non dovrebbero né
entrare né stare in carcere, da poveri che la società
opulenta riduce ad avanzi di galera.
Quante
riflessioni avrebbe dovuto produrre questa vicenda invece
del tormentone sulla sicurezza delle nostre città! Tema che
certo esiste ed ha uno spessore pieno di sofferenza, di
paura per troppi cittadini, soprattutto i più deboli, ma
che deriva dallo stato delle periferie urbane, dalla
esclusione sociale, dalla violenza diffusa, dalla volgarità
massiccia e da un imbarbarimento della società, insomma da
condizioni della convivenza delle nostre città che non può
essere semplicisticamente attribuita al ritorno nella società
dei “sani”, anticipato di sei mesi o di un anno, di
alcune migliaia di “devianti”.
E per finire:
i numeri dei rientri in carcere per recidiva
immediata, in alcuni casi per pura disperazione, dimostrano
che pur in condizioni di difficoltà estrema, la generosità
dello stato è stata compresa e non è stata tradita,
infatti la percentuale dei recidivi si
è stabilizzata intorno al 10% dei fruitori
dell’indulto e pari
a poco più di
duemila persone. Il fatto che ancora oggi i detenuti non
abbiano superato la cifra dei quarantamila, può fare
sperare ancora che la partita non sia ineluttabilmente
perduta.
L’agenda degli
obiettivi riformatori da perseguire è scritta e condivisa:
per un esame coerente e non frammentario occorrerebbe una
sessione parlamentare ad hoc. Ovviamente si tratterebbe di
una via razionale e proprio per questo risulta
impraticabile.
Il nuovo codice
penale che sostituisca il codice Rocco del 1930 deve essere
assunto come priorità assoluta; se è vero che a fine
aprile la commissione Pisapia consegnerà al ministro
Mastella il proprio progetto, occorrerà richiedere una
legge delega per un esame del Parlamento che porti a una
svolta di civiltà.
Purtroppo dopo un
anno della nuova legislatura, le leggi criminogene sulla
recidiva, sull’immigrazione e sulle droghe non sono state
abrogate e continuano a produrre effetti nefasti che in
ultima analisi ricadono sul carcere e sulla composizione
della popolazione detenuta, realizzando una forma non
casuale di detenzione sociale.
Il sistema
penitenziario richiederebbe alcune misure che sono già
elaborate e in discussione da anni: il superamento degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari, uno specifico ordinamento
penitenziario per i minori, l’approvazione della legge
istitutiva del garante nazionale delle persone private della
libertà, il riconoscimento del diritto di voto per le
persone in esecuzione penale e per gli ex detenuti, il
riconoscimento dell’affettività come diritto per le
persone detenute.
Vi è poi il
campo sterminato della piena applicazione delle norme e
leggi esistenti a partire dalla salute in carcere, dal
lavoro, alla esclusione dal circuito carcerario dei bambini
figli di madri detenute, alla applicazione più estesa
possibile delle misure alternative. Infine occorrerebbe un
Piano per la realizzazione integrale del Regolamento del
2000 e contestualmente almeno iniziare la discussione della
proposta Margara di un nuovo testo dell’Ordinamento
Penitenziario. L’unica notizia confortante è la
prospettiva dell’istituzione della figura del Garante a
livello nazionale. Infatti la Camera dei Deputati ha
approvato il 4 aprile il testo unificato delle proposte
presentate da diversi gruppi parlamentari.
La mole del
lavoro è tale che il pessimismo della ragione può
sovrastare l’ottimismo della volontà eppure vi sono
momenti nella storia in cui si chiede la consapevolezza
della discontinuità. Oggi è il tempo della politica, delle
scelte e non solo della buona amministrazione. Non c’è da
conservare ma da cambiare.
L’obiettivo è
rovesciare l’imbarbarimento della cultura politica che si
è affermato in questi anni producendo un incattivimento
della società.
Le parole sono stanche
Nel dicembre del
2004 con la Fondazione Michelucci l’Ufficio del Garante di
Firenze organizzò un convegno dal titolo: “Del carcere:
solo questo sappiamo, ciò che non è, ciò che non
vogliamo”. Poteva apparire una sorta di denuncia di
impotenza, di fragilità, di resa alla dura replica dei
fatti rispetto al sogno, all’utopia del cambiamento.
Così non era.
L’allusione del titolo ai versi di Eugenio Montale voleva
certo esplicitare la consunzione che tante parole utilizzate
per descrivere la realtà del carcere hanno subito:
discarica sociale, deposito di corpi, contenitore di ferite
sociali, imbuto classista dell’amministrazione della
giustizia. La consapevolezza del fallimento di tante ipotesi
di cambiare radicalmente un’istituzione totale che quasi
naturalmente si caratterizza come luogo di potere e in cui
il detenuto è il soggetto più debole, impone la necessità
di una riflessione teorica che incida sul senso profondo
della pena.
Il
carcere malato ha bisogno cioè di un progetto complessivo
che faccia i conti con le tendenze, i valori, le paure e le
speranze della società. La lettura disincantata del carcere
come è, ci può far capire meglio di tanti saggi, le
pulsioni che emergono nel corpo della società, la voglia di
vendetta, le risposte orientate alla tolleranza zero.
L’aumento del numero dei detenuti non risponde a un
aumento della criminalità e dei delitti, ma a un
atteggiamento che forse inconsapevolmente vuole ridefinire i
confini delle due città, quella dei sani da quella dei
malati, quella dei giusti e dei normali da quella dei
criminali e dei devianti.
Chi è destinato al carcere
Basta
un’analisi anche superficiale della composizione sociale
dei detenuti presenti in un giorno dell’anno per avere la
rappresentazione plastica, o meglio in carne e ossa, dei
rifiuti umani della nostra società.
Tossicodipendenti
e immigrati costituiscono la grande maggioranza degli ospiti
delle patrie galere. Addirittura si può stimare che per
reati direttamente o indirettamente riconducibili alla legge
sugli stupefacenti sia coinvolta la metà dei detenuti. Ecco
il primo di una lunga serie di paradossi: una sola legge
delle almeno cinquantamila in vigore nel nostro ordinamento
determina la gran parte delle carcerazioni e una detenzione
fuori misura e spropositata, oltre che inutile e iniqua. Per
un esame dettagliato dei dati, rinvio alla mia Introduzione
al volume Marijuana I miti e i fatti di
Zimmer e Morgan edito da Vallecchi.
A parole tutti si dicono
d’accordo con il principio che il carcere debba essere
l’extrema ratio,
ma per alcuni se ne propone una vera overdose.
La
scommessa di un carcere trasparente e come luogo di
sperimentazione sociale va giocata senza fermarsi alle
differenziazioni di regime giuridico e trattamentale
previste per le aree di massima e alta sicurezza, e
soprattutto rifiutando la logica del contenitore della
devianza e dell’emarginazione.
L’istituzione
della figura del Garante per i diritti delle persone private
della libertà personale, uno specifico Ombudsman,
deve avere il segno non certamente della normalizzazione, ma
della felice ambiguità.
Non è fuoriluogo
cercare di inserire la discussione sul ruolo del Garante dei
diritti dei detenuti in un quadro concettuale chiaro e non
equivoco.
Il carcere ipertrofico e
criminogeno
Lavorare per garantire i
diritti presuppone la contestazione esplicita
dell’ipertrofia del sistema penale e il rifiuto del
dominio dello “stato penale” rispetto allo “stato
sociale”. Deve ad esempio essere chiaro cioè che la
denuncia del sovraffollamento ha un valore
politico-culturale e che deve tendere a un minore ricorso
alla detenzione e non alla costruzione di nuove carceri,
magari privatizzate.
Non si può dare
neppure per un momento l’impressione di essere disponibili
a farsi rinchiudere nel recinto della buona amministrazione,
delle compatibilità o delle buone intenzioni: il carcere
deve accettare la sfida di essere un laboratorio di
sperimentazione di forme inedite di Stato sociale. Il lavoro
positivo di tanti operatori e del volontariato non
reggerebbe senza affondare in una visione complessiva del
mondo. Risulterebbe davvero impraticabile un riformismo
senza riforme.
In tempi di
guerra e di terrorismo, di conflitti di civiltà e di
opposti fondamentalismi, di limitazioni di libertà e di
maggiori controlli sulla vita dei cittadini, può apparire
paradossale invocare e agire per i diritti dei detenuti. Ma
la Storia per fortuna non ha sempre direzioni univoche e
permette strade alternative e sentieri impervi.
Diritti e loro esigibilità
Quali sono dunque
i diritti di cui parliamo? Norberto Bobbio nel suo libro
“L’età dei diritti” ricorda che Kant aveva ridotti i
diritti innati a uno solo: la libertà. Come si può allora
parlare di diritti per persone private proprio della libertà?
Credo
che l’affermazione dei diritti dell’uomo non possa
escludere nessuno, pena la sua intima contraddizione. Quindi
quando parliamo di diritti dei detenuti ci riferiamo
sicuramente ai diritti che vanno declinati in ordine alla
specificità della condizione (così come sono state
approvate Convenzioni internazionali per i diritti del
fanciullo, delle persone handicappate, del minorato mentale,
degli anziani). In primo luogo vanno affermati i diritti
classici, di voto, di espressione, di religione, ecc., ma a
maggior ragione vanno previsti i diritti sociali: diritto
allo studio, al lavoro e alla salute. Sono previsti dalla
nostra Costituzione come norme programmatiche per il divario
che esiste tra la norma e la sua effettiva applicazione. I
diritti sono tali perché esigibili, ciò richiede da parte
dello Stato (sociale) una attivazione particolare; verso i
detenuti si tratta di un intervento che richiede una priorità
assoluta perché sono alla base della condizione di
effettiva cittadinanza. Inoltre l’articolo 27 della
Costituzione laddove prescrive il carattere delle pene come
tendenti alla rieducazione del condannato, obbliga lo Stato
a garantire azioni positive per il reinserimento sociale a
vantaggio del singolo e della società.
Esistono infine
diritti specifici alla condizione di vita in carcere e a
titolo meramente esemplificativo e in ordine casuale ne cito
alcuni, la socialità, l’esercizio della propria
confessione religiosa, l’alimentazione, l’igiene
personale, le misure alternative, i colloqui e i permessi.
Questi diritti
sono scritti nelle leggi specifiche, nell’Ordinamento
Penitenziario e nel Regolamento approvato nel 2000; il
problema è che questo complesso di norme non rimanga chiuso
nei cassetti, inapplicato per inerzia burocratica o per
colpevole boicottaggio.
Il Garante, un
profeta disarmato, può ridare speranza di futuro a un mondo
senza parola e senza voce, troppo spesso illuso e deluso?
L’importanza del Garante
nazionale dei detenuti
Il testo
approvato dalla Camera dei Deputati, pur con alcuni limiti e
alcune reticenze, pone le basi di un potere reale attraverso
la visita senza autorizzazione degli istituti, la visione
dei fascicoli personali, la verifica della idoneità delle
strutture edilizie alla salvaguardia della dignità e al
rispetto dei diritti fondamentali, e infine, in concorso con
il magistrato di sorveglianza, vigila che la custodia sia
attuata in conformità delle norme e dei principi stabiliti
dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali sui
diritti umani ratificate dall’Italia, dalle leggi dello
Stato e dai regolamenti.
Sono
convinto che la figura del difensore civico non dovrà
limitarsi a un ruolo di controllo e di denuncia ma anche di
promozione, gettando un fascio di luce su quanto accade ma
soprattutto su quanto non accade nei penitenziari, troppo
spesso luoghi, desolatamente, del “non fare”.
E’ sotto gli
occhi di tutti la diffusione di una cultura securitaria e di
un clima di imbarbarimento della convivenza civile, e anche
per questo l’istituzione della figura di un Ombusdsman, apparirebbe in controtendenza, assolutamente positiva.
L’intollerabile
numero di suicidi in carcere dimostra una tragica
insostenibilità della situazione e, al di là
dell’aspetto non irrilevante dei poteri di questa nuova
figura, la sua presenza di per sé potrà costituire un
segno di sensibilizzazione della cosiddetta società civile
per un progetto di inclusione sociale che sconfigga la
logica della recidiva.
In attesa
dell’approvazione della legge istitutiva nazionale, si
sono diffuse le nomine di garanti cittadini e regionali.
Questo processo dal basso ha una valenza fondamentale di
legame con il territorio respingendo quella visione che
vuole cancellare il carcere dalla vita della città.
L’accoglienza,
la solidarietà, l’umanizzazione della pena devono essere
affermate non come istanze buoniste, ma come diritti
esigibili nella consapevolezza che la legalità anche in
carcere è un valore da affermare con ancora maggiore
intransigenza.
Il
carcere, luogo di rimozione per eccellenza, subisce spesso
il peso della cappa dell’indifferenza: il dolore, le urla,
il sangue che innumerevoli atti di autolesionismo
testimoniano, rimangono confinati al di là dei muri, gli
ultimi esistenti, insuperabili e non destinati a un
abbattimento liberatorio.
Ad affrontare il
problema, scriveva Sofri, occorrerebbe un pazzo, o un santo:
un santo pazzo, piuttosto, capace di metterci la propria
vita, e di restare solo, senza rispetti umani e senza
partiti presi.
In questi anni, i
rapporti del Comitato europeo contro la tortura, i rapporti
di Antigone, l’Annuario Sociale e il Rapporto annuale sui
diritti globali hanno gettato una qualche luce fornendo
molti dati sulle carceri italiane, ma ancora ritengo sarebbe
utile riprendere la proposta del Ministero della Giustizia,
poi incomprensibilmente abbandonata, di un’indagine sullo
stato delle prigioni italiane e del sistema penitenziario.
“Un’inchiesta sulle carceri potrebbe dire sullo stato
presente e futuro dell’Italia cose terribili e
preziose”, così commentava Adriano Sofri nella prefazione
a Giustizia senza fine,
per poi concludere: “Si
capisce che metter mano a un sistema giunto a questo, sia
impresa che fa tremare; e che vinca la Normale
Amministrazione. Anche chiudere i Giardini Zoologici
sembrava sbagliato a molti, impossibile a quasi tutti. Dove
li mettiamo poi i coccodrilli, e i tossicodipendenti?”
Occorre ripensare i fondamenti
stessi della reclusione
A conclusione di
questa analisi, vorrei proporre questa riflessione: “I
modelli sanzionatori non devono ritenere scontate le modalità
di risposta al reato fondate semplicemente sulla ritorsione,
sulla pena fine a se stessa, sull’emarginazione. E’ il
tema del superamento della centralità del carcere nell’ambito penale.
Bisogna fare di tutto perché il carcere sia luogo di forte
e austera risocializzazione, con programmi chiari e
controllati, con l’impegno di persone motivate e con
incentivi atti a promuovere tali processi. Appare oggi più
evidente l’inadeguatezza di misure repressive o punitive
che un tempo la società non poneva in questione. E’
quindi necessario ripensare la stessa situazione carceraria
nei suoi fondamenti e nelle sue finalità, proprio a partire
dalle attuali contraddizioni”. Sono parole scritte dal
cardinale Martini nel suo libro Sulla
Giustizia: parole quasi rivoluzionarie per questo Paese,
in cui, nella pratica se non nella teoria, si continua ad
attribuire una centralità - spesso impropria, sovente
nefasta - alla pena reclusiva. All’opposto, il nostro
sistema dovrà articolare un metodo delle pene che non abbia
solo la pena della privazione della libertà per un certo
tempo, ma delle pene, o meglio alternative alle pene, che
mettano immediatamente, nel momento del giudizio, la persona
in rapporto alla società. Una previsione cioè di attività
e comportamenti credibili, efficaci, di riparazione del
danno in funzione di reintegrazione sociale, di rapporto con
la vittima dal punto di vista della possibile
riconciliazione.
Perché sia
possibile una forte e austera risocializzazione, come la
definisce il cardinale Martini, essa dovrebbe far leva sulla
responsabilità personale dei detenuti. Invece, come
denuncia Sofri nel volumetto A
doppia mandata, “Il carcere mira, con una metodicità
accanita, al contrario. Ogni piccolo gesto dell’esistenza
quotidiana è espropriato di senso e di libertà, tallonato
da riti assurdi e umilianti, regolato da norme che
suonerebbero infantili in un asilo infantile”. L’infantilizzazione
deriva anche dalla composizione della popolazione detenuta;
la maggior parte dei detenuti si trova in galera per fatti
che riguardano la droga. A questo proposito impietosamente
Sofri così descrive la situazione: “Ed è per antonomasia
una ragione di irresponsabilità, di vittimismo e di
autodistruzione, di disposizione furbesca e lamentosa a
usare gli altri come strumenti. L’ovvietà che descrive la
tossicodipendenza come una malattia offre ai
tossicodipendenti un pretesto all’auto commiserazione e
alla deresponsabilizzazione”. Il primo compito è quindi
quello di esaltare la responsabilità, la stima di sé, del
proprio sapere e della propria esperienza, insomma della
vita passata e futura, a cominciare anche dalla riscrittura
del vocabolario carcerario stretto tra gergo burocratico e
parole insopportabilmente infantili e offensivamente servili
(il riferimento alla “domandina” è di per sé
eloquente).
Può apparire un
paradosso che il carcere da luogo della separazione dalla
società dei condannati, riacquisti il senso della sfida per
il reinserimento sociale, per abbattere l’esclusione
sociale. In questi ultimi tempi si è risvegliato uno
spirito forcaiolo che, strumentalizzando il dolore delle
vittime e delle
famiglie, ha proposto una sorta di riduzione al silenzio per
gli ex terroristi e un destino di morte civile per colpe
ritenute non espiabili. Siamo di fronte a un imbarbarimento
che risulta incomprensibile dopo venti anni dalla legge
Gozzini e dalla legge sulla dissociazione. Questa ventata
giustizialista riduce lo spazio della politica e del
dialogo. Proprio per questo, contro “il fine pena mai”,
occorre trovare un filo di umanità. Per farlo occorre,
certo, cambiare il senso comune, con tutta la pazienza che
ciò comporta. Ma anche sollecitare le istituzioni e la
politica a fare la loro parte, a rinunciare al pericoloso
gioco di alimentare derive giustizialiste. Ad esempio,
abbiamo recentemente proposto una sessione parlamentare sui
problemi dei carcere e della giustizia, come presa d’atto
dell’urgenza di una serie di problematiche, come segnale
di presa in carico, di una volontà di cambio di rotta, di
affrontamento strutturale e di una doverosa attenzione.
All’opposto, abbiamo trovato perlopiù distrazione e
indifferenza. Un segno dei tempi e, al tempo stesso, un
preoccupante segnale dell’assoluta mancanza di un progetto
sulla giustizia, di una politica che ha perso l’anima. E
senza anima e senza progetto si può al massimo navigare a
vista. Col rischio, però, di portare la nave sugli scogli.
-
Franco Corleone
-
|