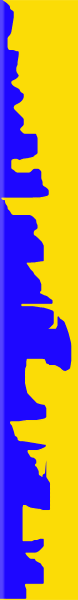Bullismo
e intolleranza s’intrecciano nel caso di un alunno di
terza elementare, irriso e picchiato perché sua madre è
napoletana – Ci si chiede dove questi persecutori
abbiano assimilato il germe dell’odio nei confronti del
diverso -
La gravissima responsabilità delle famiglie e
della politica– L’episodio richiama un tragico
precedente, quello del ragazzo indiano adottato da una
famiglia fiorentina che fu indotto al suicidio dalle
canzonature per il colore della pelle
Parliamoci chiaro: se un gruppo di alunni di terza
elementare isola un compagno che ha di diverso soltanto la
provenienza della madre, napoletana, lo sbeffeggia
chiamandolo “monnezza” e lo picchia, sembra evidente che
la responsabilità va cercata nei contesti ambientali e
familiari. L’incredibile episodio è accaduto in una
scuola di Loria, nei pressi di Castelfranco Veneto, ne ha
parlato il sito web della Tribuna di Treviso. È
stata proprio la madre a scoprire la vicenda, leggendo sul
diario del suo bambino una frase che rivela un abisso di
disperazione: “se mi mandi ancora in quella scuola mi
uccido”. Naturalmente la minaccia non è stata
sottovalutata: il piccolo frequenta ora un altro istituto in
una provincia vicina. E speriamo che lì lo lascino in pace.
La Tribuna di Treviso c’informa che il sindaco di
Loria si è pubblicamente e civilmente scusato, a nome di
tutti i cittadini, con la famiglia del bambino.
Lasciateci immaginare le circostanze in cui la vicenda
è maturata. Il termine “monnezza”, associato a Napoli,
significa che a quel bambino di otto anni veniva
implicitamente rinfacciata la colpa dello scandalo della
spazzatura ammucchiata nelle strade della metropoli
meridionale e della regione circostante. Uno scandalo che
come si sa ha fatto il giro del mondo attraverso la
copertura televisiva, una vergogna che attende una soluzione
giudiziaria ma anche politica, un esempio di cattiva
amministrazione sullo sfondo di torbidi interessi criminali.
I piccoli della terza elementare di Loria devono avere
assorbito nelle rispettive case una sbrigativa
interpretazione popolare di questa emergenza: napoletani
uguale “monnezza”, dunque alla larga.
Non è nuovo, nelle frange meno evolute della società
italiana, un atteggiamento che riduce semplicisticamente i
grandi problemi sociali alla dimensione personale. A Napoli
non si ripuliscono le strade e la spazzatura ammorba
l’atmosfera? Vuol dire che i napoletani sono sporchi,
brutti e cattivi: bisogna dare una lezione a quella gente.
Giusto, una lezione: ecco la conclusione degli adulti
riproposta sulla scala infantile. C’è a portata di mano
un piccolo indifeso compagno di classe, eccolo etichettato
con il nome infamante dello scandalo, eccolo perseguitato e
percosso, eccolo confidare al suo diario disperati propositi
di suicidio.
Il problema riguarda anche altri, in questa stagione
storica di grandi migrazioni riguarda soprattutto gli
stranieri. Le comunità immigrate portano con sé una
partecipazione massiccia, dunque giustamente preoccupante,
alle statistiche della criminalità? E allora isoliamo il
rumeno, l’albanese, l’arabo, e soprattutto non
permettiamo ai loro bambini, anche loro sporchi, brutti e
cattivi, d’insudiciare i nostri. Non permettiamo che
pretendano di sedere agli stessi banchi di scuola, di
ottenere le stesse attenzioni, la stessa formazione.
Altrimenti finiranno fra qualche generazione con il
rinchiuderci nelle riserve, come è stato fatto con gli
indiani d’America: quest’ultima forsennata
considerazione ha campeggiato nelle piazze italiane durante
la recente campagna elettorale, era una normale propaganda
politica dei nostri tempi, di un normale partito politico
che miete vasti consensi e fra l’altro si vanta di
difendere le nostre “radici cristiane”. Lasciando da
parte, a quanto pare, quel cristianissimo precetto che
impone di amare il prossimo.
L’episodio di Loria richiama alla memoria un tragico
precedente di alcuni anni or sono. Ce ne occupammo nel
numero del Foglio Lapis del maggio 2002 (http://www.fogliolapis.it/maggio2002-2.htm):
era la storia di Anthony, un ragazzo indiano adottato a otto
anni da una famiglia italiana e inserito nel nostro sistema
scolastico. Dopo altri otto anni, frequentava a Firenze un
istituto tecnico agrario, e una mattina di primavera si
uccise stringendosi un cappio attorno al collo. Anthony era
un ragazzo intelligente, lo dimostra la lettera con cui si
accomiatò dalla vita. Distingueva nettamente fra
l’esperienza familiare (“quando rientravo a casa ero il
ragazzo più felice del mondo”) e quella ambientale:
“ogni volta che uscivo di casa la gente non faceva altro
che insultarmi per il colore della mia pelle e mi sentivo un
verme”.
E la scuola? C’era stato un incidente, all’inizio
dell’anno scolastico: un compagno aveva alluso proprio al
colore della sua pelle e Anthony aveva reagito scagliandosi
contro di lui. Poi c’era stata un’assemblea di classe
per esaminare il caso e tutto era andato a posto: era solo
una battuta e non m’importa delle battute, aveva detto.
Una stretta di mano aveva chiuso il caso. Ma evidentemente
c’era dell’altro: dicono che il suo profitto era
discreto ma non gli bastava, sentiva che la sua condizione
gl’imponeva di dare di più. E forse non ce la faceva.
Anche lui, come quel bambino di terza elementare, aveva
minacciato il suicidio: ma non l’avevano preso sul serio.
Meno male che hanno preso sul serio il piccolo emulo
potenziale di Castelfranco Veneto.
-
Alfredo Venturi
-
|